Descrizione
1.
George Edward Stanhope Molyneux Herbert, visconte Porchester, soprannominato “Porchey” dai suoi pochi intimi e ritenuto dagli invidiosi il futuro Lord Carnarvon, piantò un cazzotto in faccia al marinaio greco che si rifiutava di obbedire ai suoi ordini. A bordo del suo yacht, l’Aphrodite, era signore e padrone e non ammetteva che gli si mettessero i bastoni tra le ruote, anche se una violenta tempesta diffondeva il panico tra l’equipaggio.
Il greco si rialzò stordito.
“Il suo cuoco è fottuto, farebbe meglio a reggere il timone.”
“Un attacco di appendicite non è una condanna a morte. E tu dovresti sapere, amico mio, che Afrodite è una dea del mare, ed è a lei che affido battello ed equipaggio durante l’operazione.”
Indifferente all’incredulità del marinaio, Porchey discese nella sua cabina, dove fece portare il malato; teneva molto a quel cuoco brasiliano che aveva assoldato in occasione del suo ultimo giro del mondo.
L’uomo si torceva in preda ai dolori.
Sul ponte, gran parte dei marinai si erano gettati in ginocchio a pregare dio. Porchey detestava esibizioni del genere, tipiche di mancanza di autocontrollo. Quando aveva imparato a navigare nel Mediterraneo, di fronte alla villa che suo padre possedeva a Portofino, il visconte Porchester non aveva mai invocato l’Onnipotente: o ce la faceva da solo, o sarebbe annegato, senza dar fastidio a una celeste assemblea che aveva cose ben più importanti a cui badare che non prestare assistenza a un velista in difficoltà.
Fece ingollare al cuoco mezza bottiglia di un ottimo whisky, poi si sedette al pianoforte e suonò le Invenzioni a due voci di Johann Sebastian Bach. L’effetto dell’alcol e della musica rasserenante tranquillizzò il paziente; se non fosse sopravvissuto, sarebbe trapassato provando estreme sensazioni di alta qualità.
Prima di morire, la madre di Porchey aveva preteso da lui che, conformemente all’educazione impartitagli al castello di Highclere, non esperisse né udisse nulla che fosse banale o di bassa lega. Preparandosi ad aprire il ventre di un brasiliano che doveva avere sulla coscienza un paio di delitti, il visconte chiese perdono ai mani della sua genitrice.
Il malato, gli occhi ardenti di febbre, osò fargli una domanda.
“Lei… Lei ha già eseguito operazioni?”
“Almeno una dozzina di volte, amico mio, e sempre riuscite. Distenditi e tutto andrà per il meglio.”
Accanito lettore, Porchey, che parlava l’inglese del Trinity College di Cambridge, oltre al tedesco, al francese, al greco, al latino, e biascicava alcuni rari idiomi del bacino mediterraneo, aveva effettivamente letto manuali di chirurgia e aveva ripetuto mentalmente un’operazione di appendicectomia, incubo dei naviganti impegnati in lunghi tragitti. Ecco perché si era munito di uno strumentario chirurgico degno di un professionista.
“Chiudi gli occhi e pensa a un buon pasto e a una bella donna.”
Un sorriso forzato schiuse le labbra del cuoco, e Porchey approfittò di quell’istante di debolezza e lo fece svenire con un colpo di mazzuolo sulla nuca. Qualche rissa in cui era stato coinvolto nei bar malfamati di Capo Verde e delle Antille gli aveva insegnato a perfezionare quella tecnica di anestesia.
Con mano ferma procedette all’operazione, ripensando a quell’epidemia di morbillo che per poco non l’aveva spacciato; il rimedio era consistito nello spruzzarlo di acqua gelida per far calare la temperatura. Non che a Eton il trattamento fosse stato migliore; fin dai primi istanti il visconte aveva odiato i professori presuntuosi, otri pieni di un sapere inutile. Studiava a modo suo e col proprio ritmo, indifferente a voti e punizioni, ed era questo il motivo per cui veniva definito pigro, mentre era dotato di una formidabile capacità di concentrazione e di assoluta indipendenza di pensiero.
Collezionista di francobolli, di tazze di porcellana, di incisioni francesi e di serpenti sotto spirito, la lettura dei classici, si trattasse di quel blaterone di Demostene, di quel guastafeste di Seneca o di quel pallone gonfiato di Cicerone, era per lui fonte di profonda noia. Al Trinity College aveva tuttavia scoperto un’occupazione appassionante: restaurare a proprie spese le boiseries. Il direttore, scandalizzato, si era lamentato con suo padre per l’atteggiamento intollerabile di un membro dell’antica aristocrazia terriera, custode dei valori e della tradizione che Porchey calpestava allegramente.
Al giovane nobile, grande sportivo, non restava che percorrere il mondo, scoprire l’Africa australe, l’Australia e il Giappone, passare da un continente all’altro alla ricerca di un ideale che incessantemente gli sfuggiva. Quando l’esistenza che conduceva gli sembrava troppo scialba, si sprofondava nei libri di storia: si sentiva attratto dall’antichità per quel suo innato amore del grandioso tanto antitetico alla mentalità piccoloborghese nella quale scivolava l’Europa. Era affascinato dall’Egitto. Forse che l’Egitto non aveva trasceso l’uomo integrandolo nel colossale e costruendo templi a misura dell’universo? Eppure aveva evitato la terra dei faraoni, quasi che un timore reverenziale, in lui così raro, gli impedisse di metter piede in terra incognita.
Il visconte considerò tutto soddisfatto la propria opera.
“Niente male, proprio niente male. Non giurerei che se la caverà, ma il manuale era esatto. Proprio vero, niente vale un buon libro.”
Era vicina l’ora di cena. Il visconte si cambiò d’abito, scegliendo una giacca candida e pantaloni di flanella grigia; non dimenticò il berretto da capitano e risalì sul ponte, dove l’equipaggio continuava a pregare nella tempesta.
“Dio è buono,” constatò l’aristocratico. “L’Aphrodite è uscita indenne da questo piccolo temporale e nessuno è caduto in mare.” Parecchi marinai si precipitarono verso di lui.
“Calma, calma, signori. Per il momento il nostro cuoco è liberato da quella sua fastidiosa appendice; probabilmente non sarà in grado di preparare i pasti, e dovremo cavarcela alla meno peggio fino al prossimo scalo. Spero che l’incidente non vi impedisca di tornare ai vostri posti.”
L’erede dei Carnarvon si mise al timone dello yacht. Aveva un’aria fiera, la fronte alta e ampia, coronata da capelli quasi rossi, il naso di buona razza, i baffi cimati alla perfezione, il mento volitivo, il volto di un conquistatore in rotta verso l’infinito. Soltanto lui, Porchey, sapeva che l’immagine era ingannevole: avrebbe ben volentieri dilapidato una parte del proprio retaggio per dare un senso alla sua vita.
L’intelligenza, la cultura, la ricchezza, la possibilità di fare quel che voleva e come gli piaceva… E tutto questo non bastava a togliergli la sensazione di vuoto e inutilità.
Il greco urlò.
“Il cuoco è vivo! L’ho visto, ha aperto gli occhi!”
Il visconte alzò le spalle.
“Io ho una parola sola, mio caro. Non avevo promesso di salvarlo?”
2.
L’uomo stava a osservare da una mezz’ora il giovane Howard Carter. Elegante, l’aspetto distinto, aveva un volto severo e lo sguardo indagatore. Approfittando della bella giornata, Howard aveva piantato il suo cavalletto in un campo sul quale una giumenta allattava un puledro; il Norfolk godeva di un fine estate eccezionale e offriva infiniti soggetti pittorici. Il ragazzo, che aveva diciassette anni, seguiva le tracce paterne, al pari di lui voleva diventare un pittore animalista; anziché mandarlo alla scuola della città, il padre gli aveva insegnato a leggere, a scrivere, a disegnare e a dipingere; cavalli e cani erano i suoi principali motivi. Sebbene Howard avesse otto tra fratelli e sorelle, si sentiva figlio unico, il solo capace di far proprio il messaggio dell’artista: a lui il compito di perpetuare la schiatta e di dimostrare che poteva vivere della propria arte. Per questo lavorava con tenacia, accanendosi a perfezionare il minimo particolare. Sebbene fosse nato a Londra, nel quartiere di Kensington, il 9 maggio 1874, Howard Carter aveva trascorso l’infanzia a Swaffham, un piccolo villaggio di cui amava la verdeggiante tranquillità.
La sera prima si era verificata una sorta di miracolo: per la prima volta, uno dei suoi dipinti gli pareva quasi soddisfacente. Il cavallo caracollava, l’occhio era splendente, l’animale sembrava vivo; certo, le zampe erano eseguite grossolanamente e la testa aveva bisogno di ritocchi. Ma la mano si faceva sicura: il mestiere prendeva sostanza.
L’uomo colse un colchico, che si mise all’occhiello, e fece qualche passo verso l’adolescente che lo guardava senza abbassare gli occhi, disobbedendo ai principi della buona educazione. L’uomo continuò la lenta avanzata tra le erbe, indifferente al fatto di macchiare il suo bel completo di aristocratico, e si fermò davanti all’acquerello, che esaminò tendendo il collo come un uccello da preda.
“Interessante,” commentò. “Ti chiami Howard Carter, vero?”
Il ragazzo detestava i modi dei ricchi: tra loro, quanti salamelecchi per rivolgersi la parola! Con gli inferiori, invece, bastava impartire ordini con tono sprezzante.
“Non la conosco. Lei non vive al villaggio.”
“Visto che non c’è nessuno per presentarci, a parte quella bella cavalla in tutt’altre faccende affaccendata, sappi che mi chiamo Percy E. Newberry e che abbiamo un’amica comune. Vorresti avere la compiacenza di disegnarmi un’anatra?”
E porse un foglio di carta.
“Ma… Perché?”
“La nostra comune amica, Lady Amherst, mi ha parlato di te come di un ottimo pittore. Ha acquistato tre delle tue opere. La tua giumenta è abbastanza ben riuscita, ma un’anatra è tutt’altra faccenda.” Irritato, Howard prese il foglio e, in meno di cinque minuti, schizzò un’anatra selvatica di ottimo effetto.
“Lady Amherst aveva ragione; saresti disposto a disegnare e a colorare per me gatti, cani, oche e molti altri animali?”
La diffidenza del giovane artista non era scemata affatto.
“Lei è un collezionista?”
“Professore di egittologia all’università del Cairo, in Egitto.”
“È lontano, vero?”
“Molto lontano. Londra è già più vicina.”
“E perché Londra?”
“Perché la nostra bella capitale ospita il British Museum, e mi piacerebbe portarti con me.”
Il più grande museo del mondo… Suo padre gliene aveva parlato spesso. Chissà che un giorno una delle sue tele non vi venisse esposta!
“Non ho quattrini. Il viaggio, l’alloggio…”
“Non preoccuparti. Sei disposto ad abbandonare la famiglia e il tuo villaggio per un mese… per tre mesi?”
Rondini sfrecciavano nel cielo; al margine del bosco, un picchio verde martellava col becco la corteccia di una quercia. Lasciare il Norfolk, separarsi dai genitori, tagliare i ponti con l’infanzia… Howard rovesciò il cavalletto.
“Quando si parte?”
Parecchi mesi di ininterrotta fatica, chino sul tavolo a riprodurre geroglifici in cui comparivano non solo animali, ma anche esseri umani, oggetti, edifici, segni geometrici e tanti altri elementi di quel linguaggio che gli egizi ritenevano sacro: al pari di uno scriba, Howard Carter imparava a disegnarlo prima di comprenderlo, e tracciare quelle parole di potere trasformava la sua mano e il suo pensiero. Si atteneva scrupolosamente ai modelli che gli venivano forniti dal professor Newberry, e un po’ alla volta imparava a scrivere come scrivevano gli antichi.
Isolato in un ufficio, relegato in una stanzetta, non faceva lega con nessuno. Il British Museum e quei gentiluomini ampollosi lo intimidivano: preferiva la compagnia dei geroglifici.
Un diluvio di pioggia gelida scendeva su Londra. Il professor Newberry lo chiamò; sulla sua scrivania, i disegni di Howard Carter.
“Sono pienamente soddisfatto del tuo lavoro. Ti piacerebbe diventare il più giovane membro dell’Egypt Exploration Fund?”
“Quali incarichi comporta questo titolo?”
Percy E. Newberry sorrise.
“Per essere franchi, Howard, tu sei il personaggio più selvatico e indipendente che il Creatore abbia messo sulla mia strada.”
“Che difetti ho?”
“Sarà il destino a dirlo. Per quanto riguarda la fondazione scientifica privata che sarebbe ben lieta di accoglierti, ha come scopo lo studio delle arti dell’antico Egitto e una più approfondita conoscenza della sua civiltà.”
Howard Carter era ben deciso a non lasciar trasparire nessuna emozione, ma fu travolto da un’ondata di entusiasmo.
“È… È meraviglioso, ecco. Dunque resterò qui e continuerò a disegnare geroglifici!”
“Temo che non sarà così.”
D’un tratto, Newberry gli apparve quale un demone uscito dall’inferno per torturarlo. A portata di mano aveva un calamaio. Il professore intuì la sua intenzione.
“Niente gesti inconsulti, Howard; la situazione è complessa.”
“Ho commesso un errore? Perché mi licenzia?”
“La tua mancanza di controllo potrebbe procurarti molti guai.”
“I consigli, dopo. Prima, la verità!”
Percy E. Newberry, le mani dietro la schiena, si volse verso la finestra del suo ufficio, a guardare la pioggia battente.
“L’anatra dei geroglifici è un animale velenoso, Howard: una volta che ti abbia beccato, ti dura per tutta la vita.”
“Sono pronto a disegnare migliaia di anatre.”
“E sei disposto a sacrificare ogni cosa a quei volatili?”
Una messa in guardia che non sgomentò affatto il ragazzo.
“Quando si ha la fortuna di incontrare amici veri, si tengono cari.”
Il professor Newberry tornò a volgersi verso l’adolescente.
“Ebbene, caro signor Carter, eccola divenuto archeologo. Resta solo un particolare da risolvere.”
“E sarebbe?”
“Le tue valigie. Partiamo domani per l’Egitto.”




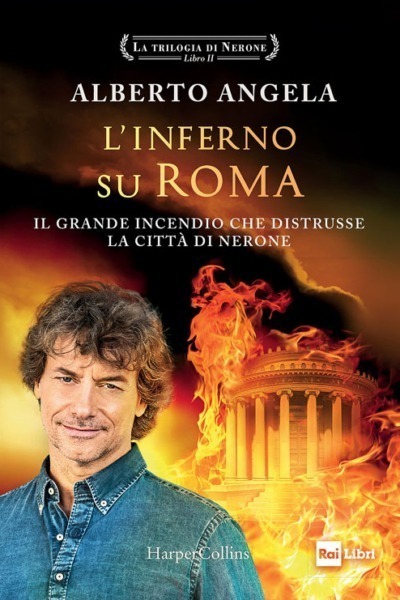


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.