Descrizione
1
Sono cresciuto a Katonah, nello Stato di New York, a circa ottanta chilometri a nord di Manhattan. Ci trasferimmo lì quando avevo tre anni da Peekskill, sempre nello Stato di New York, una cittadina con una numerosa comunità di origine italiana sul fiume Hudson dove la famiglia di mio padre si era stabilita dopo essere emigrata dalla Calabria. Anche la famiglia di mia madre era di origini calabresi e viveva nella vicina Verplanck, abitata principalmente da immigrati italiani e irlandesi. I miei genitori, Joan Tropiano e Stanley Tucci II, si erano conosciuti nel 1959 a un picnic, e pochi mesi dopo mio padre aveva chiesto a mia madre di sposarlo. Io sono nato dieci mesi dopo il loro matrimonio. Avevano chiaramente fretta di riprodursi. Tre anni dopo nacque mia sorella Gina, e dopo altri tre mia sorella Christine. Abitavamo in una casa moderna con tre camere da letto in cima a una collina in fondo a una strada chiusa quasi del tutto circondata dai boschi. Mio padre era il direttore del corso di discipline artistiche nel liceo di una cittadina nelle vicinanze, e mia madre lavorava nella segreteria della stessa scuola. Io e le mie sorelle frequentammo la scuola elementare, le medie e le superiori locali.
Negli anni Sessanta e Settanta le zone periferiche della parte settentrionale della contea di Westchester non erano così densamente popolate come oggi ed erano il luogo ideale in cui crescere. Io e le mie sorelle avevamo uno splendido gruppo di amici che abitavano nella nostra strada o nei dintorni con cui giocavamo tutti i giorni e quasi esclusivamente all’aperto. All’epoca non esistevano né videogame, né cellulari, e guardavamo di rado la televisione. Giocavamo nei cortili e nei campi, ma soprattutto nei boschi, per tutto l’anno. I boschi avevano tutto da offrirci: alberi infiniti su cui salire e su cui costruire «fortini», acquitrini da attraversare o su cui pattinare quando erano ghiacciati, muretti di pietra della Guerra d’indipendenza da scalare, e colline da cui scendere con la slitta quando erano ricoperte dalla neve che cadeva copiosa ogni inverno. Ora che sono nell’autunno della mia vita (avendo appena compiuto sessant’anni, forse però sono più vicino al tardo autunno) provo spesso il desiderio di tornare a quei giorni, a quei luoghi, a quando ero così innocente, curioso e pieno di energia. Vorrei tornarci anche solo per recuperare i miei bellissimi capelli. Le attività spensierate all’aperto, in qualunque tempo, rappresentano una parte meravigliosa della mia infanzia, ma ancora più meraviglioso era ciò che si cucinava e si mangiava nella mia famiglia.
Quando ero bambino, preparare, servire e ingerire il cibo era l’attività primaria e il principale argomento di conversazione in casa mia. Mia madre sostiene che quando sposò mio padre sapeva a malapena far bollire l’acqua. Se è vero, nel corso dell’ultimo mezzo secolo ha decisamente colmato le sue lacune. Posso dire con tutta sincerità che sul fornello elettrico a quattro fuochi che ha usato per tutta la mia infanzia e sul piano cottura a gas che ne ha preso il posto molti anni dopo non ha mai cucinato niente che fosse meno che buono. Nemmeno una volta. Il fulcro della sua cucina sono le ricette della sua famiglia o della famiglia di mio padre (ma non ha mai avuto paura di avventurarsi tra le ricette dell’Italia settentrionale:
settentrionale: il suo risotto alla milanese è uno dei migliori che abbia mai mangiato). Nel corso degli anni ha perfezionato anche alcuni piatti di altri Paesi, che sono diventati un classico del suo repertorio. Un anno ha fatto la sua comparsa la paella, cucinata e servita in un’elegante casseruola danese bianca e arancione. Traboccante di vongole, cozze, gamberi, pollo e astici (all’epoca, l’astice era molto più abbordabile), è stato per anni un piatto delle occasioni speciali. All’inizio degli anni Settanta, senz’altro su ispirazione di Julia Child, sono apparse per la prima volta le crêpes. Soffici e leggere, ripiene di pollo e ricoperte di besciamella, ne andavamo matti. Di tanto in tanto ecco arrivare in tavola un ricco e denso chili con carne, punteggiato di peperoncini verdi e rossi, la carne ben condita con sugosi pomodori rossi e olio d’oliva. Questo piatto veniva spesso preparato in occasione del party annuale che i vicini davano per il Super Bowl. Noi non ne abbiamo mai organizzato nemmeno uno, perché nessuno in casa era un appassionato di football.
A questo punto credo sia chiaro che, quando ero giovane, mia madre passava buona parte della giornata in cucina. E ancora oggi è così. Cucinare per lei è allo stesso tempo uno sfogo creativo e un modo per nutrire la famiglia. La sua cucina, al pari di quella di ogni grande chef, è la prova che la creatività culinaria può essere la forma d’arte più perfetta. Consente di esprimersi liberamente proprio come dipingere, comporre musica o scrivere, ma soddisfa anche un bisogno molto più pratico: mangiare. Arte edibile. Cosa c’è di meglio?
Vista l’abilità culinaria di mia madre, quando ero bambino mangiare dai vicini era sempre un supplizio. Il cibo era insipido o semplicemente non era buono. I miei amici, invece, erano felicissimi di sedersi alla nostra tavola. Sapevano che il cibo a casa nostra era speciale. Gli ingredienti erano stati scelti con cura e spesso in base alla stagione, ogni piatto aveva una storia ed era preparato con amore.
Non erano meravigliati solo dal cibo in sé, ma anche dalla passione con cui veniva cucinato e presentato e dalla gioia con cui la nostra famiglia lo consumava. I nostri mugolii di soddisfazione bastavano a convincere chiunque a godersi il pasto anche se non lo stava già facendo. Tra un mugolio e l’altro discutevamo del come e del perché era tutto così delizioso. «È la cosa migliore che tu abbia mai cucinato, Joan», diceva mio padre ogni sera. Io e le mie sorelle confermavamo, mentre nostra madre borbottava qualcosa sul fatto che fosse insipido o poco cotto, oppure chiedeva: «Anche per voi è un po’ asciutto?» e così via.
Quindi seguivano racconti di pasti già consumati, immaginati, o desiderati, poi in un lampo il pranzo o la cena erano finiti e non si era parlato praticamente d’altro se non di cibo. La politica, per fortuna, non era in cima ai nostri interessi. Qualunque cosa mangiassimo – potevano anche essere semplicemente olive e affettati presi in salumeria – a casa nostra veniva elevata a un nuovo livello di gusto. Una volta, un amico del college, mentre mangiava un panino con prosciutto e formaggio nel mio primo appartamento di New York, mi disse: «Stan, com’è possibile che io compro la stessa roba che compri tu, nello stesso negozio, ma a casa tua è più buona?»
«Dovresti andare a trovare i miei genitori, allora», gli risposi. Nelle famiglie italiane non c’è nulla che venga discusso, analizzato, o su cui si scherzi più del cibo (a parte la morte, ma terrò l’argomento per un altro libro); per questo nella mia famiglia esistono diverse espressioni legate al cibo che sono state trasmesse di generazione in generazione e che continuo a usare ancora oggi anch’io.
Mio padre è un mangiatore molto vorace, e a cena, mentre assaporava il cibo (in realtà né io, né lui pratichiamo l’attività dell’assaporare, anche se forse siamo entrambi esperti di assaporamento post-prandiale), inevitabilmente pronunciava questa domanda retorica: «Mio Dio, ma cosa mangia il resto del mondo?!!!»
Considerata la qualità del nostro cibo, mi sembrava una domanda più che giusta. Quando la cena era pronta, beveva un ultimo sorso di Scotch, sbatteva il bicchiere sul bancone di legno, ed esclamava: «Bene! Perché ho una fame che parla con Dio!»*
Ma Dio non deve prestargli molta attenzione, perché la fame atavica di mio padre si ripresenta ogni sera.
Quando era piccolo, come tutti i bambini, chiedeva sempre: «Mamma, cosa c’è per cena?»
La sua dolcissima madre (lo dico in base ai racconti che ho sentito, dato che è morta quando io avevo solo sette anni e non ho potuto conoscerla bene) allora gli rispondeva: «Cazzi e patate»**.
In altre parole: «Lasciami in pace». Nell’attuale clima politicamente corretto, se i genitori dicessero una cosa del genere ai figli verrebbero immediatamente allertati i servizi sociali. L’unica speranza sarebbe un’assistente sociale di origine italiana.
Quando eravamo piccoli, se io e mia sorella ci lamentavamo di qualcosa che nostra madre aveva cucinato con amore, lei ci suggeriva senza troppi giri di parole di andare a vedere cosa avevano preparato i vicini. E così metteva fine alla discussione. Il motivo, come ho già detto, è che noi sapevamo benissimo cosa mangiavano i vicini, e non avevamo alcun desiderio di rivivere l’esperienza. A casa nostra, arrivava in tavola ogni giorno un pasto delizioso e ben bilanciato, e anche se ci lamentavamo dei broccoli, del pesce, dell’insalata, o delle costolette di maiale, sapevamo di essere molto fortunati. Eppure, anche se quando ci lagnavamo di quello che preparava lei ci diceva di andare a vedere se dai vicini avremmo trovato trovato qualcosa di meglio, mia madre conosceva benissimo i nostri gusti e faceva il possibile per preparare ogni sera almeno un paio di piatti che potessero soddisfare tutti quanti. La cena tipica poteva consistere in un piatto di pasta coi broccoli, cotolette di vitello con contorno di zucchine saltate, e insalata. Con una tale varietà, c’era sempre qualcosa per tutti. Mia sorella Christine adorava la carne, Gina preferiva la pasta e le verdure, e io mangiavo sostanzialmente tutto quello che mi mettevano davanti. La sera dopo poteva esserci pollo alla cacciatora con contorno di riso, scarola in padella e insalata di cavolo, e così via. Come facesse mia madre a preparare tutte le sere piatti così strepitosi, vari e sani lavorando fuori tutto il giorno è qualcosa che va oltre la mia capacità di comprensione.
Con l’avvicinarsi del venerdì il budget famigliare si era notevolmente ridotto, e così i pasti del weekend erano semplici e poco costosi. Ma non era un problema, perché gli italiani sono bravissimi a mettere insieme un pasto sostanzioso praticamente dal nulla. Il venerdì era spesso l’unica sera in cui cucinava mio padre, così che anche nostra madre avesse un po’ di meritato riposo. Lei si trasformava nel suo sous-chef, pronta ad aiutarlo in caso di bisogno. La classica cena del venerdì sera consisteva in uno dei piatti che mio padre era bravo a preparare. Il più semplice, e quello che mangiavamo più spesso, era la pasta aglio e olio. Eccola qua.


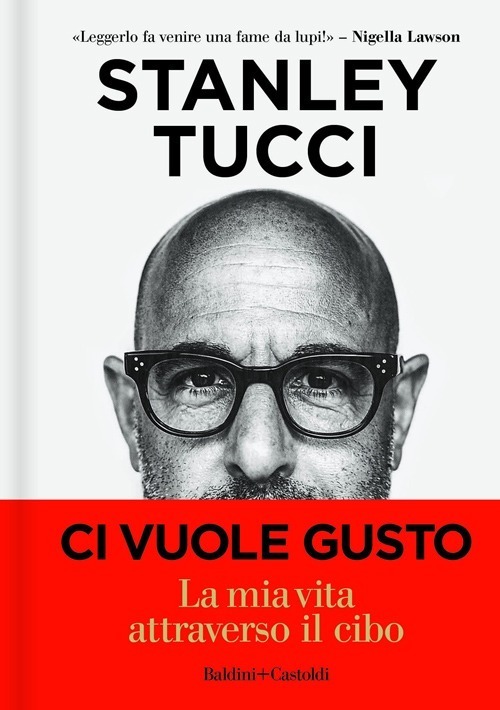



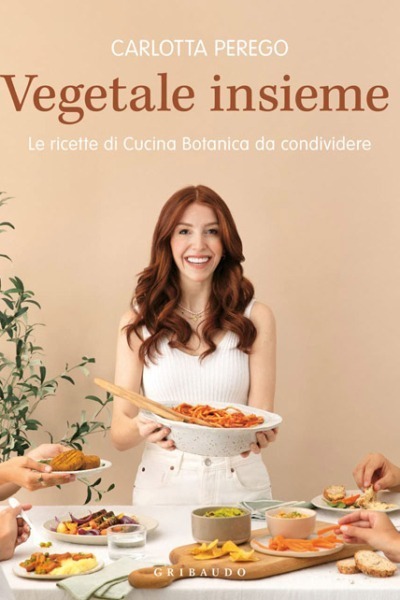


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.