Il libro dei Baltimore
€17,00
Sino al giorno della Tragedia, c’erano due famiglie Goldman. I Goldman di Baltimore e i Goldman di Montclair. Di quest’ultimo ramo fa parte Marcus Goldman, il protagonista di La verità sul caso Harry Quebert. I Goldman di Montclair, New Jersey, sono una famiglia della classe media e abitano in un piccolo appartamento. I Goldman di Baltimore, invece, sono una famiglia ricca e vivono in una bellissima casa nel quartiere residenziale di Oak Park. A loro, alla loro prosperità, alla loro felicità, Marcus ha guardato con ammirazione sin da piccolo, quando lui e i suoi cugini, Hillel e Woody, amavano di uno stesso e intenso amore Alexandra. Otto anni dopo una misteriosa tragedia, Marcus decide di raccontare la storia della sua famiglia: torna con la memoria alla vita e al destino dei Goldman di Baltimore, alle vacanze in Florida e negli Hamptons, ai gloriosi anni di scuola.
Ma c’è qualcosa, nella sua ricostruzione, che gli sfugge. Vede scorrere gli anni, scolorire la patina scintillante dei Baltimore, incrinarsi l’amicizia che sembrava eterna con Woody, Hillel e Alexandra. Fino al giorno della Tragedia. E da quel giorno Marcus è ossessionato da una domanda: cosa è veramente accaduto ai Goldman di Baltimore? Qual è il loro inconfessabile segreto?
Informazioni aggiuntive
| Autore | |
|---|---|
| Editore | |
| Data di pubblicazione | 10 maggio 2018 |
| ISBN-13 | 978-8893445511 |
| Lingua | |
| Formato | Copertina flessibile |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora domande.


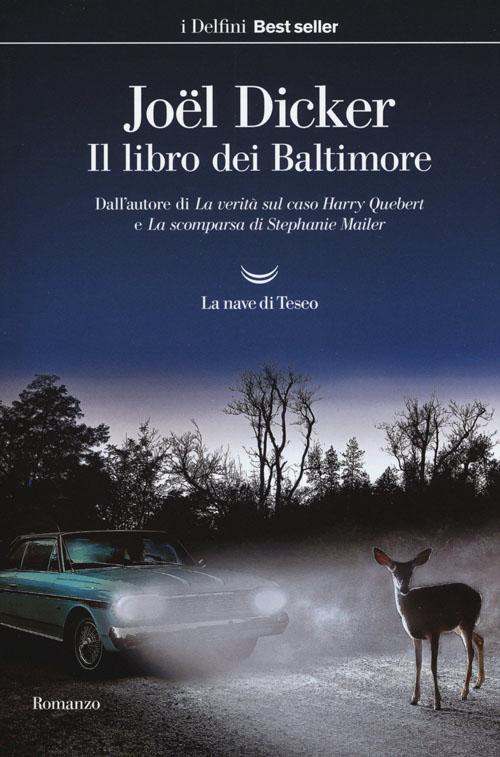

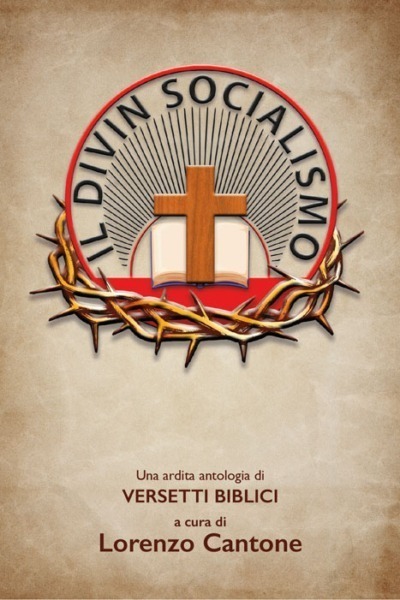

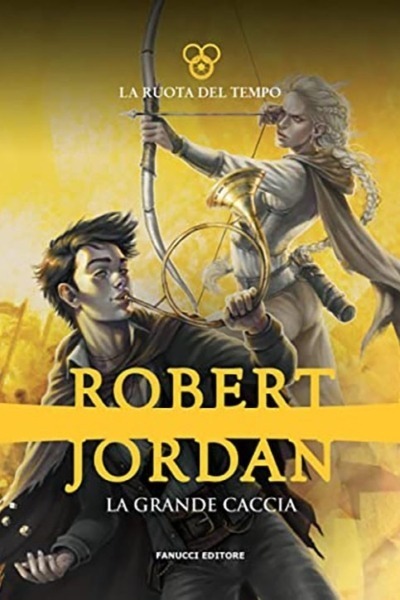
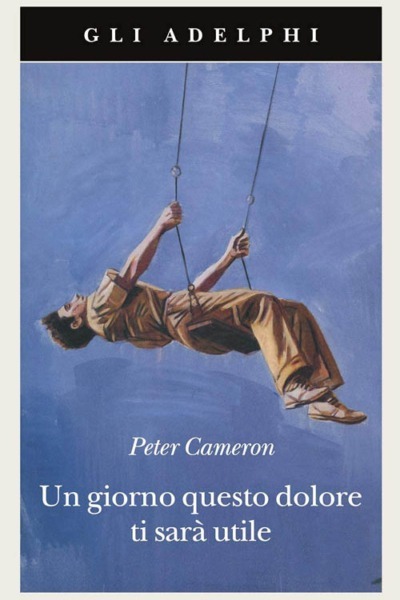

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.