La verità sul caso Harry Quebert
€17,00
Estate 1975. Nola Kellergan, una ragazzina di 15 anni, scompare misteriosamente nella tranquilla cittadina di Aurora, New Hampshire. Le ricerche della polizia non danno alcun esito. Primavera 2008, New York. Marcus Goldman, giovane scrittore di successo, sta vivendo uno dei rischi del suo mestiere: è bloccato, non riesce a scrivere una sola riga del romanzo che da lì a poco dovrebbe consegnare al suo editore. Ma qualcosa di imprevisto accade nella sua vita: il suo amico e professore universitario Harry Quebert, uno degli scrittori più stimati d’America, viene accusato di avere ucciso la giovane Nola Kellergan. Il cadavere della ragazza viene infatti ritrovato nel giardino della villa dello scrittore, a Goose Cove, poco fuori Aurora, sulle rive dell’oceano. Convinto dell’innocenza di Harry Quebert, Marcus Goldman abbandona tutto e va nel New Hampshire per condurre la sua personale inchiesta. Marcus, dopo oltre trent’anni deve dare risposta a una domanda: chi ha ucciso Nola Kellergan? E, naturalmente, deve scrivere un romanzo di grande successo.
Informazioni aggiuntive
| Autore | |
|---|---|
| Editore | |
| Data di pubblicazione | 12 gennaio 2022 |
| ISBN | 978-8830109391 |
| Lingua | |
| Formato | Copertina flessibile |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora domande.






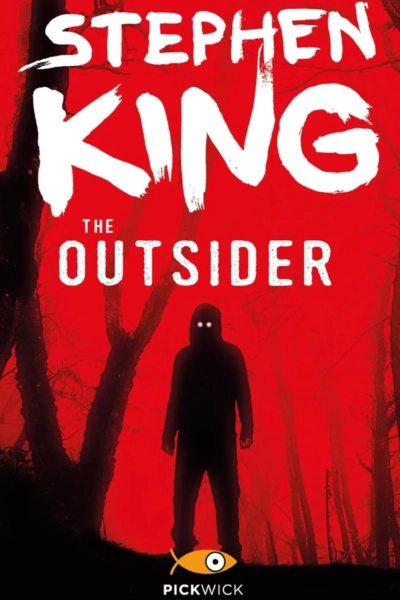


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.