Descrizione
Prologo
«Ho preso un appuntamento per vederlo».
Lo disse come se stesse parlando del dentista o dello psicologo o dell’assillante venditore di frigoriferi che aveva garantito a vita a lei e Walter latte fresco, verdure croccanti e formaggio perfettamente conservato se solo avessero acquistato quel nuovissimo modello.
Lui asciugava i piatti, gli occhi fissi sulla gallina gialla con l’ombrello stampata sullo strofinaccio. Non replicò. L’inclinazione per la logica di Walter Archer, la sua capacità di lasciare che la ragione prevalesse su tutto erano la testimonianza del buonsenso di Roya. Non aveva forse sposato un uomo ragionevole, un pilastro di stabilità e, santo cielo, incredibilmente comprensivo? Walter. Che mangiava un uovo sodo a colazione quasi ogni singolo giorno, che disse mentre asciugava i piatti: «Se vuoi vederlo, dovresti farlo. Mi sembri un po’ turbata».
Ormai Roya era quasi americana, non solo per via del matrimonio, ma anche perché viveva lì, negli Stati Uniti, da quasi sessant’anni. Ricordava l’infanzia trascorsa nelle strade soffocanti e polverose di Teheran a giocare ad acchiapparello con la sorella minore, Zari, ma adesso la sua vita era accuratamente circoscritta al New England.
Con Walter.
Ma era bastato mettere piede in un negozio solo una settimana prima – per comprare delle graffette! – a scoperchiare il vaso di pandora. Si era trovata catapultata nel 1953. Il Cinema Metropole al centro della città più grande dell’Iran quell’estate di sconvolgimenti. Il divano rosso rotondo nell’atrio sopra il quale le gocce di cristallo di un lampadario scintillavano come grosse lacrime, il fumo delle sigarette che aleggiava ovunque. Il ragazzo che la teneva per mano. Fuori, il cielo era color lavanda e dipinto di così tante sfumature di viola da sembrare irreale. Era un’estate densa di promesse. Ma alla fine, niente. La vita le aveva portato via tutto quello che aveva pianificato.
Nessun problema.
La madre di Roya diceva sempre che il nostro destino lo portiamo scritto in fronte alla nascita. Non lo si può vedere, non lo si può leggere, ma è lì, tracciato in inchiostro invisibile, e la vita obbedisce al destino. Indipendentemente da tutto.
Aveva una vita da costruire, un Paese da conoscere. Walter. Quel ragazzo di Teheran poteva benissimo rimanere ficcato in fondo a un secchio, come uno straccio inutile e logoro cacciato così in profondità che dopo un po’ era stato quasi dimenticato. Fino a quel momento.
Walter manovrò l’auto nella piazzola ghiacciata stretta fra cumuli di neve. Quando si fermarono, Roya non riuscì ad aprire la portiera. Per qualche ragione durante il tragitto in macchina erano rimasti bloccati dentro.
Lui fece il giro e le aprì lo sportello, perché era Walter e perché era stato cresciuto da una madre (Alice: gentile, dolce, con addosso l’odore di insalata di patate) che gli aveva insegnato come comportarsi con una signora. Perché aveva settantasette anni e non riusciva a capire come mai i giovani di oggi non trattassero le mogli come vetro delicato. Aiutò Roya a scendere e si assicurò che la sciarpa le coprisse bene naso e bocca riparandola dal vento. Attraversarono con cautela il parcheggio e salirono i gradini dell’edificio grigio che ospitava il Duxton Senior Center.
Nell’atrio furono accolti da una folata di aria surriscaldata. Una giovane sui trent’anni coi capelli biondi raccolti in uno chignon era seduta dietro una scrivania. Sul petto portava appuntata una targhetta di plastica con scritto claire. Sulla bacheca alle sue spalle erano attaccati volantini che proclamavano “Serata cinema!” e “Pranzo bavarese!”, tutti pieni di punti esclamativi, anche se i bordi si arricciavano, anche se persone rattrappite in sedia a rotelle avanzavano a passo di lumaca sul pavimento di linoleum e altri si appoggiavano al deambulatore per non cadere.
«Ehilà! Vi unite a noi per il pranzo del venerdì?» Claire parlava a voce altissima. Walter aprì bocca per rispondere.
«Salve, no», intervenne in fretta Roya. «Mio marito ha intenzione di provare il famoso lobster roll del Dandelion Deli. Ha cercato su Yelp. Non è cosa da tutti i giorni trovare i lobster roll in pieno inverno, non crede? Anche se l’astice non l’ha visto neanche in foto». Stava parlando a vanvera. Si sforzava in tutti i modi di non essere nervosa. «Ha cinque stelle».
«Quella gastronomia?» La receptionist sembrava stupita.
«Il loro lobster roll», borbottò Roya.
Walter sospirò e alzò cinque dita per segnalare a Claire che sua moglie credeva nelle cinque stelle.
«Ah, okay! Astice!», Claire annuì. «C’è da fidarsi di quelle recensioni di Yelp!»
«Vai, adesso», disse Roya al marito in tono gentile. Si alzò in punta di piedi per dargli un bacio sulla guancia rasata di fresco. La pelle sottile, il profumo di sapone irlandese. Voleva rassicurarlo.
«Giusto». Annuì lui. «Hai ragione. Vado, allora». Ma non si mosse. Lei intrecciò le dita alle sue, quella stretta delicata che ormai le era così famigliare.
«Non permetta che si cacci nei guai», disse alla fine rivolto alla receptionist. Aveva la voce tesa.
Una folata di aria fredda riempì l’atrio quando Walter uscì dalle porte a doppio battente e scese nel parcheggio ghiacciato.
Roya rimase in piedi a disagio davanti alla reception. D’un tratto fu sopraffatta dalla puzza di ammoniaca e di stufato. Manzo? Manzo con cipolle, sicuramente. Il riscaldamento tenuto al massimo per compensare il freddo del New England rendeva l’odore di cibo opprimente. Non poteva credere di essere lì. I radiatori sibilavano, le sedie a rotelle cigolavano, e di colpo tutto le parve un terribile errore.
«Come posso aiutarla?», chiese la ragazza. Al collo portava una croce d’oro. La osservava con un’espressione strana, come se la conoscesse.
«Ho preso appuntamento per vedere una persona», disse Roya. «Uno dei vostri pazienti della casa di riposo».
«Ah, intende un ospite. Magnifico. E di chi si tratta?»
Le parole le uscirono di bocca lentamente, come anelli di fumo, visibili e concrete. Erano passati anni da quando aveva pronunciato a voce alta il suo nome.
La croce al collo di Claire scintillò sotto le luci al neon. Ormai Walter doveva essere uscito dal parcheggio.
Claire si alzò, fece il giro della scrivania e le prese entrambe le mani fra le sue. «È così bello conoscerla finalmente, Mrs Archer. Sono Claire Becker, la viceresponsabile del Duxton Center. Grazie per essere venuta. Ho sentito parlare così tanto di lei. Il fatto che sia qui significa molto per me».
Non era la receptionist, era una responsabile. Come faceva a sapere il suo nome? Doveva essere sull’agenda. Aveva preso un appuntamento, dopotutto. Ma perché questa giovane donna si comportava come se la conoscesse? E come faceva ad aver sentito parlare di lei?
«Venga, prego», disse Claire a voce bassa. Stavolta non aveva aggiunto i punti esclamativi d’obbligo che sembravano necessari per mascherare la tristezza che aleggiava in quel posto.
La seguì lungo il corridoio fino a una grande sala arredata con un lungo tavolo e sedie pieghevoli di plastica disposte tutt’intorno. Ma non c’era nessuno seduto a giocare a bingo o a chiacchierare.
Claire indicò l’estremità opposta del locale. «La sta aspettando».
Vicino alla finestra c’era un uomo in sedia a rotelle. Dava loro le spalle e Roya non lo vedeva bene in faccia. Claire si avviò per poi fermarsi.
Inclinò la testa di lato e la squadrò da capo a piedi come per valutare il suo potenziale: doveva aspettarsi compostezza, pericolo, sceneggiate? Giocherellò con la collana. «Posso portarle qualcosa? Acqua? Tè? Caffè?»
«Oh, sto bene così, grazie lo stesso».
«Sicura?»
«Gentile da parte sua. Niente».
Adesso era la volta di Claire di indugiare. Dio santo, nessuno voleva lasciarla da sola con questo… ospite. Ma per la miseria. Come se alla sua età avesse ancora un qualche potere su di lui, o su chiunque altro. Come se lei, Roya Archer, potesse incenerire quel posto, farlo saltare in aria con la sua sola presenza.
«Sto bene così», disse. Lo aveva imparato dagli americani: “Sono a posto”, “Sto bene”, “Tutto ok, okay”. Americanismi semplici. Sapeva come comportarsi. Il cuore le martellava, ma guardò la ragazza senza batter ciglio.
Claire abbassò la testa e finalmente si girò e uscì. Il ticchettio dei tacchi mentre lasciava la stanza faceva il paio con il battito furioso del cuore di Roya.
Era ancora in tempo a seguire Claire e andarsene da quel posto puzzolente, raggiungere Walter prima che finisse il pranzo, tornare a casa, andare a letto e fingere di non aver mai commesso quel bizzarro errore di valutazione. Non era troppo tardi. Immaginò suo marito seduto tutto solo con le spalle curve in quella gastronomia davanti a una ginger beer e al lobster roll … povero caro. Però, no. Era venuta qui per scoprire finalmente come stavano le cose.
Un piede davanti all’altro, era così che si faceva. Si costrinse ad avvicinarsi alla sedia a rotelle. I suoi tacchi non facevano rumore; indossava le sue fide scarpe grigie dalla suola spessa. Walter aveva insistito perché si mettesse degli stivali da neve, ma lei si era rifiutata.
L’uomo sembrava ignaro della sua presenza, come se lei non esistesse.
«Ti stavo aspettando», disse all’improvviso una voce in farsi, e Roya fu percorsa da un brivido.
Era il 1953. Era estate. Il New England si dissolse, il freddo all’esterno e il caldo artificiale all’interno evaporarono, e le gambe di Roya erano abbronzate e toniche, e loro due, lei e lui, erano sulle barricate a sporgersi sul legno scheggiato, a urlare con tutto il fiato che avevano in gola. La folla ondeggiava, il sole le scottava la testa, due lunghe trecce finivano al di sotto del seno, il colletto alla Peter Pan era fradicio di sudore.
Attorno a loro le persone agitavano i pugni e gridavano all’unisono. Un senso di attesa, la consapevolezza che stava per arrivare qualcosa di nuovo e migliore, la certezza che sarebbe stata sua in un Iran libero e democratico… ecco quello che provavano.
Roya vide i propri piedi sul linoleum e d’un tratto non li riconobbe… in quelle scarpe grigie da vecchia con la suola spessa e le nappine sulla punta.
L’uomo fece ruotare la sedia a rotelle e il suo viso si aprì in un sorriso. Aveva l’aria stanca; le labbra erano screpolate e la fronte percorsa da rughe profonde. Ma gli occhi erano gioiosi e pieni di speranza.
«Ti stavo aspettando», ripeté. Era possibile tornare indietro così facilmente? Era lui, proprio lui, gli occhi, la voce.
Poi però si ricordò perché era venuta. «Capisco». La voce le uscì molto più forte di quanto intendesse. «Ma tutto quello che volevo chiederti è perché mai non mi hai aspettata l’ultima volta?»
Si lasciò cadere sulla sedia accanto a lui, stanca come non si era mai sentita in vita sua. Aveva settantasette anni ed era esausta. Ma mentre rievocava quell’estate di crudele disillusione da cui non si era mai ripresa del tutto, ebbe la sensazione di avere di nuovo diciassette anni.
PARTE PRIMA
1
«Mi piacerebbe», disse Baba a colazione mentre mangiavano naan fresco con la feta e la marmellata di amarene fatta in casa, «che voi ragazze diventaste le prossime Marie Curie. Sarebbe bello. O magari scrittrici», sorrise a Roya, «come quell’americana: Keller? Helen Keller?»
«Non sono sorda, Baba», disse Roya.
«Non è cieca, Baba», disse Zari.
«E questo cosa c’entra?», Maman fece cenno alle figlie di sbrigarsi a finire.
«Devi essere sorda e cieca per essere Helen Keller». Zari fece un gran sorriso, fiera di ciò che sapeva delle eroine americane.
«E muta. Non dimenticare muta», borbottò Roya.
«Non intendevo quella parte». Baba mise giù il bicchiere di tè. «Intendevo la parte del genio. Intendevo la parte di scrivere undici libri. Ecco cosa intendevo!»
Il destino aveva dato a Maman e Baba solo due figli, e femmine per di più. Baba era notevolmente illuminato per la sua epoca: voleva che le figlie fossero istruite e avessero successo. L’istruzione era il suo credo e la democrazia il suo sogno.
Studentesse delle superiori, Roya e Zari erano avviate a ottenere la migliore istruzione cui una ragazza potesse aspirare nell’Iran del 1953. Il Paese stava cambiando in fretta e si apriva al mondo. Avevano un primo ministro eletto democraticamente: Mohammad Mossadeq. E avevano anche un re, lo scià, che continuava il lavoro in difesa dei diritti delle donne iniziato da suo padre, Reżā Pahlavī. «Non c’è dubbio che lo scià sia un lacchè dei dannati britannici quando si tratta di vendere il nostro petrolio!», diceva sempre Baba. «Però, sì, ha aiutato le donne. Questo ve lo concedo».
Le opinioni illuminate di Baba e Maman erano criticate con sdegno dai membri della famiglia più tradizionalisti. Ma cosa gli passa per la testa, sibilavano le zie in cucina rivolte a Maman, di lasciar andare le figlie dappertutto senza un accompagnatore? Maman era ormai abituata a liquidarle con una risata. Aveva smesso di portare l’hijab non appena lo scià Reżā aveva abolito il velo per le donne, negli anni Trenta. Aveva accolto con favore le riforme per l’emancipazione femminile anche se i suoi parenti più religiosi non vedevano di buon occhio l’adozione di usanze straniere, da farangi.
Maman e Baba avevano mandato le figlie alla migliore scuola superiore femminile di Teheran. Ogni mattina, mentre Maman metteva il tè in infusione, le due sorelle si preparavano per la giornata. Roya si limitava a lavarsi la faccia e a legarsi i folti capelli scuri in due lunghe trecce, Zari, invece, si dava un po’ di rossetto e sistemava tutta orgogliosa la chioma ondulata che si era fatta avvolgendo le ciocche in striscioline di carta da giornale.
Mentre la sorella minore si agghindava, Roya guardò il proprio riflesso allo specchio. Nell’ultimo anno era cambiata parecchio. Il viso aveva perso la rotondità infantile e gli zigomi erano più prominenti. La pelle, che certe volte si ricopriva di foruncoli, ora era liscia. I lunghi capelli neri erano ondulati e avrebbe potuto lasciarli sciolti sulle spalle come le consigliava spesso Zari, ma lei continuava a preferire le trecce: la facevano sentire più se stessa, soprattutto adesso che il suo fisico era così diverso. Non era cresciuta in altezza, ma ora era più formosa… o, per dirla come la sorella, “sviluppata”.
Zari la fece spostare e monopolizzò lo specchio. Si toccò i capelli e sporse in fuori le labbra. «Questa pettinatura mi fa somigliare a Sophia Loren. Vero?»
Che altro avrebbe potuto rispondere Roya, se non sì? Si abbottonò la camicia di cotone a maniche lunghe, infilò l’uniforme di ormak e si tirò su gli odiati calzettoni. Doveva ammettere che perfino lei avrebbe voluto portare i calzini alle caviglie, quelli “americani”, come li chiamavano le altre ragazze, ma la preside puniva le studentesse che li indossavano. Roya non aveva trovato il coraggio di entrare a scuola a testa alta con dei calzini ai piedi.
«È la nostra speranza!», Baba si riempì la bocca di pane e feta. «Il primo ministro Mossadeq ha nazionalizzato il petrolio, così possiamo liberarci dal cappio dell’aioc». L’Anglo-Iranian Oil Company era la nemesi di Baba. «Per la prima volta da decenni, gli iraniani possono avere il controllo delle loro risorse naturali, anziché essere sfruttati dai Paesi imperialisti. Il primo ministro è l’unico capace di tener testa alle potenze straniere. Diventeremo una democrazia in un batter d’occhio con Mossadeq alla guida. Ora, se voi ragazze studiate storia, chimica e matematica, potrete entrare a far parte della classe di professionisti migliore che questo grande Paese abbia mai avuto. Riuscite a crederci? Lo vedete cosa vi viene offerto? Le opportunità che si aprono per le giovani donne? Cosa posso fare io come funzionario del governo? Passar carte? Starmene seduto a bere tè?» Ne bevve un lungo sorso dal suo bicchiere. «Ma voi, figlie mie! Voi arriverete più lontano di quanto vostra madre e io abbiamo mai potuto sognare. Giusto, Manijeh?»
«Una mattina soltanto!», esclamò Maman. «Non possiamo avere una mattina senza conferenze? Colazione e basta?»
Baba parve ferito, ma non si arrese del tutto. «La mia Marie Curie!» Rivolse un cenno del capo a Zari. «La mia Helen Keller!» Strizzò l’occhio a Roya.
Le ragazze, che avevano diciotto mesi di differenza, conoscevano fin troppo bene le speranze esagerate del loro padre. Roya, diciassette anni, cercava di essere all’altezza dei desideri di Baba, ma quello che voleva fare davvero era leggere i romanzi di scrittori come Hemingway e Dostoev-skij. O le poesie dei grandi autori persiani come Rumi, Hafez o Saadi. Le piaceva anche cucinare stando accanto a Maman e seguendo le ricette dei migliori spezzatini khoresh.
E la sorella minore non era esattamente sulla strada per diventare una futura Marie Curie. Zari era ossessionata da un ragazzo di nome Yousof. Voleva sposare un uomo ricco, ballare il tango e imparare il valzer. Le importava di più avere cinque toman per comprare il biglietto per una delle feste dei ragazzi popolari, lanciarsi in una samba e stupire tutti con i suoi passi. Non passava sera, quando andavano a letto, che Zari non raccontasse alla sorella per filo e per segno tutti i suoi sogni.
«Andate, adesso!» Maman baciò le figlie sulle guance e prese i loro bicchieri.
Zari fece il saluto a Baba, esprimendo scherzosamente la propria devozione agli ideali del padre. Anziché ridere, Baba le restituì il gesto lentamente e con espressione serissima. Lei lanciò un’occhiata a Roya con una smorfia appena accennata, il linguaggio segreto delle sorelle.
Alla porta, si infilarono le scarpe nere basse con il cinturino che facevano parte dell’uniforme della scuola. Uscirono infine dall’andarun, la parte più interna della casa, nella parte esterna, percorsero un corridoio e scesero i gradini che portavano nel giardino. Mentre passavano accanto allo stagno delle carpe piastrellato di azzurro, Roya invidiò i pesci. Non facevano altro che nuotare in quell’acqua fresca. Non erano tenuti a diventare membri della miglior classe di professionisti che il Paese avesse mai avuto.
Roya chiuse il cancello e insieme alla sorella imboccò il vicolo che portava alla strada principale. Qui rimasero vicine, con i libri stretti al petto.
Non c’erano manifestanti a quell’ora del mattino, ma il terreno era cosparso dei volantini di una dimostrazione precedente. Fotografie del primo ministro Mossadeq – l’affilato naso aquilino, gli occhi da erudito stanchi del mondo – ricoprivano la strada. Roya non sopportava di vedere la sua faccia sparpagliata ovunque in quel modo, calpestata da tutti. Ne raccolse alcuni, tenendoli con cautela a faccia in su.
«Oh, ma per favore, pensi sul serio di poterlo salvare?», chiese Zari. «Stasera ci sarà una manifestazione comunista. E dopo quella ce ne sarà un’altra dei sostenitori dello scià. Non puoi salvare il primo ministro. È messo in minoranza da due fazioni che vogliono cacciarlo».
«Ha migliaia, milioni di sostenitori! Il popolo, noi, lo sosteniamo!», protestò Roya.
«Il popolo ha ben poco potere, e lo sai. In questo Paese ci sono troppi intrallazzi e corruzione dietro le quinte».
Roya strinse più forte al petto i libri e le immagini di Mossadeq. Ovviamente Zari aveva ragione. Solo la settimana prima a scuola era stata indetta un’assemblea straordinaria. La preside era rimasta in piedi sul palco con le mani sui fianchi e aveva preteso che gli studenti identificassero chi faceva circolare volantini comunisti fra gli studenti. Nessuno aveva parlato. Roya sapeva che era Jaleh Tabatabayi a passarli sotto i banchi a lezione e durante l’intervallo, nascosti nella carta da pacchi. Si chiedeva come facesse ad avere accesso a quei testi. Come avesse anche solo avuto il coraggio di procurarseli. Poi, all’uscita, si erano ritrovate davanti la polizia con un megafono, le armi e un tubo dell’acqua. Abbas, il portiere della scuola, aveva aiutato i poliziotti dal collo taurino ad attaccare il tubo a un rubinetto in cortile. Non appena Jaleh era uscita da scuola, i poliziotti avevano aperto l’acqua e le avevano puntato addosso il tubo. Sulle prime l’espressione di Jaleh era stata di stupore meravigliato. Poi sul volto le si era dipinta la determinazione. Aveva fatto un salto per evitare il serpente sibilante del getto ed era atterrata con un tonfo, investita in pieno dall’acqua. Qualche secondo più tardi era fradicia, con l’uniforme che aderiva alle curve del corpo, i capelli sgocciolanti e incollati alla testa.
Uno dei poliziotti aveva detto al megafono: «Questo ti insegnerà a svergognare il tuo Paese diffondendo bugie comuniste. Non crediate che non scoveremo fino all’ultimo di voi, traditori collusi con la Russia. Voi ragazze dovete concentrarvi a diventare giovani donne rispettabili anziché somari politici».
La preside aveva applaudito.
Le ragazze favorevoli alla monarchia, devote allo scià, si erano unite all’applauso e avevano esultato. Parecchie di loro venivano da famiglie ricche con padri che lavoravano nell’industria petrolifera. Quelle molto religiose le imitarono. Era la prima volta da molto tempo che famiglie del clero e sostenitori dello scià si trovavano dalla stessa parte.
Non appena i poliziotti e la preside se ne andarono, le amiche di Jaleh le si affollarono attorno, cercando di asciugarla con i maglioni, i fazzoletti, l’orlo dell’uniforme. Jaleh rimase a testa alta anche se sgocciolava e disse loro di non preoccuparsi. Scoppiò perfino a ridere.
Roya sapeva che adesso avrebbe distribuito più volantini marxisti, non meno. Le comuniste del Tūdeh erano fatte così: impavide e risolute, sempre pronte a proclamare che l’Iran avrebbe dovuto seguire l’esempio dell’Unione Sovietica. Roya, Zari e le altre sostenitrici del primo ministro avevano formato il loro gruppetto, scioccate e scosse. Se una compagna le avesse chiesto per chi parteggiava, Roya avrebbe risposto: «Il primo ministro Mossadeq e il Fronte nazionale»; dire qualcos’altro avrebbe spezzato il cuore a Baba. Il primo ministro Mossadeq avrebbe potuto portare il loro Paese alla democrazia. Aveva studiato diritto in Svizzera, era diventato ministro degli Esteri ed era andato fino alle Nazioni Unite per testimoniare che l’Anglo-Iranian Oil Company britannica avrebbe dovuto dare all’Iran la proprietà del suo petrolio. Roya apprezzava l’indipendenza e la sicurezza di Mossadeq. Ammirava perfino il suo pigiama (col quale talvolta era stato fotografato).
Mentre camminava diretta a scuola con Zari ripensò all’incidente con il tubo dell’acqua e desiderò che la polarizzazione e la continua rivalità politica finissero. La politica era penetrata in tutte le classi: le sue compagne erano divise, proprio come il Paese, tra favorevoli alla monarchia, al primo ministro e al comunismo. E lei non ne poteva più.
Quando raggiunsero il cancello d’ingresso, Abbas, il custode, aveva un’espressione severa. Era suo compito accertarsi che nessuna persona non autorizzata entrasse nell’edificio, proteggere la santità dell’istituzione e l’incolumità delle ragazze. Non faceva parte delle sue mansioni aprirsi la patta dei calzoni e tirar fuori il pene avvolto da un bel fiocco rosa. Ma era noto proprio per fare esattamente quello.
Quando Abbas aprì il cancello e sorrise, Zari si irrigidì. Una volta che furono fuori portata d’orecchio, sussurrò alla sorella: «La settimana scorsa mi ha fatto di nuovo vedere il suo doodool».
«Aveva un nastro attorno?», volle sapere Roya.
«Al solito. Come fanno gli uomini a camminare con quell’affare che gli penzola fra le gambe?»
«Deve far male».
«È enorme, mi stupisce che non abbiano un’irritazione permanente là sotto».
«Be’, hai visto solo quello del custode».
«Sì». Zari parve rifletterci sopra.
«L’hai riferito alla preside?»
«Ha detto che per una ragazza come me mentire è molto brutto. Che Abbas lavora qui da prima che io nascessi e che dovrei vergognarmi di inventare storie tanto volgari».
«Capisco. La solita risposta, quindi».
«Già». Zari sospirò.
I ragazzi non avevano nessun problema a trovare la strada dalla loro scuola a quella delle ragazze per ciondolare nei dintorni all’ora dell’uscita. Abbas gridava e li cacciava via. «Figli di cane!», sbraitava. «Lasciate in pace queste ragazze, brucerete all’inferno!»
Roya ignorava i ragazzi che le seguivano a casa, ma Zari faceva in modo che quelli carini la vedessero mentre giocherellava con i folti capelli scuri, soprattutto se fra loro c’era Yousof. Certi giorni i maschi spuntavano a ogni angolo di strada, dietro ogni svolta. Ragazzi maliziosi e svelti che facevano l’occhiolino, fischiavano e flirtavano. Ragazzi belli e spavaldi con il sorriso affascinante. Ragazzi silenziosi e timidi che azzardavano un’occhiata e poi arrossivano quando venivano colti sul fatto. Roya si era abituata alla loro presenza come ci si abitua alle mosche, ovvero non ci si era abituata proprio. Il posto che preferiva in assoluto di Teheran era la Cartoleria. Si trovava all’angolo di Churchill Street e Hafez Avenue, di fronte all’ambasciata russa e alla sua scuola.
Roya adorava far correre le dita sui blocchi di pagine, aspirare l’odore delle scatole di matite che odoravano di piombo e promettevano sapere. Poteva trascorrere pomeriggi interi solo ad ammirare le penne stilografiche e le boccette di inchiostro o a sfogliare libri che parlavano di poesia, amore e perdita. Il negozio si chiamava semplicemente la Cartoleria – non un nome fantasioso – ma era una libreria oltre che una cartoleria. Quell’inverno, quando i dissidi politici si esacerbavano e le teste calde partecipavano a dibattiti e manifestazioni per le strade, era il rifugio perfetto per starsene tranquilli e imparare. Era un luogo di pace: mai troppo illuminato, mai chiassoso.
Un giorno particolarmente ventoso di gennaio, quando la manifestazione comunista per strada si fece turbolenta, Roya si infilò nel negozio. Voleva solo leggere un po’ di poesia.
«Rumi oggi?», le chiese il signor Fakhri da dietro il bancone. Era il proprietario del negozio da quando Roya ricordava ed era un esperto di libri. Teneva gli scaffali ben forniti di classici e poeti persiani, e di traduzioni di letteratura da tutto il mondo. Era un uomo pacato e gentile sulla cinquantina, con i capelli sale e pepe, baffi cespugliosi e occhiali rotondi dalla montatura metallica, lucida come era sempre tirato a lucido il negozio.
«Sì, grazie». Roya veniva così spesso che l’uomo ormai conosceva bene i suoi gusti in fatto di letture. Sapeva che amava la poesia persiana antica, ma non sopportava alcuni racconti moderni. Sapeva che poteva spendere gli ultimi soldi della paghetta per un quaderno nuovo e che i suoi prodotti di cartoleria preferiti erano importati dalla Germania perché erano i più colorati e moderni. E che non solo aveva letto ogni parola delle antiche poesie, ma anche che, ogni tanto, in silenzio, buttava giù versi sui taccuini che acquistava da lui. Il signor Fakhri conosceva tutte queste cose ed era la sua calma scevra di giudizi a portarla in quel negozio, tanto quanto le pile di libri nuovi, le matite e i quaderni.
«Ecco qui». Il libro di poesie di Rumi che le porse era stampato su carta patinata e aveva una copertina verde scuro con le lettere dorate. «Alcune delle sue migliori, in questa raccolta. Trovati un posto tranquillo e non permettere a nessuno di disturbarti. Ci vuole un po’ di concentrazione se si vuole capirlo davvero».
Roya annuì e stava per infilare la mano nella borsa quando suonò la campanella sopra l’ingresso. La porta si spalancò, lasciando entrare le grida dalla strada e una folata di vento che fece increspare le pagine del libro di Rumi che aveva in mano. Un ragazzo della sua età entrò nel negozio di gran carriera. Portava una camicia bianca e pantaloni scuri; i capelli erano una criniera folta e nera, e aveva le guance arrossate per il vento. Fischiettava un motivo malinconico e pieno di nostalgia, diverso da qualunque cosa Roya avesse mai sentito e del tutto in contrasto con l’aspetto sicuro di sé.
Il signor Fakhri saltò su e si mosse velocemente. Si chinò dietro il bancone, prese un fascio di fogli, li legò con uno spago e li porse al ragazzo come se avesse aspettato quell’ospite speciale tutto il giorno. Lui smise di fischiettare, si cacciò le mani in tasca e pagò. Una transazione rapida, urgente, senza scambio di parole. Il ragazzo aveva quasi raggiunto la porta quando si girò. Roya credeva che avrebbe salutato il signor Fakhri e invece lui la guardò dritto in faccia. Aveva gli occhi gioiosi e pieni di speranza. «Sono fortunato a incontrarla», disse. Poi uscì nel vento.
Il signor Fakhri e Roya rimasero in silenzio mentre il negozio tornava alla normalità dopo lo scompiglio portato dalla presenza del ragazzo, come se fossero stati su una mongolfiera che solo ora toccava terra e si sgonfiava.
«Chi era?», chiese Roya sentendosi elettrizzata senza alcuna ragione al mondo. Quell’ondata di eccitazione suscitata dalla mera apparizione del ragazzo la disorientava.
«Quello, cara la mia ragazza», disse il signor Fakhri, «è Bahman Aslan». Assunse un’espressione preoccupata e tamburellò con le dita sul bancone. «Il ragazzo che vuole cambiare il mondo».
Roya mise in borsa il libro di Rumi stando attenta a non sgualcirlo e fissò la porta. Si sentiva un po’ contagiata, come se avesse assistito a qualcosa di soverchiante e sorprendente ma anche profondamente personale, qualcosa che recava in sé il pulsare inevitabile della speranza, della vita e dell’energia. Salutò il signor Fakhri, scombussolata.
Nei giorni successivi, Roya andò e tornò da scuola con Zari, mangiò il khoresh fatto da sua madre, studiò geometria, scribacchiò versi, ascoltò Baba raccontare i piani del primo ministro Mossadeq e sorrise ogni volta che le ripeteva che sarebbe stata la prossima Marie Curie, “certo che sì che diamine, lascia perdere Helen Keller”. Ma non riusciva a togliersi dalla testa il ragazzo che per una manciata di minuti aveva dato uno scossone al suo mondo imprimendogli un po’ più di velocità.
Lo cercò per giorni, inutilmente. Sembrava che, ovunque andasse, i ragazzi affollassero le strade. Partecipavano in gruppo alle diverse dimostrazioni. Hossein, quello col moccio al naso, seguiva lei e Zari avanti e indietro, irritandola oltre ogni dire. L’audace e chiassoso Cyrus insisteva per aprire loro la porta. Yousof lanciò diverse occhiate a Zari mentre attraversavano la strada e poi finse di essere concentratissimo a studiare il lampione.
Ma il ragazzo con gli occhi gioiosi, quello che aveva spinto il signor Fakhri a consegnargli un fascio di fogli con rapidità e aria d’importanza come se stesse consegnando un’arma a un guerriero, non si vedeva da nessuna parte.
La settimana successiva alla Cartoleria, mentre Roya faceva scorrere il pollice sulle minuscole scanalature dei bordi di un temperamatite di metallo, di nuovo il vento scompigliò le pagine dei libri impilati e lui fece il suo ingresso.
Smise di fischiettare non appena la vide. Sembrava meno sicuro di sé e più timido. «Rumi», disse al signor Fakhri, ma le lanciò una rapida occhiata. La zazzera di capelli neri era pettinata con cura da una parte. La camicia bianca stirata. Gli occhi brillavano e lui sorrideva educato.
Con la stessa rapidità e desiderio di compiacere, il signor Fakhri prese una copia del libro che aveva dato a Roya la settimana prima e si schiarì la gola: «Ecco qui, Bahman Jan».
Questa volta Bahman ringraziò il signor Fakhri, rivolse un lieve inchino a Roya, dopodiché uscì nuovamente in strada.
«Cos’è tutta questa fretta? Dove sta andando? Che c’è di tanto importante?», chiese lei quando si fu ricomposta. Voleva dimostrare al signor Fakhri che quel ragazzo non la faceva ammutolire.
«Te l’ho detto, Roya Khanom. Il ragazzo vuole cambiare il mondo. Una cosa che richiede fervore». Il libraio prese uno straccio e si mise a spolverare il bancone. «Richiede vigilanza». Smise di passare lo straccio. «Richiede», la guardò con attenzione, «grande cautela».
Roya tirò su col naso, mise giù il temperino e raddrizzò le spalle. «Non so cosa intenda per cambiare il mondo. Cammina troppo svelto. Non è molto educato. Fischietta senza motivo! Quando è venuto qui martedì scorso non le ha praticamente rivolto la parola. Si dà arie di importanza. Ha i capelli strani. Non saprei proprio come un ragazzo del genere cambierà il mondo».
«Grande», il signor Fakhri appoggiò entrambe le mani al bancone e si sporse verso di lei, «cautela».
Era stata avvertita. Vide Bahman in quel negozio in qualche altra occasione: ogni volta arrivava il martedì subito dopo la scuola come se sapesse che lei era lì. Ogni volta Roya fingeva di essere occupatissima a cercare in mezzo ai libri, a esaminare nuovi prodotti di cartoleria, a guardare ovunque tranne che nella sua direzione. Ogni volta, naturalmente, non poteva fare a meno di lanciargli un’occhiata, fino al quinto martedì, quando non riuscì più a sopportare il silenzio.
Con il pretesto di un dubbio su una poesia, si rivolse al signor Fakhri, che per qualche motivo non rispose, e fu il ragazzo a doverlo fare.
Il ragazzo che avrebbe cambiato il mondo riuscì a spiccicare: «Fuoco», in risposta alla sua domanda su quale parola veniva dopo nella strofa che aveva appena citato da una delle antiche poesie di Saadi.
Lei avvampò.
«Fuoco», ripeté il ragazzo.
Naturalmente aveva ragione e lo disse con tale sicurezza che Roya un po’ sperava che si sbagliasse e un po’ avrebbe voluto sedersi a parlare con lui per ore. Ma doveva andare; sua sorella la stava aspettando.
Quando Roya le andò incontro, Zari era di pessimo umore. Era diventata sorda a furia di ascoltare tutti i manifestanti, si lamentò, mentre sua sorella si gingillava con matite e libri in quell’inutile negozio. Disse che aveva bisogno di tornare a casa e mettersi a letto con una bottiglia di acqua calda perché aveva crampi mestruali dolorosissimi e stava morendo di fame, era rimasta lì ad aspettarla per ore, e Roya non poteva proprio imparare a rispettare il tempo degli altri, tanto per cambiare? Roya ascoltò le lamentele per tutto il tragitto fino a casa, ma continuò a guardarsi attorno chiedendosi quando, e se, avrebbe rivisto quel ragazzo in qualche altro posto che non fosse la Cartoleria.
2013
Roya appoggiò la testa al vetro del finestrino dell’auto e guardò passare il New England, imperturbabile nella morsa del gelo.
Avrebbe voluto concentrarsi su Walter e su quanto sarebbe stato piacevole cenare insieme. Aveva intenzione di preparare i bastoncini di pesce che lui adorava. Avrebbe voluto dimenticare il ragazzo, la visita che aveva appena fatto al centro.
«Oh, Walter», disse. E pianse.






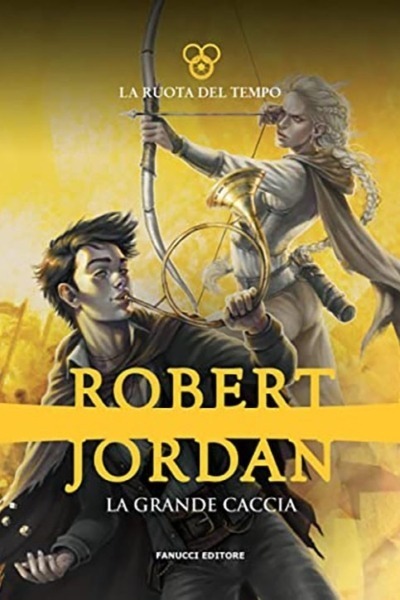

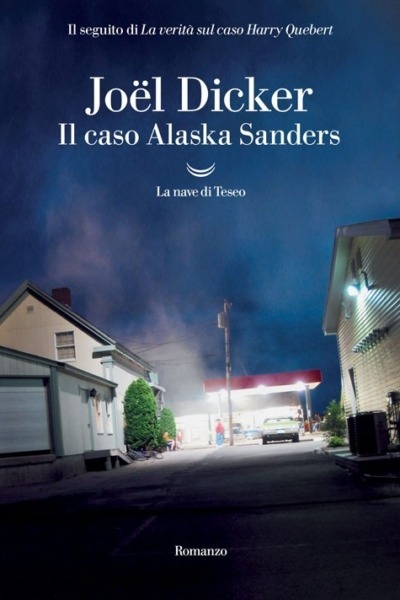
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.