Descrizione
1
Il maledetto ponte. Il miracolo. L’ululato
1
SONO sicuro di riuscire a raccontare questa storia. Sono altrettanto sicuro che nessuno ci crederà. Per me va bene così. Mi basta poterla raccontare. Il mio problema – e sono certo che ce l’hanno molti scrittori, non solo i novellini come me – è decidere da dove cominciare.
All’inizio ho pensato di partire dal capanno, perché è lì che sono iniziate veramente le mie avventure, ma poi mi sono reso conto che avrei dovuto parlare in primo luogo del signor Bowditch, e di come è nato il nostro legame. Ma questo legame non si sarebbe mai venuto a creare se non fosse stato per il miracolo che è accaduto a mio padre. Un miracolo molto ordinario, direte voi, e che è successo a diverse migliaia di uomini e di donne dal 1935 in avanti, però a un ragazzino com’ero allora è sembrato comunque un miracolo.
Ma anche questo non è il punto giusto da cui partire, perché non credo che mio padre avrebbe avuto bisogno di un miracolo se non fosse stato per quel maledetto ponte. Perciò è da lì che devo iniziare: dal maledetto ponte di Sycamore Street. E adesso, ripensandoci, vedo un filo molto chiaro che, nel corso degli anni, porta dritto al signor Bowditch e al capanno chiuso a chiave dietro la sua vecchia e decrepita casa vittoriana.
Ma un filo si può spezzare in qualunque momento. Perciò, più che di un filo, parlerei di una catena. Bella forte. E io ero il ragazzino con l’anello stretto intorno a un polso.
2
Il Little Rumple scorre nella parte nord di Sentry’s Rest (meglio nota ai locali come Sentry) e fino al 1996, l’anno in cui sono nato, era attraversato da un ponte di legno. Fu in quell’anno che gli ispettori del Dipartimento trasporti e viabilità lo controllarono e dichiararono che non era sicuro. La gente che abitava nella nostra zona lo sapeva sin dall’82, disse mio padre. Teoricamente, il ponte poteva sopportare un peso di quattro tonnellate e mezza, ma gli abitanti di Sentry, se guidavano un furgone a pieno carico, preferivano evitare di attraversarlo e optavano per l’autostrada: una deviazione non da poco, e una vera seccatura. Mio padre sosteneva che si potevano sentire le tavole di legno tremare e vibrare anche se ci passavi sopra con la macchina. Era un ponte pericoloso, gli ispettori su questo avevano ragione da vendere, ma qui sta l’ironia della sorte: se quel vecchio ponte di legno non fosse stato rimpiazzato da un ponte d’acciaio, forse mia madre sarebbe ancora viva.
Il Little Rumple è veramente piccolo, e non ci volle molto a tirar su il nuovo ponte. Quello di legno venne demolito, e il sostituto venne aperto al traffico nell’aprile del 1997.
«Il sindaco ha tagliato il nastro, padre Coughlin ha benedetto quel maledetto arnese, e buonanotte ai suonatori», disse mio padre una sera in cui era decisamente sbronzo. «Be’, come benedizione ha fatto un po’ schifo, non trovi, Charlie?»
Lo avevano chiamato Frank Ellsworth Bridge, in nome di un eroe locale che era morto in Vietnam, ma per la gente del posto era semplicemente il ponte di Sycamore Street. Sycamore Street era asfaltata come Dio comanda, liscia su ambedue i sensi di marcia, ma la pavimentazione del ponte – lungo meno di cinquanta metri – consisteva in una grata d’acciaio che produceva un ronzio quando ci passava sopra un’auto e un rombo vero e proprio quando toccava a un camion. E i camion ci passavano eccome, perché adesso il carico autorizzato era salito addirittura a ventisette tonnellate. Certo, il ponte non era abbastanza largo per un autoarticolato, ma, del resto, gli autoarticolati non ci passavano proprio, da Sycamore Street.
Ogni anno, durante le riunioni del consiglio comunale, si parlava di asfaltarlo e di aggiungere almeno un marciapiede, ma, a quanto pareva, c’erano sempre questioni più urgenti per cui spendere i soldi che sarebbero serviti. Non credo che un marciapiede avrebbe salvato mia madre, ma una nuova pavimentazione forse sì. Non c’è modo di saperlo, comunque, giusto?
Quel maledetto ponte.
3
Abitavamo più o meno a metà della collina di Sycamore Street, a quattrocento metri circa dal ponte. Sul lato opposto c’era una piccola stazione di servizio con negozio annesso, che si chiamava Zip Mart. Vendeva la solita roba, dall’olio per motori al pane in cassetta e alle merendine, ma anche il pollo fritto cucinato dal proprietario, il signor Eliades (che tutti, nel quartiere, chiamavano Mr Zippy). Il pollo era esattamente ciò che proclamava il cartello in vetrina: IL MIGLIORE IN CIRCOLAZIONE. Ricordo ancora quanto fosse gustoso, ma non ne ho più assaggiato nemmeno un boccone da quando mia madre è morta. Se ci avessi provato, sono sicuro che mi si sarebbe rivoltato lo stomaco.
Un sabato di novembre del 2003 – dopo che il consiglio comunale aveva discusso per l’ennesima volta di pavimentare il ponte per poi rimandare le migliorie all’anno successivo – mia madre decise di andare a piedi da Zippy per prendere del pollo fritto per cena. Io e mio padre stavamo guardando una partita di football del campionato universitario.
«Dovresti prendere la macchina», disse papà. «È prevista pioggia.»
«Ho bisogno di fare un po’ di moto», ribatté mamma. «Vorrà dire che mi metto l’impermeabile di Cappuccetto Rosso.»
E indossava proprio quello, l’ultima volta che la vidi. Non aveva tirato su il cappuccio perché non stava ancora piovendo, perciò i capelli le scendevano sulle spalle. Avevo sette anni, ed ero convinto che mia madre avesse i più bei capelli rossi che esistessero al mondo. Mi vide che la guardavo dalla finestra e mi salutò con la mano. Io risposi al saluto, poi tornai a concentrarmi sulla tv, dove la LSU era in vantaggio. Vorrei tanto essermi soffermato più a lungo su mamma, ma non mi colpevolizzo per non averlo fatto.
Non si può mai sapere quali trappole ti riserva la vita, giusto? Non è stata colpa mia, e non è stata neanche colpa di mio padre, anche se so che invece si è sentito responsabile, e ha pensato chissà quante volte: Se solo avessi alzato il culo dalla poltrona e le avessi dato un passaggio fino a quel maledetto negozio. E probabilmente non è stata neanche colpa dell’uomo che guidava il furgone da idraulico. La polizia ha detto che era sobrio, e lui ha giurato che stava rispettando il limite di velocità, che nel nostro quartiere era di quaranta chilometri orari. Papà sosteneva che, se anche le cose stavano così, quell’uomo doveva aver distolto lo sguardo dalla strada, anche solo per pochi secondi. E probabilmente papà aveva ragione. Era un perito assicurativo e una volta mi ha detto che l’unico evento accidentale di cui avesse mai sentito parlare era quello capitato a un uomo in Arizona, che era stato centrato in testa da un meteorite ed era morto sul colpo.
«C’è sempre un responsabile», mi disse una volta. «Ma responsabile non è sinonimo di colpevole.»
«Sei arrabbiato con l’uomo che ha investito mamma?» gli chiesi.
Ci pensò su, prima di rispondere. Portò il bicchiere alle labbra e mandò giù un sorso. Mamma era morta da sette od otto mesi, e lui aveva quasi smesso di bere birra. Ormai, si era dato al Gilbey’s.
«Cerco di evitarlo. E di solito ci riesco, ma non quando mi sveglio alle due di notte in un letto vuoto. Allora sì che lo maledico.»
4
Mamma si avviò giù per la collina. C’era un cartello nel punto in cui il marciapiede finiva. Lo oltrepassò e attraversò il ponte. Ormai stava facendo buio, aveva cominciato a piovigginare. Entrò nel negozio, e Irina Eliades (che ovviamente tutti chiamavano Mrs Zippy) le disse che il pollo sarebbe stato pronto in tre minuti, cinque al massimo. Da qualche parte in Pine Street, non lontano da casa nostra, l’idraulico aveva appena finito il suo ultimo intervento del sabato e stava sistemando la cassetta degli attrezzi sul pianale del furgone.
Il pollo uscì, bello caldo, croccante e dorato. Mrs Zippy ne preparò una confezione da otto pezzi e diede a mamma un’ala in più, da mangiare sulla via del ritorno. Mamma la ringraziò, pagò e si fermò a guardare l’espositore con le riviste. Se non lo avesse fatto forse sarebbe riuscita ad attraversare indenne il ponte: chi può saperlo? Il furgone dell’idraulico doveva aver appena svoltato in Sycamore Street per poi cominciare la discesa di un chilometro e mezzo lungo la collina mentre mamma sfogliava l’ultimo numero di People.
Lo rimise sulla rastrelliera, aprì la porta e disse a Mrs Zippy, senza nemmeno voltarsi: «Buona serata». Forse ha lanciato un grido quando si è accorta che il furgone stava per investirla, e Dio solo sa che cosa le sia passato per la mente, ma quelle sono state le ultime due parole che ha pronunciato, prima di uscire. La pioggia si era fatta fredda e fitta: una trama di linee argentate sotto la luce dell’unico lampione su quel lato del ponte.
Mordicchiando la sua ala di pollo, mia madre cominciò a camminare sulla grata d’acciaio. I fari la illuminarono, proiettando la sua ombra ben oltre le sue spalle. L’idraulico superò il cartello sul lato opposto, con la scritta: LA SUPERFICIE SUL PONTE GHIACCIA PRIMA DELL’ASFALTO! GUIDARE CON PRUDENZA!
Stava guardando lo specchietto retrovisore? O controllando il telefono per vedere se c’erano messaggi? Ha risposto di no a entrambe le domande, ma se penso a ciò che è successo quella sera mi tornano sempre in mente le parole di mio padre, quando sosteneva che l’unico evento accidentale del quale fosse a conoscenza era quello dell’uomo colpito in testa da un meteorite.
C’era spazio in abbondanza; il nuovo ponte era decisamente più largo rispetto alla versione in legno. Il problema erano le grate. L’idraulico vide mia madre a metà del ponte e frenò, non perché andasse troppo veloce (o così ha dichiarato), ma per puro istinto. L’acciaio aveva cominciato a ghiacciare. Il furgone slittò e sbandò, per poi mettersi di sbieco. Mia madre si schiacciò contro il parapetto, lasciando cadere l’aletta di pollo. Il furgone continuò a scivolare e la colpì, sbattendola come una trottola. Non voglio pensare alle parti del suo corpo che furono dilaniate in quelle giravolte mortali, ma a volte non riesco a evitarlo. So solo che il muso del furgone alla fine la spedì contro uno dei montanti del ponte, non lontano dallo Zip Mart. Una parte di lei precipitò nel Little Rumple, ma il grosso rimase sul ponte.
Ho una foto mia e di mamma nel portafogli. Avevo forse tre anni quando è stata scattata. Lei mi tiene su un ginocchio, e io ho una mano infilata tra i suoi capelli. Erano bellissimi.
5
Un vero Natale di merda, quell’anno. Potete credermi.
Ricordo il ricevimento dopo il funerale. Si tenne a casa nostra. Mio padre era lì che salutava le persone e accettava le loro condoglianze, poi sparì. Chiesi a suo fratello, lo zio Bob, dove fosse finito. «Ha dovuto stendersi un po’», mi rispose. «Era veramente esausto, Charlie. Perché non esci e vai a giocare in giardino?»
Non avevo mai avuto meno voglia di giocare in vita mia, ma uscii lo stesso. Passai accanto a un gruppetto di adulti che erano andati a fumarsi una sigaretta e sentii uno di loro dire: «Poveraccio, è ubriaco marcio». Perfino in un momento come quello, travolto dal dolore per la morte di mia madre, capii subito di chi stessero parlando.
Prima che mamma morisse, mio padre era quello che definirei un «normale bevitore». Ero un bambino che frequentava la seconda elementare, perciò immagino che dobbiate prendere quest’affermazione con il beneficio del dubbio, ma rimango ancora oggi della mia idea. Non l’avevo mai sentito biascicare, non incespicava per casa, non frequentava i bar e non aveva mai sfiorato con un dito me o mia madre. Tornava a casa con la sua valigetta e mamma gli preparava un drink, di solito un martini. Ne prendeva uno anche lei. Magari la sera, mentre guardavamo la televisione, si beveva un paio di birre, ma nient’altro.
Tutto cambiò dopo quel maledetto ponte. Era ubriaco dopo il funerale (marcio), ubriaco a Natale e ubriaco a Capodanno (che, come ho scoperto in seguito, la gente come lui chiama la «Serata del Dilettante»). Nelle settimane e nei mesi che seguirono la morte di mamma, era quasi sempre ubriaco. Beveva soprattutto in casa. Continuava a non frequentare i bar la sera («Troppi stronzi come me in giro», mi disse una volta), e non mi sfiorava neanche con un dito, ma non era più in grado di controllarsi. Adesso ne sono consapevole; allora mi limitai ad accettare lo stato delle cose. Capita spesso, ai bambini. E anche ai cani.
Mi ritrovai a prepararmi la colazione da solo due volte la settimana, poi quattro, infine quasi tutti i giorni. Mangiavo i miei cereali, Alpha-Bits o Apple Jacks, in cucina, e lo sentivo russare in camera da letto: sembrava una barca a motore. Ogni tanto si scordava di farsi la barba prima di andare al lavoro. Dopo aver cenato (quasi sempre con roba da asporto), gli nascondevo le chiavi della macchina. Se doveva comprare un’altra bottiglia, poteva sempre andare a piedi da Zippy e procurarsene una. A volte mi preoccupavo che potesse incrociare un’auto su quel maledetto ponte, ma non più di tanto. Trovavo impossibile (quasi impossibile, almeno) che entrambi i miei genitori potessero essere cancellati dalla faccia della terra nello stesso luogo. Mio padre lavorava nel ramo assicurativo, e sapevo in cosa consistessero le tavole attuariali: puro calcolo delle probabilità.
Era bravo nel suo lavoro, mio padre, ed era riuscito ad arrangiarsi per più di tre anni, nonostante l’alcol. Aveva avuto dei richiami? Non lo so, ma è possibile. Era stato fermato per guida pericolosa, dopo aver iniziato a bere anche di pomeriggio? Se è accaduto, forse l’hanno lasciato andare con una ramanzina. Diciamo pure che è probabile, perché conosceva tutti i poliziotti in città. Trattare con loro faceva parte del suo lavoro.
Le nostre vite seguivano un loro ritmo durante quei tre anni. Forse non un buon ritmo, non di quelli che ti fanno venire voglia di ballare, ma comunque uno sul quale poter contare. Tornavo a casa da scuola verso le tre. Mio padre rientrava intorno alle cinque, con un bel po’ di alcol nello stomaco e nell’alito (non andava in giro per bar la sera, ma ho scoperto in seguito che si fermava regolarmente alla Duffy’s Tavern, tornando dall’ufficio). Portava una pizza, dei tacos o cibo cinese comprato da Joy Fun. Qualche sera se ne dimenticava e ordinavamo da casa… o, meglio, ero io a farlo. E dopo cena cominciava a bere sul serio. Soprattutto gin. O altri alcolici, se il gin era finito. Ogni tanto si addormentava davanti alla televisione. Altre volte si trascinava in camera da letto, lasciando che fossi io a mettere a posto le scarpe e la giacca spiegazzata. Capitava anche che mi svegliassi e lo sentissi piangere. Mi faceva un gran brutto effetto, nel cuore della notte.
Il disastro avvenne nel 2006. Era estate. Avevo giocato una partita di campionato alle dieci del mattino ed ero andato benissimo: due fuoricampo e una presa al volo clamorosa. Rincasai subito dopo mezzogiorno e trovai mio padre già lì, seduto sulla sua poltrona a guardare la televisione: due star del cinema dei bei tempi andati duellavano sulle scale di un castello. Era in mutande e stava bevendo un liquido bianco che, dall’odore, mi parve Gilbey’s liscio. Gli chiesi che cosa ci facesse a casa.
Continuando a guardare gli spadaccini in azione e senza quasi biascicare mi rispose: «Sembra proprio che abbia perso il lavoro, Charlie. Ovvero, se posso citare Bobcat Goldthwait, so dov’è, ma c’è qualcun altro che lo sta facendo al posto mio. O che lo farà tra non molto».
Credevo che non avrei saputo cosa dire, ma le parole mi uscirono ugualmente di bocca. «Perché bevi.»
«Ho deciso di smettere.»
Mi limitai a indicare il bicchiere che teneva in mano. Poi andai in camera mia, chiusi la porta e scoppiai a piangere.
Dopo poco lo sentii bussare. «Posso entrare?» Non risposi. Non volevo che mi sentisse piagnucolare. «Dai, Charlie. L’ho versato tutto nel lavello.»
Come se non sapessi che il resto della bottiglia era sul bancone della cucina. E che ce n’era un’altra nel mobiletto dei liquori. O due. O tre.
«Avanti, Charlie, di’ qualcosa.» Qualcoscia. Non sopportavo quel biascichio.
«Vaffanculo, papà.» Non gli avevo mai detto una cosa del genere in vita mia, e avrei quasi voluto che entrasse e mi tirasse un ceffone. O che mi abbracciasse. Che facesse qualcosa, insomma. Invece lo sentii trascinarsi in cucina, dove c’era la sua bottiglia di Gilbey’s ad aspettarlo.
Quando uscii dalla mia stanza, dormiva sul divano. La tv era ancora accesa, ma con il volume azzerato. C’era un altro film in bianco e nero, con delle vecchie auto che correvano intorno a quello che era palesemente un set cinematografico. Quando beveva, papà guardava sempre i film sul canale TCM, a meno che io non fossi a casa e non insistessi per vedere qualche altro programma. La bottiglia era sul tavolino, semivuota. Versai nel lavello il poco che rimaneva. Aprii il mobiletto dei liquori e pensai di fare lo stesso con tutto il resto, ma guardando il gin, il whisky, le bottigliette di vodka e il brandy al caffè mi sentii invadere da una profonda stanchezza. Non crederete mai che un ragazzino di dieci anni possa sentirsi stanco a tal punto, ma io lo ero.
Infilai un piatto precotto nel microonde – il pasticcio di pollo della nonna, il nostro cibo preferito – e lo svegliai. Si alzò a sedere, si guardò intorno come se non sapesse dove si trovava, poi cominciò a fare dei rumori orrendi che non avevo mai udito prima. Corse in bagno con una mano davanti alla bocca e lo sentii vomitare. Mi sembrava che non sarebbe mai finita, invece i conati cessarono. Il microonde tintinnò. Tirai fuori il pasticcio di pollo, usando i guanti da forno con le scritte BELLA CUCINA sul sinistro e CIBO DA RE sul destro – se dimentichi di usarli una volta quando tiri fuori dal forno qualcosa di bollente, puoi star certo che non ti succederà più. Ne distribuii un po’ in due piatti e mi spostai in salotto, dove papà era seduto sul divano, con il capo chino e le mani intrecciate dietro la nuca.
«Ce la fai a mangiare?»
Alzò gli occhi. «Forse. Se mi porti un paio di aspirine.»
Il bagno puzzava di gin e di qualcos’altro, forse salsa di fagioli, ma almeno era riuscito a vomitare dentro la tazza, e a tirare lo sciacquone. Spruzzai un po’ di deodorante, poi gli portai il flacone con le aspirine e un bicchiere d’acqua. Ne prese tre e posò il bicchiere dove prima c’era stata la bottiglia di gin. Mi guardò con un’espressione che non avevo mai visto prima, neppure dopo la morte di mamma. Odio doverlo dire, ma lo farò comunque perché è questo che pensai in quel momento: era l’espressione di un cane che ha appena cagato sul pavimento.
«Forse riesco a mangiare, se prima mi abbracci.»
Lo abbracciai e mi scusai per quello che avevo detto poco prima.
«Va bene così. Probabilmente me lo meritavo.»
Andammo in cucina e mangiammo tutto il pasticcio di pollo che ci riuscì di mandare giù, cioè non molto. Mentre sfregavamo i piatti nel lavello, mi disse che avrebbe smesso di bere, e quel fine settimana lo fece sul serio. Mi disse che da lunedì avrebbe cominciato a cercare un nuovo lavoro, ma non lo fece. Rimase a casa a guardare i vecchi film sul canale TCM e, quando tornai dagli allenamenti di baseball e dalla nuotata di mezzogiorno alla YMCA, era ubriaco fradicio.
Si accorse che lo stavo guardando e scosse il capo. «Domani. Domani. Te lo prometto.» «Dici solo stronzate», ribattei, prima di andarmene in camera.


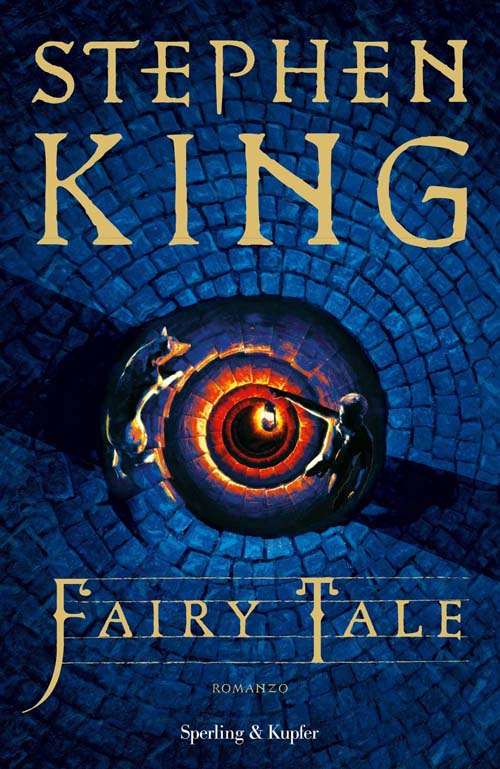
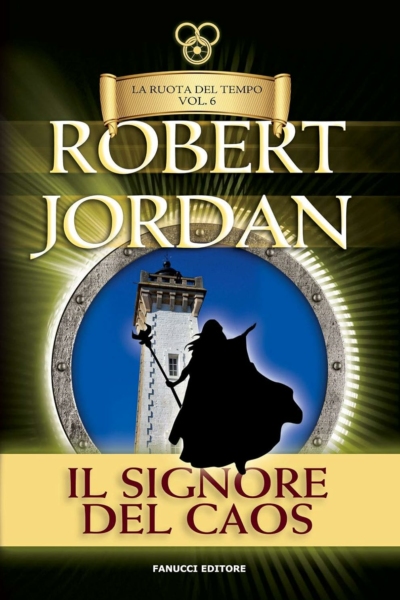
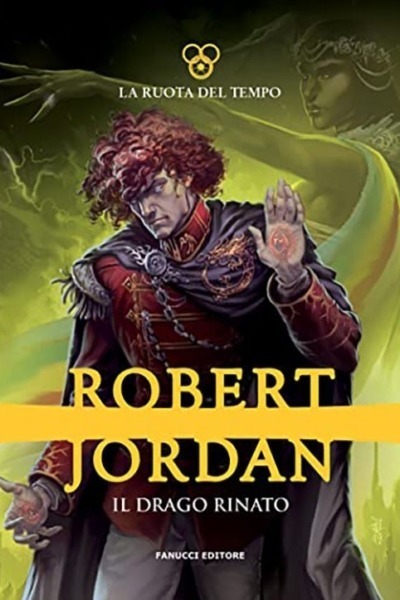
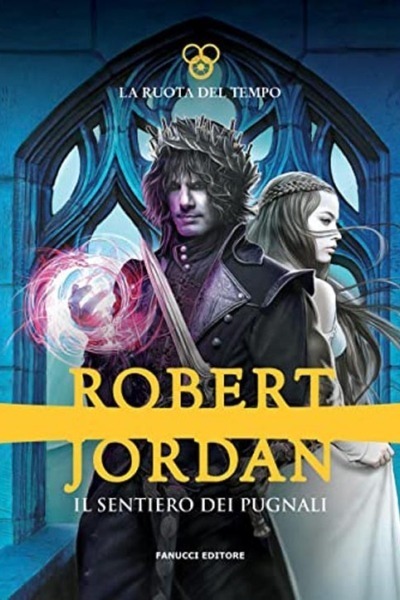
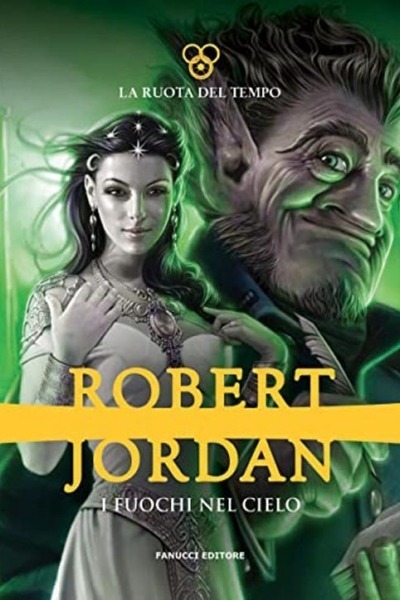


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.