Descrizione
Austria, 1978
C’era una leggenda che gravava su quel posto. Una di quelle che si appiccicano ai luoghi come un odore persistente. Si diceva che in autunno inoltrato, prima che le piogge si tramutassero in neve, il lago alpino esalasse respiri sinistri.
Uscivano come vapore dall’acqua e risalivano la china insieme alla bruma del mattino, quando la gora rifletteva il cielo. Era il paradiso che si specchiava nell’inferno.
Allora si potevano sentire sibili lunghi come ululati, che avvolgevano l’edificio del tardo Ottocento, sulla riva est.
La Scuola. Lo chiamavano così, giù in paese, ma quelle mura avevano mutato destino e nome diverse volte nel tempo: residenza di caccia imperiale, comando nazista, preventorio antitubercolare infantile.
Ora nei corridoi c’erano solo silenzio e pareti scrostate, stucchi sbiaditi ed echi di passi solitari. E poi, a novembre, quegli ululati che sgorgavano dalla nebbia e si arrampicavano lungo le finestre dei piani più alti, fino al tetto spiovente che luccicava di brina.
Le leggende, tuttavia, si addicono solo ai bambini e ai vecchi malinconici, a cuori troppo teneri. Lo sapeva bene Agnes Braun. La Scuola era la sua casa da troppo tempo per lasciarsi impressionare da un gorgoglio notturno. Conosceva lo scricchiolio di ogni asse, di ogni tubatura arrugginita che correva nelle intercapedini delle pareti, sebbene la maggior parte dei piani ora fosse chiusa e le porte delle stanze sprangate con tavole e chiodi.
Da quando l’edificio era diventato un orfanotrofio, i fondi statali erano sempre più centellinati e nessun privato si faceva avanti per donare qualche spicciolo.
Agnes attraversò la cucina che si trovava nel piano interrato, tra i locali adibiti a dispensa e la lavanderia. Spingeva un carrello, destreggiandosi tra i recipienti che di lì a poche ore avrebbero sbuffato vapori unti. Era sola, in quell’ora che non era notte e nemmeno giorno. A farle compagnia, giusto l’ombra furtiva di un ratto e le sagome delle carcasse appese a frollare nell’ex ghiacciaia.
Si servì del montacarichi per raggiungere il primo piano, l’ala di cui era responsabile. Da qualche tempo, quell’incarico le provocava un disagio senza nome, come un malessere latente che non si decideva a scoppiare.
Il montacarichi cigolò accogliendo il suo peso e quello del carrello. Le catene e le funi iniziarono a stridere. La gabbia vibrò e cominciò a salire, per arrestarsi pochi metri dopo con uno scossone. Agnes aprì la rete metallica. Il corridoio del primo piano era un lungo nastro colorato di un azzurro polveroso, macchiato di umidità e costellato su un lato di finestroni a riquadri.
Un’anta sbatteva a intervalli regolari. La donna si allontanò dal carrello per andare a richiuderla. Il vetro era freddo e appannato. Lo pulì con una mano, disegnando una sorta di oblò. L’alba stava rischiarando il villaggio, giù a valle. I tetti delle case erano minuscole tessere color del piombo. Più su, a millesettecento metri sul livello del mare, tra l’abitato e la Scuola, la distesa immobile del lago si colorava di rosa tra la bruma. Il cielo invece era terso. Agnes sapeva, però, che il sole quel giorno non avrebbe scaldato la radura scoscesa. Ormai lo capiva non appena posava un piede fuori dal letto ed era assalita dall’emicrania.
La nebbia si stava sollevando per assorbire ogni cosa: la luce, i suoni, persino gli odori si impregnavano del suo umore stagnante, che sapeva di ossa. E dalle sue spire, che arrampicandosi sull’erba bruciata dal gelo sembravano prendere vita, si levarono i lamenti.
Il respiro dei morti, pensò Agnes.
Era il vento, il Buran, che soffiava violento da nord-est. Nato in steppe lontane, aveva percorso migliaia di chilometri fino a incunearsi nel canalone della valle, ringhiare contro gli argini del fiume, sotto la linea del bosco, agitarsi nelle golene e riemergere fischiando per poi infrangersi sulla parete di roccia.
Era solo il vento, si ripeté la donna.
L’orologio a pendolo dell’ingresso batté sei rintocchi. Si era fatto tardi, ma Agnes non si mosse. Sapeva che stava temporeggiando. E sapeva anche il perché.
Suggestione, si disse. È solo suggestione.
Strinse le mani attorno all’acciaio del portavivande. I contenitori tintinnarono quando si decise a muovere qualche passo verso la porta in fondo al corridoio.
Il Nido.
Un pensiero improvviso le provocò uno spasmo allo stomaco: era davvero un nido. Lo era diventato nelle ultime settimane. Brulicava di un lavorio sommesso, misterioso. Come un insetto operoso, preparava la muta. Agnes ne era certa, anche se non avrebbe saputo spiegare quello che stava accadendo in quella stanza. Non ne aveva fatto parola con nessuno, nemmeno con il direttore: l’avrebbe presa per pazza.
Infilò una mano nella tasca della divisa. Le dita sfiorarono la stoffa ruvida del cappuccio. Lo estrasse e se lo calò sul viso. Una retina sottile copriva anche gli occhi, velando il mondo esterno. Era la regola.
Entrò.
La stanza era immersa nel silenzio. La grossa stufa di ghisa accanto all’ingresso conservava ancora qualche brace e restituiva un tepore piacevole. I posti erano allineati in quattro file da dieci. Nessun nome sulle targhette distintive, solo numeri.
Non si udivano pianti né richiami. Agnes sapeva che cosa avrebbe visto se solo avesse guardato: occhi inespressivi, spenti.
In tutti i posti, tranne uno.
Ora che si era abituata al silenzio, poteva sentirlo: sgambettava là in fondo, acquistava forza. Si preparava. A cosa, non avrebbe saputo dirlo. Forse era davvero pazza.
Un passo dietro l’altro, si avvicinò al posto numero 39.
Contrariamente agli altri, il soggetto pulsava di vita. I suoi occhi, così particolari, erano attenti, guizzavano seguendo i suoi movimenti. Agnes sapeva che il soggetto cercava il suo sguardo oltre la rete del cappuccio. Lei lo distoglieva, in imbarazzo. Il soggetto numero 39 era cosciente della sua presenza, anche se non avrebbe dovuto.
La donna controllò che nessun inserviente si fosse affacciato alla porta e allungò un dito. E il soggetto morse, strinse la carne tra le gengive, con forza. Negli occhi, uno sguardo diverso: spiritato. Un breve lamento nervoso gli scivolò dalle labbra quando Agnes si ritrasse con un’imprecazione.
Ecco la sua vera natura, pensò lei. Carnivora.
Fu ciò che accadde un attimo dopo a convincerla che non potesse più tenere solo per sé certi pensieri.
I posti accanto a quello numero 39 non erano più muti. I respiri si erano fatti agitati, come se i soggetti stessero rispondendo a un richiamo. Il Nido brulicava.
Ma forse era solo suggestione.
1
Oggi
Il corvo giaceva a lato del sentiero, le piume dai riflessi violacei in disordine e il becco spalancato. Una macchia di sangue aveva impregnato la terra sotto il ventre gonfio, ma era già secca nonostante l’umidità del pomeriggio.
Chissà da quanto tempo la bestiola era lì, un occhio vitreo puntato sul cielo che prometteva neve, l’altro perso chissà dove.
Mathias lo osservava da un po’, piegato sulle ginocchia. Si era chiesto se le pulci avessero abbandonato il corpo non appena il cuore aveva cessato di battere. Un giorno lo aveva sentito dire a un cacciatore e quel particolare lo aveva tormentato a lungo. Lo trovava impressionante e affascinante al tempo stesso.
Toccò il corvo con la punta di un dito. Era un esemplare vecchio. Lo capì dal becco, nudo e bianco. Le zampette erano rigide, gli artigli robusti afferravano il nulla.
Si pulì subito il guanto sui pantaloni. Se lo avesse saputo suo padre, gli avrebbe mollato un ceffone. L’aveva sorpreso più volte a osservare le carcasse dei piccoli animali che trovava in giardino o nella pineta dietro casa e lo aveva rimproverato, usando una parola che Mathias non conosceva, ma che faceva pensare a qualcosa di brutto. Ne aveva cercato il significato nel dizionario. Non la ricordava, ma aveva a che fare con la pazzia.
Da grande Mathias voleva fare il veterinario e ogni occasione era buona per imparare. L’osservazione – gli aveva detto una volta il nonno – è già per metà apprendimento. Il resto è provare e riprovare ancora.
Il bambino si alzò, gli occhi fissi sull’animale. Avrebbe voluto seppellirlo, ma poi si disse che era giusto così: la natura era carnivora, aveva fame di quei resti che non sarebbero andati sprecati.
Le campane del duomo giù in paese batterono due rintocchi e mezzo. Era tardi, gli altri lo stavano aspettando nel luogo segreto.
Si incamminò lungo il sentiero ghiacciato. L’abitato di Travenì quella mattina si era risvegliato sotto una coltre di neve. Un’imbiancatura leggera, sciolta troppo presto, che però faceva ben sperare per la stagione sciistica alle porte.
Arrivò al promontorio poco fuori dal paese. Il monumento ai caduti delle guerre napoleoniche svettava tra i boschi più bassi di abeti rossi e pini. Il granatiere bronzeo scrutava l’orizzonte con cipiglio severo, i lunghi baffi rivolti all’insù. Dalla baionetta sventolava una sciarpa azzurra, indicando che qualcuno del gruppo si era già arrampicato fin lassù per appendere il segnale.
Mathias accelerò il passo. Quella mattina a scuola l’insegnante aveva spiegato il significato della parola «leader». Lui ne era rimasto affascinato. Gli piaceva come suonava – aveva un non so che di definitivo – ma soprattutto gli piaceva l’idea di essere una guida per gli altri.
Un leader protegge i suoi compagni, aveva detto la maestra, ed era proprio così che si sentiva Mathias. Era consapevole di essere il capo del gruppo, per i suoi amici, e non solo perché era il più grande – dieci anni, due mesi e una settimana quel giorno – ma perché su di lui si poteva contare.
Ecco perché la sciarpa appesa alla statua avrebbe dovuto essere la sua e non quella di Diego. Sarebbe dovuto arrivare prima e aprire la strada ai suoi compagni, anche se ormai l’avevano percorsa chissà quante volte. Invece si era attardato a scrutare dei resti animali al bordo di una strada. Forse aveva ragione suo padre.
Il promontorio del granatiere era circondato da pareti rocciose scoscese, a strapiombo sul letto di un torrente. Qualche decina di metri più sotto, l’acqua gorgogliava tra le fronde scure.
Mathias iniziò a scendere i ripidi tornanti del sentiero, saltando per guadagnare tempo e aggrappandosi alla staccionata che delimitava il percorso, quando i sassi ruzzolavano sotto le suole delle scarpe da ginnastica. Arrivò sul greto ghiaioso senza fiato, le ginocchia che tremavano e il viso in fiamme.
Seguì lo snodarsi della gola scavata nel corso dei millenni. Passatoie a sbalzo sull’acqua si alternavano a scale di ferro e legno aggrappate alle rocce. Tra le grate, il torrente aveva riflessi di smeraldo e profumava di ghiaccio. Nel fondo di quell’orrido, la luce e il tepore del sole non arrivavano quasi mai.
Mathias riusciva a udire il rumore del proprio respiro e quello del cuore nel petto e, di colpo, si accorse di essere solo. In quel periodo dell’anno i turisti preferivano le piste da sci: troppo freddo là sotto, oltre al rischio di cadere.
Accelerò il passo, senza sapere perché.
Sopra la testa, tra le cime puntute degli abeti, lo scorcio di cielo era attraversato dal ponte della vecchia linea ferroviaria ormai chiusa, a più di sessanta metri di altezza. Il nonno di suo nonno aveva partecipato ai lavori di costruzione, un secolo e mezzo prima.
Mathias, il naso all’insù, scivolò su un sasso coperto di ghiaccio e batté un ginocchio a terra. La sua esclamazione di sorpresa fu seguita da un rumore nel bosco. Un grido basso. Si voltò, il fiato corto.
«La foresta non è un posto per bambini.»
Le parole di sua madre iniziarono a danzargli nella mente.
Si rimise in piedi, senza controllare i danni ai jeans e ai palmi delle mani che bruciavano sotto la lana dei guanti. Attraversò una passatoia che girava attorno a una roccia sporgente. Muschio da una parte, mulinelli d’acqua dall’altra. Il sentiero proseguiva attraverso una piccola grotta. Mathias percorse quei pochi metri di buio correndo, dicendosi che era la fretta a spingere le sue gambe e non la paura. Quando spuntò dall’altra parte si fermò. Un raggio di sole bucava il verde e incendiava d’oro il sottobosco. La cascata che alimentava il torrente si gettava in un salto pauroso, spruzzando minuscole gocce d’acqua che in estate, quando la luce riusciva a raggiungere il fondo, si coloravano di arcobaleno.
Sulla spiaggia sassosa i suoi amici lo aspettavano seduti in cerchio. Lucia, Diego e Oliver.
Bastò quella visione a scacciare i timori. Un sorriso gli spuntò sulle labbra. Non c’era nessuno dietro di lui. Nessuno aveva seguito i suoi passi.
Scrutò ancora le tenebre della grotta, come per sfidarle. Aveva vinto lui, era davvero un leader. Ma poi il sorriso si smorzò, fino a sparire.
D’un tratto ne fu certo.
C’era qualcuno, nascosto nell’oscurità, e lo stava osservando.



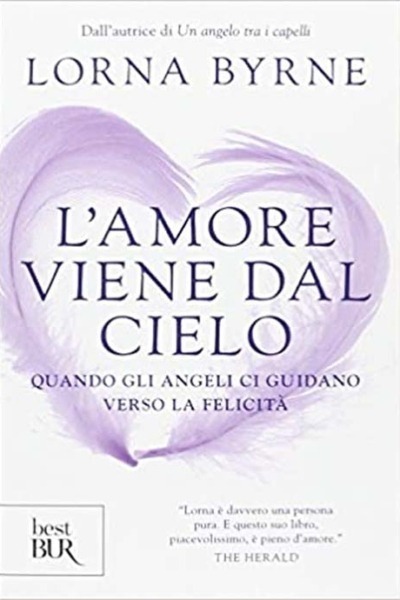




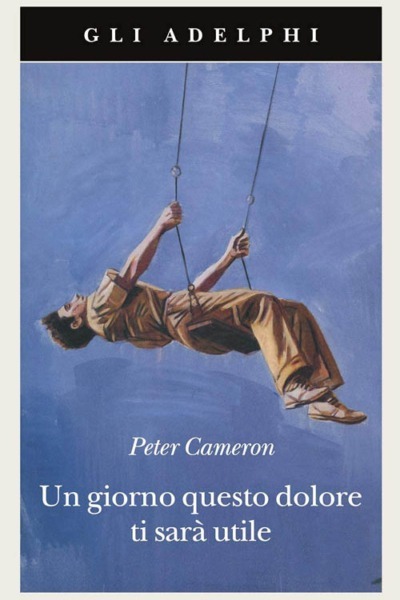
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.