Descrizione
L’incontro
Conobbi Bianca Idoia in una calda notte di agosto. Eravamo due estranei dentro il bar di un vetusto hotel che aveva visto giorni migliori; io ero di passaggio, lei era andata a prendere da bere, mentre da un giradischi seminascosto Julie London sussurrava “Cry me a river”, con la malinconia che le attanagliava la gola. Mi avvicinai al bancone e le offrii un altro bicchiere di qualunque cosa stesse bevendo, ma lei mi dedicò appena un lieve cenno del capo, senza nemmeno girarsi, mentre il suo sguardo si perdeva tra le bottiglie dello scaffale. Osservando con circospezione il suo riflesso nello specchio che avevamo davanti, notai che si trattava di una donna giovane e attraente, con i capelli biondi lunghi fino alle spalle e occhi castani, da cui traspariva un dolore altero e lontano, che sembrava voler fuggire oltre le pareti di quel locale. Eravamo seduti sui nostri sgabelli a nemmeno due palmi l’uno dal l’altra, ma in realtà lei si trovava ben più distante, persa nel tempo e nella memoria, e io mi sentivo come un naufrago che la osserva va allontanarsi come una vela all’orizzonte. Rassegnato, finii la mia birra sotto lo sguardo compassionevole del cameriere, lasciai qualche banconota sul bancone e, in silenzio, mi alzai da dov’ero seduto.
– Grazie per il drink – mormorò infine con voce stanca.
– Sorpreso, mi voltai e vidi i suoi occhi nello specchio, fissi su di rne – Di niente – risposi, tendendole la mano -.
Mi chiamo Fernando. Lei si girò sullo sgabello e, dopo avermi squadrato per qualche istante con quella noia che sembrava impregnare ogni suo gesto, mi strinse la mano con indifferenza.
Lei si girò sullo sgabello e, dopo avermi squadrato per qualche istante con quella noia che sembrava impregnare ogni suo gesto, mi strinse la mano con indifferenza.
– Mi chiamo Bianca – si presentò e, come se dovesse compilare un formulario, mi chiese subito dopo da dove venissi.
– Da Barcellona -risposi.
– E cosa ti porta da queste parti?
– Stavo per farti la stessa domanda.
Restò in silenzio per qualche istante, sbattendo ripetutamente le palpebre, quasi a manifestare il desiderio di lasciar cadere il discorso.
– Sono uno scrittore -balbettai, temendo che mi voltasse nuovamente le spalle. – Sono venuto a cercare idee per un nuovo romanzo.
– Scrittore? – ripeté con rinnovato interesse.
– Si…
– Un romanziere… in cerca del suo romanzo – borbottò, girandosi nuovamente verso il bancone e abbozzando un triste sorriso, mentre si portava il bicchiere alle labbra -.
Ti piacerebbe sentire una bella storia… una storia vera, per il tuo libro?
– Certo -affermai sinceramente, poggiando il gomito sul bancone.
– Allora ascoltami con attenzione -disse, avvicinando il suo viso al mio e abbassando la voce-, perché sto per raccontarti qualcosa che successe non molto tempo fa nel cuore dell’Africa.
Una storia di coraggio, amore, odio; una storia di… – restò in silenzio, di nuovo con lo sguardo perso, lasciando la frase sospesa nel limbo delle parole difficili da pronunciare -… una storia vera concluse prendendomi la mano-, che in certi momenti sembra sconfinare nella fantasia. Sto per raccontarti la mia storia.
E così fece. Mi raccontò la sua storia; la più straordinaria che io abbia mai sentito.
Mi sono limitato a scriverla parola per parola, così come lei me la narrò. Sono stato solo l’assorto tachigrafo di questo incredibile racconto. Un anello, come potreste esserlo voi una volta giunti all’ultima pagina di questo libro…anelli di una stessa catena.
Un passo in avanti su un cammino incerto, che solo il tempo rivelerà dove ci avrà portato.
1
—Signora Margherita! Sono rientrata! —esclamai, mentre aprivo la porta ridipinta color azzurro cielo.
Lasciai il mio piccolo zaino sul pavimento e mi affacciai nella cucina, convinta che l’avrei trovata, come al solito, intenta a preparare i suoi stufati e le fritture di pesce.
—Signora Margherita?— chiamai, sorpresa dal non trovarla lì, per la prima volta in quasi due mesi—. Dov’è andata?
Mi avvicinai al gabinetto, situato ad alcuni metri dal resto della casa e vigilato da una pelosa tarantola sistemata sulla parete bianca, che avevo ormai battezzato Matilde, dopo i lunghi momenti di intimità trascorsi insieme. Alla fine mi diressi verso il piccolo orto dietro la casa e poi tornai dentro, entrando nell’unica stanza in cui ancora non avevo guardato. Era lì. Nella semioscurità, abbandonata sul letto, con la vecchia camicia da notte appiccicata al corpo per via del sudore che si estendeva come una macchia persino sulle lenzuola.
Allarmata, aprii la finestra cercando di illuminare la stanza, e così la miriade di piccole goccioline di sudore, che imperlavano la sua pelle scura, rifletterono la luce della sera, e gli occhi della donna accennarono ad aprirsi con uno sforzo sovrumano per un corpo tanto esile e stanco.
—Bianca… —riuscì appena ad articolare.
—Sì, signora Margherita. Sono qui —risposi, prendendole la mano, cercando di mantenere la calma— Cosa le succede?
L’anziana si sforzò di sorridere, ma il dolore le impedì di compiere quel gesto.
—Sto morendo —gemette.
—Assolutamente no! Non lo pensi nemmeno! —protestai senza pensare— Ora prendo la jeep e la porto all’ospedale di Malabo-. Le poggiai la mano sulla fronte per sentire la temperatura e dovetti mordermi il labbro, per impedirmi di palesare il mio orrore nel percepire quanto scottava.
—È un attacco di malaria. Le abbasserò la temperatura con una doccia e poi via di corsa all’ospedale.
La presi in braccio, sorprendendomi per quanto fosse leggera: era come sollevare una bambina. Avevo sempre notato la sua magrezza, ma quando sentii la colonna vertebrale e le costole che quasi fuoriuscivano dalla pelle, fui per la prima volta cosciente della sua malata gracilità.
—Non si preoccupi, signora Margherita, presto starà meglio- dicevo a me stessa, più che a lei, mentre la signora si lasciava trasportare come un passerotto agonizzante.
La infilai sotto la doccia e stupidamente girai il rubinetto: erano decenni che non c’era acqua corrente nel Paese, e tanto meno lì, un piccolo villaggio di pescatori. Lasciai la signora seduta sul pavimento della doccia, incapace perfino di stare in piedi appoggiata alla parete. Mi avvicinai all’enorme bidone azzurro in cui conservavamo l’acqua e, dopo aver preso una piccola bacinella da terra, la riempii e iniziai a lasciarla cadere delicatamente sulla testa e il corpo dell’anziana, nell’inutile tentativo di far abbassare la sua temperatura di uno o due gradi.
La povera donna emetteva flebili lamenti, ma era incapace di articolare qualsiasi parola e fare il benché minimo movimento: si lasciava andare, forse consapevole che la sua vita non era già più nelle sue mani.
Non saprei dire quanto tempo passammo così. Lei abbandonata sul pavimento della doccia, io tentando disperatamente di rinfrescarla, alla tenue luce di una lanterna a petrolio appesa alla parete, visto che da un bel pezzo lì non arrivava nemmeno la luce elettrica. Alla fine, vedendo che non ottenevo alcun risultato con quella patetica bacinella di acqua tiepida, decisi di portarla, mettendole addosso giusto una vestaglia, all’ospedale di Malabo, ad un paio d’ore di viaggio su una strada disastrata.
La sistemai come potei sul sedile posteriore del Defender bianco, sulla cui portiera compariva l’adesivo azzurro dell’UNICEF, e schiacciai l’acceleratore, sapendo che ogni minuto perso lungo il tragitto poteva essere fondamentale per la sopravvivenza della povera donna, che agonizzava là dietro. Presi la strada che parte da Luba e costeggia la parte occidentale dell’isola, mentre il sole si tuffava nelle acque del Golfo di Guinea e in lontananza si intravedeva il bagliore delle innumerevoli piattaforme petrolifere, che negli ultimi anni erano comparse sul mare come nere candele su una torta.
La via era deserta e le luci del veicolo erano ogni momento più indispensabili, per seguire la strada sinuosa o schivare gli animali a cui piaceva dormire in mezzo alla carreggiata. Gli pneumatici del fuoristrada fischiavano nelle curve asfaltate, quando addirittura non derapavano pericolosamente, visto che un paio di volte fui sul punto di uscire di strada e cadere in mare. Intanto l’anziana aveva smesso di lamentarsi già da un po’, e questo non era certo un buon segno.
Improvvisamente, vidi la luce di una torcia che, ad un lato della strada, era puntata dritta verso di me, mentre i fari dell’auto illuminarono un tronco piazzato in mezzo alla carreggiata. Capii subito che si trattava di un agguato, o di un controllo di polizia, o di entrambe le cose allo stesso tempo, cosa tutt’altro che rara.
—Lasciatemi passare! -gridai dal finestrino- Trasporto una donna molto malata!
La persona che aveva in mano la torcia non rispose. Si limitò a illuminare l’interno del veicolo, dove la signora Margherita tremava rannicchiata sul sedile.
—Documenti —disse una voce autoritaria, senza identificarsi, ma che intuii essere di un militare o un poliziotto.
—Per favore-, insistetti- non c’è un minuto da perdere! Non vede che la signora sta per morire?
—Documenti— ripeté la voce, stavolta con tono più pressante.
—Accidenti! Porca puttana! Ecco i miei documenti! —Ma nel compiere l’automatico gesto di girarmi a prendere la borsa, che poggiavo sempre sul sedile del passeggero, mi resi conto con un tuffo al cuore, che questa si trovava ancora vicino all’entrata di casa, dove l’avevo lasciata quando ero arrivata.
Guardai verso la luce e, consapevole della vita che era nelle mie mani, decisi di abbassare il tono e cercare di uscirne il prima possibile.
—Mi scusi, nell’uscire di corsa per andare all’ospedale, ho lasciato il passaporto e i permessi a casa. Non ce li ho qui.
—Scenda dall’auto —fu l’aspra risposta che ottenni.
—Andiamo… —mormorai senza ancora aprire la portiera della macchina, cercando di risolvere quella situazione in qualche modo— So che dovrei avere tutti i documenti con me, e le chiedo scusa per l’errore, però devo giungere con urgenza all’ospedale di Malabo, altrimenti questa signora morirà. Se vuole, posso lasciarle il mio orologio a garanzia del fatto che poi tornerò e le porterò tutto ciò che mi chiede. È un orologio del valore di oltre cento euro —dissi mentre me lo toglievo dal polso e glielo passavo oltre il finestrino.
Una mano me lo strappo bruscamente dalle dita e lo illuminò con la torcia, lasciando intravedere un polsino verde militare. Poi di nuovo la luce venne puntata verso i miei occhi.
—Spagnola? – chiese la voce, come se fosse un insulto.
—Sì, spagnola. Lavoro per l’UNICEF, sto realizzando uno studio sul campo su…
—Sì… —mi interruppe— spagnola…e dove ha detto di essere diretta?
—All’ospedale di Malabo! Gliel’ho detto prima! —risposi senza riuscire a celare l’impazienza.
L’uomo con la torcia illuminò nuovamente il sedile posteriore, poi il portabagagli, le scritte sul lato della jeep e di nuovo i miei occhi.
—Va bene— disse con un tono che lasciava intuire che le chiacchiere erano finite—. Scenda dall’auto.
—Ma… —replicai confusa— l’orologio…
—Lo terremo come prova —rispose con una risatina—. Adesso scenda o la faccio scendere io
—Ma di cosa mi accusa? Perché? Non vede che la donna ha bisogno di cure immediate?
In quel momento la porta del veicolo si aprì violentemente e un paio di mani forti mi afferrarono un braccio e i capelli, e mi scaraventarono a terra senza nessuno scrupolo.
Sbattei contro la portiera e notai che un filo di sangue caldo cominciava a scendere dalla mia fronte mentre, ancora a terra, non potevo credere a ciò che mi stava succedendo.
—Mi ascolti! —tentai di dire con disperazione— Voi non vi rendete conto di ciò che state facendo! Sono una rappresentante dell’UNICEF e cittadina spagnola. Se mi farete del male o mi tratterrete illegalmente, i vostri superiori ve la faranno pagare! Capite quello che sto dicendo?
Non so se avessero capito, ma in risposta ricevetti una serie di grosse risate da parte di vari uomini che non riuscivo a vedere, e all’improvviso uno stivale militare comparse dall’ombra e mi colpì brutalmente la tempia. Persi conoscenza.
2
Non so bene quando riaprii gli occhi. So che c’era una piccolissima finestrella con una grata, dalla quale filtrava un timido raggio di luce che andava a stamparsi contro una sporca parete, quasi che anch’esso, come me, fosse giunto in quel luogo senza sapere come e non potesse fuggirne.
Ero in una cella. Una cella puzzolente, umida, buia e calda. Forse sarebbe meglio definirla semplicemente claustrofobica. La piccola prigione mi avrebbe permesso a mala pena di sdraiarmi a terra e aprire le braccia senza toccare le pareti, muri neri per la muffa in cui potevano notarsi, aguzzando la vista, centinaia di incisioni, suppliche o forse qualche addio; scritte una sull’altra, utilizzando a volte niente più che le proprie unghie.
C’era anche odore di feci e urine, che si aggiungeva a quello del sudore, che a sua volta si sommava a quello dell’umidità, rendendo ogni respiro un’esperienza ripugnante. Un’altra cosa che ricordo perfettamente è il mal di testa. Un fortissimo dolore nel punto esatto in cui quello stivale aveva impattato contro il mio cranio…il giorno prima? Non avevo la minima idea di quando fosse successo. In realtà non sapevo niente di niente. Né dove mi trovavo, né perché ero stata incarcerata, né tanto meno ciò che fosse successo alla signora Margherita. Ricordo anche di essermi sollevata, appoggiandomi alle pareti lerce, e aver gridato contro la porta metallica; e ricordo come il cervello sembrasse in procinto di scoppiare, sentendo l’eco della mia stessa voce nella testa. Ricordo me stessa mentre colpivo inutilmente quella porta arrugginita, dandole calci con i piedi scalzi, maledicendo quel pezzo di ferro come se fosse stato il diretto colpevole di quella situazione. Ricordo il dolore. Ricordo la disperazione…indubbiamente ricordo più di quanto vorrei.
Alla fine, esausta, mi arresi alla stanchezza e all’evidenza che nessuno mi sentiva, o che a nessuno importava ciò che stessi o non stessi facendo. Dall’oscurità della mia cella, cercavo di prestare attenzione a qualsiasi rumore venisse dal di fuori, come se ciò mi confermasse che c’era qualcuno là e, in qualche modo, alimentasse l’assurda speranza che si ricordassero di me.
Durante le prime ore di prigionia cercavo di farmi forza, immaginando che da un momento all’altro si sarebbe aperta la porta metallica e sarebbe comparso un tipo elegante a chiedermi scusa per il malinteso, assicurandomi tra mille riverenze che sarei potuta andar via in qualsiasi istante. Sfortunatamente, quell’illusione stava perdendo terreno con il passare delle ore tra quelle pareti sporche; mi trovavo in Guinea Equatoriale da abbastanza tempo, per sapere come funzionavano le cose in quel disgraziato Paese. Però non ci volevo pensare, perché se lo avessi fatto sarei caduta in preda all’ansia e ad un terrore tale, che tutto il mio corpo sarebbe stato assalito da un’incontenibile nausea.
Ero atterrata qualche settimana prima nel terminal appena inaugurato dell’aeroporto di Malabo, e la prima cosa a darmi il benvenuto fu una raffica calda che, dopo aver lasciato ore prima la città di Vitoria sotto un cielo plumbeo, mi sembrò quasi un benvenuto in paradis
o. Con il passare dei giorni scoprii che quella prima boccata d’aria calda, in realtà, proveniva direttamente dall’inferno. Nella cella opprimente, dove il tempo sembrava fermarsi (un paio di volte diedi involontariamente un’occhiata al mio polso sinistro, dove ora c’era solo una striscia di pelle candida), ebbi il tempo di ripensare ai miei genitori che mi salutavano in aeroporto, pregandomi all’orecchio, mentre mi abbracciavano, di fare molta attenzione.
—Tranquilli… —avevo risposto—, a Malabo mi aspetta un funzionario dell’UNICEF, e godrò del suo appoggio mentre starò lì. Vado solo a fare una ricerca sulla popolazione infantile nell’area rurale, e ho un salvacondotto del governo guineano. Cosa potrebbe succedermi?
Quasi mi scappava un’amara risata, nel ricordarmi quelle parole. Mentre ripensavo a quel momento, mi accorsi che all’esterno l’attività stava aumentando. Per l’eco che mi arrivava di alcune voci, dedussi che oltre la finestrella doveva esserci un cortile, dove alcuni uomini davano ordini mentre altri gemevano e supplicavano clemenza in perfetto castigliano. Probabilmente ero confinata in una sorta di commissariato o di area militare, e quelli erano uomini e donne reclusi come me.
Forse, proprio come me, detenuti arbitrariamente e portati a… E la porta si aprì. Cigolando sui cardini, la pesante porta di ferro sembrò sbadigliare fino a fermarsi contro la parete alla sua destra: un rettangolo di luce diffusa mi permise di vedere il profilo di un uomo basso, grasso e con un berretto militare sul capo. Sconcertata, feci un passo indietro. Era da ore che aspettavo che quella porta si aprisse, ma ora provai paura, molta paura. Come un animale spaventato nella sua tana, non volevo uscire da quella cella, per ripugnante che fosse. Mi rifugiai contro la parete in fondo, cercando di rendermi invisibile a quella siluetta dagli occhi fiammeggianti.
—Portatela fuori —ordinò con voce roca e autoritaria. Quindi l’uomo grasso si girò e usci dalla mia vista; immediatamente, irruppero due soldati più giovani, che senza alcuno scrupolo mi legarono le mani dietro la schiena con una briglia di plastica e, afferrandomi un braccio ciascuno, mi trascinarono fino a portarmi fuori dalla stanza. Invece di darmi la possibilità di mettermi in piedi, preferivano farmi strisciare a terra come un peso morto, facendomi terribilmente male a gomiti, spalle, piedi e collo.
—Per favore! —gridai—. Lasciate che mi metta in piedi, vi supplico! Mi state facendo molto male! L’unica risposta fu una perfida risatina da parte di entrambi. Alla fine del corridoio incrociammo una nuova porta, vicino alla quale un altro soldato, seduto su una sedia, mi rivolse uno sguardo che volli credere fosse di compassione…anche se forse era solo di indifferenza. Una volta attraversato quest’ultimo varco, mi ritrovai nel cortile che avevo immaginato prima.
Circondato da alti muri e recinzioni di filo spinato, aveva piccoli faretti che dall’alto illuminavano una scena che, dal punto in cui mi trovavo, con la testa girata a pochi palmi dal suolo, all’inizio non riuscii a capire; o forse, semplicemente, la mia mente si rifiutava di accettarla. Vari soldati formavano una sorta di corridoio e, in mezzo, due corpi sembravano lottare al suolo, aizzati dagli uomini che stavano in piedi. Solo quando mi arrivò all’orecchio l’urlo atterrito di una donna, compresi ciò che in realtà stavo vedendo. Non riuscii a trattenere un grido di orrore. Immediatamente, uno dei soldati che mi trascinava capì cosa stavo guardando e, chinando il volto fino a metterlo all’altezza del mio, rise lascivamente, mostrando una giallastra fila di denti sporchi.
—Ti piace, puttana? Andiamo a vederlo più da vicino… Il mio timore si convertì in panico assoluto, e disperatamente cercai di liberarmi dalla presa di quei due uomini, rigirandomi nell’inutile sforzo di mettermi in piedi. Quindi, il soldato che mi teneva il braccio sinistro, senza pensarci due volte mi diede un calcio alla bocca dello stomaco, facendomi vomitare bile amara. Attraversammo il cortile, e il capannello ululante di soldati si spostò affinché potessi contemplare la terribile scena in prima fila.
Trattenuta per le braccia dai miei detentori, mi trovai faccia a faccia con una donna che veniva violentata. Un brivido percorse la mia schiena quando scoprii che la presunta donna non era altro che una ragazzina di quattordici o quindici anni. Gli occhi le uscivano dalle orbite per il terrore puro. Grida supplicanti uscivano dalla sua bocca insanguinata, ed io non riuscivo nemmeno a sostenere il suo sguardo perso, distogliendo il mio da quell’indescrivibile sofferenza, mentre la violentavano brutalmente più e più volte, nuda, gettata sul cemento sporco del cortile come una bambola di stracci, strappati da mostri che non smettevano di colpirla, tra insulti e sputi.
L’avevano mutilata, tagliandole parte delle orecchie, marchiandola come una bestia, e sui suoi seni potevo vedere piccole ferite aperte attorno ai capezzoli, con la forma che avrebbero lasciato dei denti nel mordere la carne. Ma la cosa peggiore, l’indescrivibile atto disumano che mi accompagnerà per il resto delle mie notti da incubo, fu quando uno di quelli che aspettava il suo turno per stuprarla, prese dalla sua tasca posteriore una volgare forchetta e, abbassandosi senza preavviso, la conficcò selvaggiamente nella vagina della ragazza, che gridò di dolore come non avevo mai sentito gridare nessuno prima, tra le sadiche risate dei suoi violentatori.
Anche io volevo gridare, ma nessun suono uscì dalla mia gola. Chiusi gli occhi con tutte le mie forze, cercando di sfuggire da quella cacofonia di urla disumane di dolore e follia; ma quegli orrendi ululati penetrarono i miei timpani fino al più profondo della mia memoria, e gli occhi sconvolti dal dolore della vittima si marcarono a fuoco nella mia retina, come cicatrici che mai scompariranno. Benché ne fossi praticamente convinta, io non fui la successiva.
Sentii che i soldati discutevano tra loro su cosa dovessero fare con me, finché uno di quelli che mi tratteneva pose fine al dibattito, chiarendo che il capitano mi stava aspettando nella stanza degli interrogatori e che avrebbero avuto il tempo per divertirsi con me dopo. E di nuovo venni trascinata per il cortile come un animale morto, fin quando una nuova porta si aprì. Entrammo in una stanza di cui riuscivo solo a vedere il suolo che scorreva davanti al mio volto, poi i due soldati mi sollevarono di peso fino a lasciarmi cadere su una sedia di legno inchiodata al suolo.
Vedevo le dita dei miei piedi scalzi sanguinare per aver strisciato per terra, e mi accorsi che una delle unghie del piede destro era scomparsa, per lasciar emergere una superficie di carne sanguinolenta. Mi facevano terribilmente male, e avrei voluto distogliere lo sguardo, ma il calcio che mi avevano assestato mi aveva lasciato senza fiato e non riuscivo nemmeno a sollevare la testa. Ancora a capo chino, sentii che i soldati si allontanavano e mi lasciavano da sola in quell’ambiente. Se non fossi stata sopraffatta da dolore, forse mi sarei rallegrata al pensiero che, almeno per il momento, non mi avevano ancora violentato. Dopo alcuni minuti la porta si aprì nuovamente.
Questa volta, solo un paio di piedi entrarono nella stanza. Percepii che giravano lentamente attorno a me e vidi che mi si fermavano esattamente di fronte: un paio di lucide scarpe nere, in contrapposizione ai miei piedi scalzi, sporchi e ricoperti di sangue.
—Signorina Idoia —disse la voce rozza dell’uomo che aveva ordinato che mi portassero lì
—. Bianca Idoia. Come potei, alzai lo sguardo. Un inaspettato barlume di speranza irruppe nel mio petto a sentir pronunciare il mio nome.
—Sì! Sono io! —esclamai precipitosamente
— Sono un’ambasciatrice dell’UNICEF, ho un salvacondotto, sono spagnola; state sbagliando persona, stavo solo accompagnando una signora all’ospedale, io…
—Stia zitta! —Ma… —Le ho detto di stare zitta —ripeté alzandomi il mento bruscamente
— Lei potrà parlare solo quando le darò io il permesso…se non vuole finire come la donna in cortile. L’uomo mi lasciò il viso con un gesto di disprezzo e andò a sedersi davanti ad un tavolo di legno, esattamente di fronte a me. Riuscivo a malapena a tenere la testa sollevata, ma riconobbi un militare di circa cinquant’anni, con una brutta cicatrice sulla guancia sinistra che gli attraversava la faccia dall’occhio alla mandibola. Sembrava stesse leggendo alcune carte che aveva sul tavolo, e solo quando fu soddisfatto, dopo quasi dieci minuti di insopportabile silenzio, rotto soltanto dalle grida della disgraziata che veniva stuprata, alzò lo sguardo e sembrò accorgersi che mi trovavo ancora lì.
—Che cosa stava facendo lei, viaggiando da sola, di notte, in una strada simile? —Ma cosa dice? Non ero sola. Portavo all’ospedale la signora che mi ospita. Lì dovrebbe risultare, in quel dossier che ha davanti. —Il documento non dice che ci fosse qualcun altro con lei nel veicolo —disse, spargendo le pagine sulla scrivania. —Ma è così! La signora Margherita era accasciata sul sedile posteriore, tremava per la febbre!
—Mi sta dando del bugiardo? —chiese con voce di ghiaccio.
—No, non dico questo…ma potrebbe essere che il documento non sia corretto.
—Quindi sta dicendo che i bugiardi sono i miei soldati? —Non sto dando del bugiardo a nessuno! Sto solo dicendo la verità! —È proprio per stabilire la verità che siamo qui, signorina Idoia. Quindi mi dica, perché viaggiava da sola, di notte, in una strada dissestata?
Cominciai a temere per la sorte della signora Margherita. Tuttavia in quel momento ero io che mi trovavo con le mani legate in una sala per gli interrogatori. Per lei non potevo più fare niente, qualunque cosa le fosse successo.
—Sta pensando a che risposta inventarsi? —mormorò, strappandomi alle mie divagazioni.
—Cosa? No! Le dirò qualunque cosa desideri sapere! Non ho niente da nascondere!
—Ne è sicura? —Certo! Le ho già spiegato che mi trovo qui per realizzare uno studio per l’UNICEF. Non ho fatto nulla di illegale!
—Ma se non ha niente da nascondere, come mai viaggiava di notte senza documenti?
—Per Dio…le ho già spiegato che stavo portando una donna molto malata all’ospedale di Malabo, e lo zaino dove tengo i documenti, per via della fretta, era rimasto a casa della signora. —Il militare diede uno nuovo sguardo al documento sul tavolo.
—Sì… —mormorò senza alzare lo sguardo— una dimenticanza molto conveniente.
—Cosa vuole insinuare? È la verità!
—La verità? Allora mi spieghi perché nascondeva nell’auto materiale sovversivo contro il governo della Guinea Equatoriale.
—Materiale sovversivo? Di che accidenti sta parlando?
—Con tutta la calma di questo mondo, il militare si alzò dalla sedia, girò attorno al tavolo, si piazzò di fronte a me e con tutte le sue forze mi diede uno schiaffo con il rovescio della mano, che sembrò quasi strapparmi via la testa dal collo. Rimasi KO per un po’, incapace di accettare quel che stava succedendo.
—Bene, signorina Idoia – riprese a dire quella voce, che percepivo molto lontana e mista ad un ronzio—. Ora che abbiamo stabilito chi è che comanda, proverò a chiederglielo ancora una volta. A chi stava portando quel materiale? Chi è il suo contatto?
—Le giuro… —balbettai, con il labbro ferito e sanguinante—, che non so di che materiale parla…
Questa volta lo schiaffo arrivò dal lato opposto. Colpì la mandibola e credetti che si fosse fratturata, quando il dolore esplose, accompagnato da un orribile rumore di ossa rotte.
—Mentire non la aiuterà…e io non intendo passare l’intera giornata così. Cercai di aprire la bocca per rispondere, ma il dolore fu tanto intenso che riuscii appena a sussurrare tra i denti.
—Io… non…
A quel punto mi afferrò dai capelli e tirandomi brutalmente la testa all’indietro, mise davanti ai miei occhi il mio vecchio diario personale. Quello che avevo tenuto da quando ero arrivata in Guinea Equatoriale e che da qualche settimana credevo di aver perduto.
—Vuol forse negare che questo quaderno sia suo? Le faccio notare che c’è il suo nome scritto sulla copertina.
—Dove…? – balbettai confusa. —Dove lo abbiamo trovato? Sotto il sedile del passeggero, esattamente dove lei lo aveva nascosto. I ripetuti colpi alla testa hanno un vantaggio: impediscono di pensare chiaramente. Se non fosse stato per questo, credo che sarei impazzita in quello stesso momento, convinta di essere immersa in un delirio sadomasochista kafkiano. Non sapevo cosa controbattere per primo, se il fatto che non avevo nascosto niente, o quello che ciò che catalogava come propaganda sovversiva altro non era che il mio piccolo diario. Anche se forse, negare qualsiasi di quelle assurde accuse equivaleva a ricevere altre percosse e altro dolore.
—Il mio diario… è solo il mio diario… Il militare lo aprì ad una pagina precedentemente segnata e lesse.
—“…il governo è un mucchio di ladri patetici e disgraziati che rubano senza il minimo scrupolo il pane dalla bocca dei guineani; appoggiati da un esercito e una polizia, che altro non sono che autentici figli di puttana sanguinari, che non sottostanno a nessuna legge che non sia dettata dai loro depravati istinti…” Chiuse il libricino di colpo e me lo sventolò davanti alla faccia. —Vuole che vada avanti? Non sapevo che dire. Ero terrorizzata. Ovviamente erano parole mie, ma cercare di difendermi in qualche modo avrebbe solo portato ulteriore sofferenza, come quella che assediava ciascuna delle mie terminazioni nervose e mi teneva paralizzata. Negai semplicemente con la testa.
—Vedo che continuiamo a non capirci… Adesso, mi spieghi chi è il suo contatto. La testa mi girava. Non riuscivo a pensare. Non potevo difendermi, e non potevo confessare alcunché, perché non c’era nulla da confessare.
—Il mio diario… —sentii come se qualcuno parlasse attraverso la mia bocca— Non è propaganda… è il mio diario… e io non ho fatto niente.
—Signorina Idoia, lei mi delude… Pensavo che avesse capito in che situazione si trova, ma vedo che mi sbagliavo. Mi obbliga a fare cose che non le piaceranno. Queste ultime parole suonarono terribili in bocca a quell’uomo brutale.
—Si spogli.
—No, per favore… —Allora mi dica quello che voglio sentire.
—È la verità… Non dovevo incontrare nessuno… Non ho nulla da nascondere… —dovetti sputare il sangue che mi colmava la bocca— Glielo giuro… —Sta mettendo a dura prova la mia pazienza, signorina. La smetta di mentire.
Chi non ha nulla da nascondere, non tenta di corrompere un ufficiale, durante un controllo stradale.
—Corrompere…? – e capii a cosa alludeva, ricordando il mio polso sinistro vuoto. Era una follia, ma dalla sua macabra logica, le ipotetiche prove mi tacciavano come colpevole. Il mio stordimento cresceva di minuto in minuto. —Inoltre —disse il militare, richiamandomi dal caos— in questo libretto c’è il suo indirizzo.
E se non leggo male, qui dice che lei è dei paesi Baschi, no? —Sì…di Vitoria —risposi, ancora più disorientata se possibile da quella domanda.
—Come i terroristi dell’ETA… Mi sbaglio? Così mi resi conto di aver a che fare con un figlio di puttana ignorante, che è la peggior specie di figli di puttana.
—Cosa intende dire con ciò…? Non starà mica insinuando… —chiesi, tirando fuori le energie dalla mia incredulità—,che essendo basca, io sia quindi una terrorista…? —Per me è evidente. Lei è una spia dell’ETA, inviata dal governo spagnolo per rovesciare il governo sovrano della Guinea Equatoriale. Nella mia vita, mai avrei pensato di poter arrivare a sentire qualcosa di tanto demenziale, come quello. In circostanze diverse sarei morta dalle risate davanti a quella accusa così surreale, ma fui solo capace di articolare tre parole, e mi pentii all’istante di averlo fatto.
—Lei è pazzo… Inevitabilmente, un nuovo pugno attraversò l’aria e andò a finire contro il mio stomaco, facendomi cadere dalla sedia tra spasmi di dolore.
Quindi la suola di una scarpa mi premette sul collo strozzandomi e facendomi quasi perdere conoscenza. Con le mani legate dietro la schiena non potevo fare nulla per liberarmi, e pensai che sarei morta lì, sullo sporco pavimento di un carcere guineano, strangolata dalla scarpa di un militare che credeva che l’ETA fosse il servizio segreto dell’esecutivo spagnolo. Ma quando ormai mi davo per spacciata, inaspettatamente la pressione sul collo scomparve e potei riprendere aria, boccheggiando disperatamente, quasi grata a quel mostro per il gesto di misericordia.
—Io… —azzardai a dire, appena ebbi abbastanza fiato per parlare— confesserò ciò che vuole…ma non so cosa devo dire…
Il militare avvicinò il suo volto al mio, facendomi respirare uno schifosissimo alito che puzzava di carne marcia.
—Di questo non deve preoccuparsi, signorina Idoia. Ho qui la sua confessione già redatta sul mio tavolo, deve pensare solo a firmarla.
3
Chiamare processo gli scarsi dieci minuti in cui mi fecero stare in piedi in un lurido stanzino, di fronte ad un uomo con la toga, sarebbe uno scherzo di cattivo gusto. Senza avvocato difensore, senza il diritto di parlare, e con una confessione firmata sotto tortura, in cui non avevo idea di cosa ci fosse scritto; le possibilità di essere dichiarata innocente, davanti a quelle demenziali accuse, erano davvero scarse.
Trincerata in un abbattuto stoicismo, ascoltavo come il giudice, nel suo duplice ruolo di pubblico ministero, leggeva i capi d’imputazione e di conseguenza mi dichiarava colpevole di incitazione alla rivolta, spionaggio, aggressione (forse il militare si era fatto male nel darmi i pugni durante l’interrogatorio), oltraggio a pubblico ufficiale, tentata corruzione e, come ciliegina sulla torta, cospirazione per assassinare il presidente Teodoro Obiang Nguema. In totale, vent’anni di carcere senza possibilità di cauzione né di ricorso.
Se non fossi stata tanto stordita e ancora in stato di shock per i fatti del giorno precedente, forse sarei svenuta seduta stante, supplicando clemenza; invece mi sentivo come in una nube, guardando dall’alto una donna che mi assomigliava, che era praticamente stata condannata a morte. Mi faceva pena quella ragazza, questo era certo, ma non mi rendevo minimamente conto che ero io, e che forse non sarei mai più tornata nella mia città natale e sarei morta in un’infetta prigione guineana; fosse stato per mano delle guardie, della malaria o della fame.
Al meno, divagai, non avevo più le mani legate e potevo massaggiarmi l’infinità di contusioni che segnavano il mio corpo. In fin dei conti, forse la mandibola non era rotta; una volta tornata in cella, mi dedicai a ripulirmi con la saliva del sangue rappreso sui piedi, le ginocchia e la faccia. Ero stranamente tranquilla, forse per la consapevolezza che la tortura era finita, o perché ormai non c’era più nulla di cui preoccuparmi. La mia sorte era stata segnata, avevo tirato i dadi sbagliati. Fossi stata più credente, avrei raccomandato la mia anima a Dio, ma a quel punto arrivata c’erano troppi peccati sul piatto della bilancia, per poter sperare che l’Amico di lassù si disturbasse a gettarmi una corda.
Sempre che non fosse Lui stesso a vendicarsi, per aver citato così spesso la Sua Famiglia. Comunque, dopo il brutale smacco, mi rigettarono nella mia cella puzzolente (che mi era addirittura mancata) e lì mi lasciarono fino al giorno seguente. Con l’arrivo della sera (lo capivo grazie a quell’unico raggio di luce che entrava dalla finestrella) cominciò nuovamente ad aumentare l’attività nel cortile, e ancora una volta la porta della mia cella si aprì cigolando. Un paio di soldati diversi da quelli del giorno prima entrarono nella stanza; uno dei due, come il giorno precedente, portava con sé una cordicella di plastica per ammanettarmi, ma questa volta ebbi la prontezza di riflessi di unire le mani sul davanti, in modo che non mi legassero le mani dietro la schiena.
Si guardarono tra loro per un secondo e, dopo aver soppesato le poche possibilità che in ogni avevo caso di scappare, mi legarono i polsi sul davanti e mi portarono in cortile. Lì, un gruppo di uomini aspettavano seduti a terra. Mi tornò in mente la terribile scena a cui avevo assistito il giorno precedente e rimasi pietrificata al pensiero che io potessi essere la prossima. Feci un passo indietro, ma i soldati che mi scortavano mi spinsero fino al luogo dove si trovavano gli altri e dove fecero sedere anche me.
Mi accorsi in quel momento che tutti loro, come me, avevano le mani legate con lo stesso laccio di plastica bianca. Eravamo tutti prigionieri, e la domanda era: cosa ci facevamo lì? Un silenzio funereo avvolgeva quei venticinque/trenta uomini (ero l’unica donna). Tra di essi alcuni anziani, dei bambini che non credo avessero più di quattordici anni, e per lo più adulti, quasi tutti ricoperti di sangue secco, che guardavano a terra senza avere il coraggio di sollevare lo sguardo. Tra tutti, spiccava uno molto alto e muscoloso che, con aria di sfida, teneva la testa alta e, con rabbia malcelata, non smetteva di guardare le guardie che ci circondavano con il suo unico occhio sano, dato che l’altro era talmente tumefatto che dubito che potesse vederci qualcosa. Nel giro di qualche minuto, giunse la risposta al quesito di cosa ci facessimo lì: era un camion per il trasporto dei militari. Allo stesso tempo, comparve da una delle porte laterali del cortile l’ufficiale che mi aveva torturato il giorno prima. Cercai di nascondermi come uno struzzo quando mi passò accanto, ma sembrò non accorgersi nemmeno di me.
—Fateli salire sul camion! —ordinò. Quindi i soldati ci fecero alzare a calci e ci spinsero fino all’interno del veicolo. Essendo arrivata per ultima, fui quasi l’ultima a salire: dopo di me era rimasto solo il Golia dall’occhio tumefatto. Il camion era pieno e feci fatica ad incastrarmi tra gli altri prigionieri e girarmi per guardare indietro. I soldati cercarono di chiudere la sponda, ma l’affollamento era tale da impedir loro di farlo.
—Capitano —avvertì uno dei soldati— è troppo carico.
Non possiamo chiudere. Il capitano, ossia quella bestia dell’interrogatorio, si avvicinò al retro e, dopo aver valutato la situazione, si rivolse direttamente all’omone che era esattamente tra la sponda e me.
—Ehi, tu! —disse— Scendi un attimo dal camion.
Il muscoloso gigante, senza perdere la sua alterigia, fece un gran salto, andando a cadere giusto davanti al naso del torturatore che, accanto a lui, appariva come un nano grassottello travestito da ufficiale. E senza preavviso, prima che qualcuno potesse rendersi conto di quanto stava succedendo, il nano grassoccio prese la pistola dalla cintura e sparò in fronte al prigioniero, che cadde di schiena con la testa sfigurata, spargendo sangue e cervello sul suolo sporco del cortile.
—Ecco cosa succede a chi mangia troppo —ironizzò con la pistola ancora fumante e gocce di sangue sul viso. Il resto della truppa rise sguaiatamente, come se quella fosse la miglior battuta che avessero mai sentito nella loro vita. Io ero talmente terrorizzata da non riuscire nemmeno a gridare.
Mi ero resa conto quella stessa mattina che la giustizia in Guinea Equatoriale non esiste, ma ora avevo appena constatato che la vita umana non ha il benché minimo valore, e tutti i passeggeri di quel camion eravamo nelle sadiche mani di assassini che non avrebbero esitato a premere il grilletto per semplice capriccio. Alle mie spalle corse appena un mormorio di sconcerto, ma nessuno si azzardò a dire nemmeno una parola, per non richiamare l’attenzione su di sé.
Alla fine, a spinte, riuscirono a chiudere la porta di legno e il camion partì con destinazione ignota. Era già notte quando attraversammo un grande villaggio, che certamente doveva essere Malabo, e tra le fessure della porta di legno intravidi le luci delle case e qualche viandante illuminato dalle stesse. Desideravo gridare per chiedere aiuto, affinché chiamassero l’ambasciata spagnola, o qualunque altra cosa.
Ma il terrore mi paralizzava, e comunque ero consapevole che non sarebbe servito a nulla, se non a fare in modo che, una volta a destinazione, venissi percossa o peggio. Dopo qualche minuto lasciammo la città e prendemmo una strada verso l’interno: forse, pensai, la stessa che conduceva a quella che era stata la mia abitazione nei tre mesi precedenti. Il camion continuava a sobbalzare, per via del cattivo stato della strada, però eravamo talmente ammassati che era impossibile che qualcuno cadesse a terra.
La poca aria che penetrava tra le assi, calda, densa, carica di paura, permetteva appena di respirare e temevo che, se il tragitto fosse stato ancora lungo, avrei finito per perdere conoscenza. —Qualcuno sa dove ci stanno portando? —chiesi, rivolta al silenzio che mi circondava.
—Alla prigione di Black Beach —rispose qualcuno dietro di me, alla mia destra—.
È l’unica dell’isola. —Credo di no, amico… —disse un’altra voce—.
Black Beach è piena. È da settimane che lì non incarcerano più nessuno. E mentre cercavo di immaginare come potesse essere un carcere guineano, perché lo definissero pieno, una voce da bambino chiese timidamente.
—Allora…dove ci portano? Nessuno rispose a quella domanda, ma sentii che qualcuno gli sussurrava —Tranquillo figliolo…tranquillo.
Un silenzio pesante si impadronì dei miei compagni di sventura che, come agnelli rassegnati in viaggio verso il macello, con la testa bassa, sembravano assorti in ricordi dei giorni felici, cercando indubbiamente di evadere attraverso di essi e forse accomiatarsi in qualche modo dai cari che mai più avrebbero rivisto. Io nel frattempo, schiacciata tra loro, mi sentivo oppressa dalla successione di castighi che il fato mi stava propinando, tanto che, la consapevolezza data da quelle ultime parole che in realtà non ci stavamo dirigendo verso un carcere, ma verso un destino più funesto, ci mise un po’ a trasformarsi in un pensiero cosciente. Ma la cosa più strana fu che non ebbi paura.
Semplicemente, mi abbandonai alla medesima disperata apatia che si era impossessata di tutti gli altri sul camion. Continuammo a sobbalzare in silenzio durante più di mezz’ora, poi forse a causa dei troppi scossoni o della pressione dei corpi, all’improvviso, come capita solo nei film più inverosimili, la parte destra della porta di carico, proprio quella davanti a me, ruppe i cardini con un rumore sordo e scomparve nell’oscurità che ci lasciavamo dietro.
Durante un paio di secondi nessuno si mosse, credendo impossibile che fosse successo davvero. Poi qualcuno gridò qualcosa alle mie spalle e subito venni spinta da dietro, cadendo dal camion in movimento, nello stesso momento in cui gli altri detenuti si lanciavano senza esitare verso la notte e la libertà. Grazie al fatto di avere le mani legate sul davanti, potei almeno proteggermi il volto nella caduta e, anche se picchiai forte la spalla nell’impatto con il suolo, ero talmente stordita da non sentire dolore.
Alzai la testa, cercando di acquistare lucidità, e mi accorsi con timore che le luci dei freni si erano accese, nel momento in cui l’auto si era fermata ad una dozzina di metri da dove mi trovavo. Mi guardai attorno, in cerca di una via di fuga, però l’oscurità avvolgeva tutto quanto attorno a me e io ero paralizzata dall’indecisione.
Sentii le portiere della macchina scricchiolare e, pochi secondi dopo, i colpi di una mitragliatrice squarciarono il silenzio della notte: mi ero appena sollevata che dovetti lanciarmi nuovamente al suolo, sentendo i proiettili che fischiavano sopra la mia testa. In quel momento, dall’oscurità apparve una mano forte che mi afferrò il braccio e mi sollevò.
—Si alzi! —mi urlò nell’orecchio—.
Se rimane qui, la uccideranno. E senza volerlo, lasciandomi condurre da quella mano che non mi abbandonava, mi misi in piedi e iniziai a correre immergendomi nel buio.
[amazon_auto_links id=”10048″]


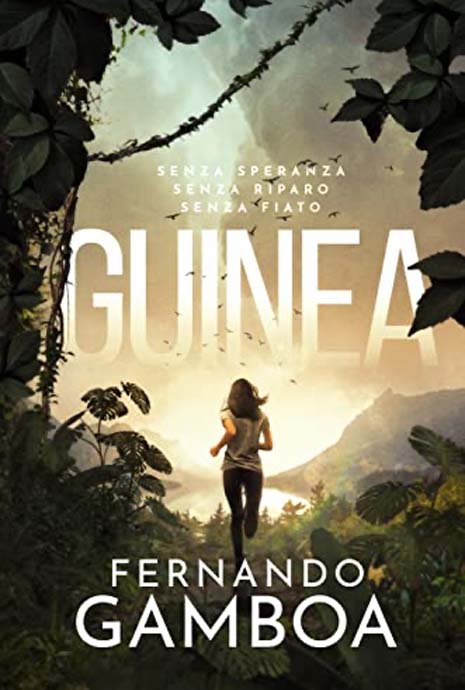

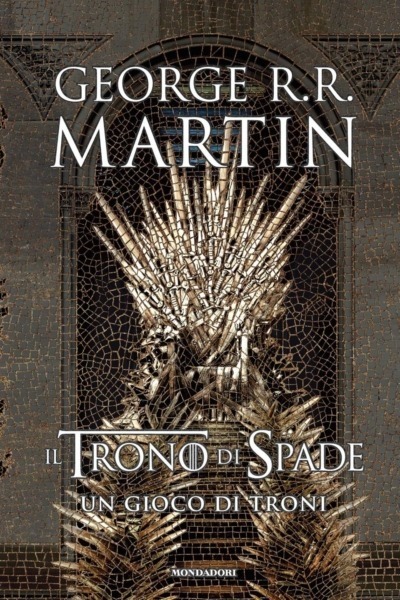

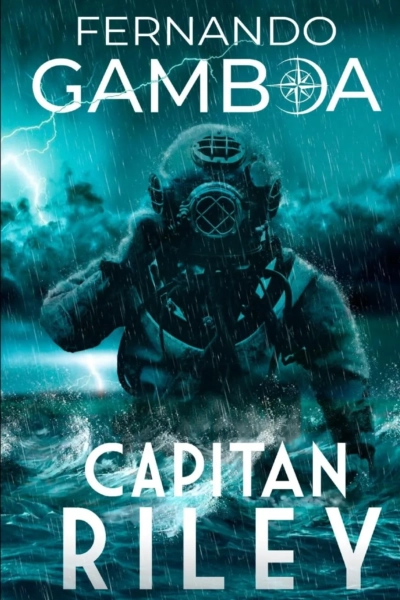

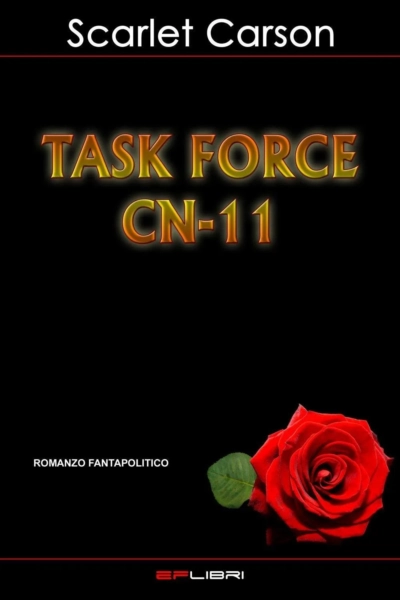
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.