Descrizione
I
Una visita inattesa
Asmara, giovedì 7 gennaio 1937
Barbagallo e io camminavamo spediti lungo viale Cadorna, diretti al palazzo del Commissariato dell’Hamasièn, che ospitava i nostri nuovi uffici. Eravamo arrivati nella capitale da pochi giorni e ci trovavamo ancora in quella felice predisposizione d’animo in cui tutto ciò che vedevamo intorno appariva inedito, affascinante, maestoso. Comunque molto differente dalla nostra piccola, afosa e cadente Massaua. Entrambi conoscevamo già Asmara, ci eravamo stati più di una volta in missione, ma era proprio il diverso atteggiamento psicologico che adesso mostrava le nuove sfaccettature della città.
Mi sentivo ancora estraneo a quella che all’epoca, per i parametri africani, era una vera metropoli, con i suoi quasi centomila abitanti. Tuttavia ero anche consapevole di non esser più di passaggio, perciò tentavo di calarmi in fretta nelle pieghe recondite della grande ragnatela di cemento, asfalto e travertino costruita a partire dal 1897, quando il governatore Martini vi aveva trasferito da Massaua la capitale della colonia eritrea. Una città che da piccolo villaggio abissino aveva conosciuto uno straordinario sviluppo urbanistico all’inizio del secolo e poi, negli anni Venti, aveva cominciato ad assumere l’aspetto della moderna urbe che il tutto il mondo ci invidiava.
Dopo cinque minuti mi resi conto che la marcia a passo da bersagliere mi stava sfiancando più del dovuto e ricordai che il mio organismo non era ancora del tutto a suo agio ai duemila metri d’altitudine dell’altopiano. Figuriamoci Barbagallo, che nonostante l’intensa attività militare da anni non riusciva a buttar giù quella decina di chiletti di troppo dovuti alla buona cucina della moglie.
«Boia fauss», riuscì a sussurrare il maresciallo, soffiando come un mantice, «in questo cavolo di Paese non si può mai passeggiare in pace. Giù a Massaua se cammini per un paio di minuti sudi come un camallo del porto di Genova, qui invece non riesci a respirare e ti gira la testa per colpa del mal di montagna. È proprio vero che il clima migliore ce l’abbiamo noi in Italia, altroché balle.»
Come sempre sorrisi agli spropositi del sottufficiale piemontese, che amava lamentarsi quasi quanto amava l’Eritrea, la terra che ormai da parecchi anni aveva accolto entrambi come nuovi figli. Ma se Barbagallo non borbottava due o tre volte al giorno non era contento.
«Fermiamoci in quel bar a prendere un caffè», proposi, «tanto non abbiamo mica fretta.»
«Io mi berrei un bel bicchierone di acqua e menta», rispose affannato, «quest’aria così leggera e asciutta mi ha seccato la gola e mi sento come un cammello nel deserto della Dancalia.»
Entrammo al caffè Istria, le cui vetrine si affacciavano sulla cattedrale di Asmara, edificata nel 1922 in stile lombardo. Il locale era affollato, come del resto tutti i luoghi di ritrovo del centro cittadino. Ci facemmo largo per arrivare al bancone e ordinammo le consumazioni. Sorseggiai con piacere il caffè espresso, che non aveva nulla da invidiare a quelli di Milano o di Roma, mentre il maresciallo si dissetava con la bibita fredda. Placata la sete, Barbagallo prese a osservare la mia uniforme e rimirò la sua nel grande specchio posto dietro i baristi indaffarati.
«Signor maggiore, dite quello che volete, ma non riesco ad abituarmi a questa divisa. Se poi penso a com’era elegante la nostra uniforme da carabiniere…»
«Via, Eusebio. Questa non è poi molto diversa, il colore è lo stesso e non si può dire che sia brutta.»
«Sì, però dove sono finiti i nostri alamari? La nostra fiamma che arde da più di centovent’anni?»
Il faccione corrucciato esprimeva tutta la sua insoddisfazione.
«E poi, scusate, ma questa roba che adesso siamo diventati dei questurini proprio non riesco a digerirla.»
Scrollai le spalle e gli diedi un’affettuosa pacca sulla schiena. In realtà anch’io facevo fatica ad accettare il nuovo status, dopo oltre vent’anni trascorsi a servire la patria nell’Arma.
Da alcune settimane eravamo stati inglobati nel nascente Corpo di Polizia Coloniale, che di lì a poco avrebbe poi assunto la denominazione di Polizia dell’Africa Italiana, PAI. La nuova forza armata era stata posta sotto il diretto controllo del ministro delle Colonie Alessandro Lessona e avrebbe via via sostituito i reparti dei Carabinieri che sino ad allora avevano svolto i compiti di polizia giudiziaria e amministrativa in terra d’Africa. Era stato lo stesso Mussolini a volere un corpo militare autonomo, con competenze specifiche, che avrebbe dovuto occuparsi di tutto ciò che riguardava l’ordine pubblico e la sicurezza nelle colonie. E il Duce non aveva certo lesinato risorse finanziarie per dotare la polizia coloniale di uomini, mezzi e armamenti adeguati.
Il comandante, generale Maraffa, era stato autorizzato dal governo ad avviare una sorta di «campagna acquisti» come quella che le società più ricche sono solite condurre prima dell’inizio del campionato di calcio per assicurarsi i giocatori migliori. L’arruolamento nel corpo prevedeva aumenti di stipendio, la possibilità di rimanere in servizio nelle colonie e concrete prospettive di carriera, dato che la nuova forza armata avrebbe avuto giurisdizione sull’intera Africa italiana, dalla Libia alle più antiche colonie di Eritrea e Somalia, fino alla nuova gemma della corona, l’Etiopia, da poco conquistata all’impero.
Avevo impiegato un paio di notti insonni a decidere del mio futuro, rigirandomi nelle lenzuola sudate dell’alloggio al comando del Bassopiano di Massaua. Anch’io, come Barbagallo, ero riluttante all’idea di lasciare l’Arma, che consideravo come una seconda famiglia. Ma l’alternativa era allettante, a cominciare dallo stipendio quasi raddoppiato. Ci pensai e ripensai per ore, cercando anche conforto nella lettura dell’amato Seneca, ma non riuscivo a prendere una decisione.
Un aiuto involontario mi venne dal mio comandante, il colonnello Frangipane, che in un caldo giorno d’inizio dicembre mi convocò nel suo ufficio. Dopo un paio di convenevoli, il colonnello andò dritto al punto.
«Morosini, entro sei mesi qui si sbaracca», affermò con aria arcigna. «Ho ricevuto poco fa un fonogramma da Roma in cui mi si annuncia che è stata accolta la mia richiesta di trasferimento a Pisa, dove andrò a dirigere il comando provinciale.»
Frangipane si alzò e fece due passi verso la finestra che affacciava sul mare. Guardò verso la rada di Massaua e si fece scappare un sospiro.
«Sapete, mi mancherà tutto questo», disse in tono stranamente confidenziale, rivolgendosi con un gesto teatrale al paesaggio esterno. «E mi mancherà anche il calore della gente eritrea.»
Repressi a stento un sorriso. Sapevo che da alcuni anni il colonnello manteneva in una casetta fuori città una giovane amante indigena, che andava a visitare piuttosto spesso inventando improbabili attività di servizio per sfuggire ai controlli della moglie, soprannominata in modo non troppo affettuoso «la colonnella». Mi venne spontaneo pensare che il calore che più gli sarebbe mancato sarebbe stato proprio quello del corpo della giovane eritrea.


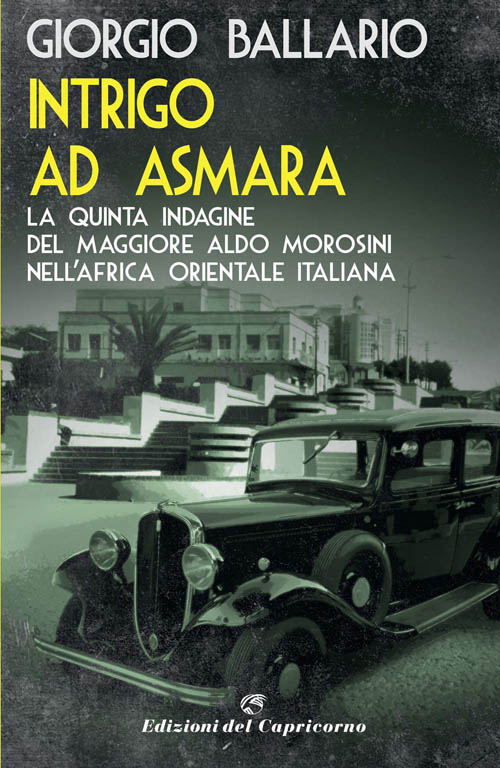



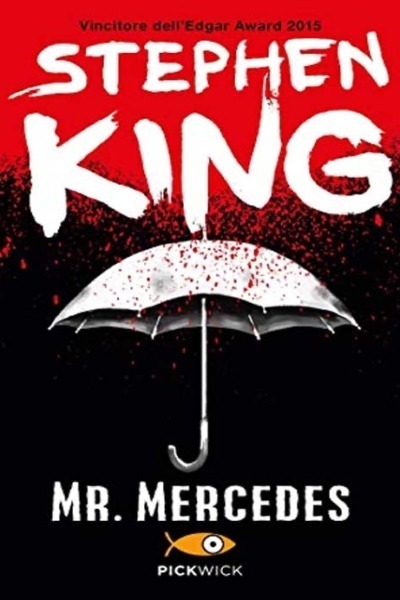
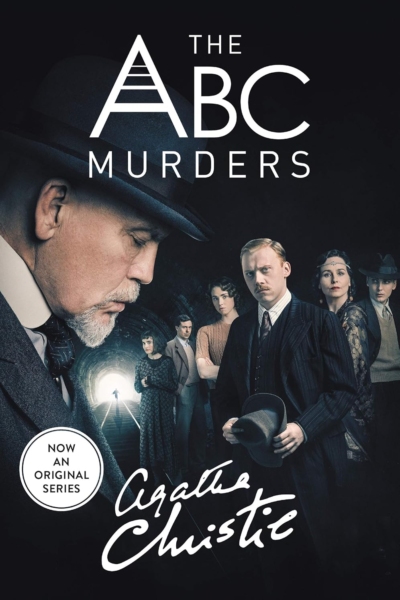
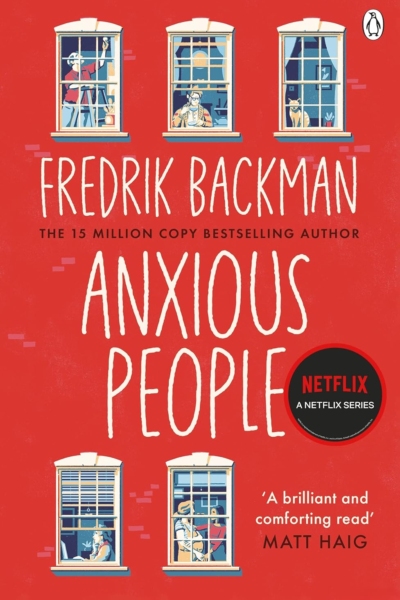
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.