Descrizione
Capitolo 1
Vicoli di ombra
La notte era dipinta dal bagliore della luna e dalle striature delle nubi violacee sulla campitura di quel cielo che assommava tutte le sfumare del blu, del grigio e del nero. In quella notte, più di molte altre notti, i vicoli di Efreim, avvolti nell’umida, flebile calura di fine estate, brulicavano di vita in occasione del cinquantenario della fondazione della città.
A molti era apparso quasi miracoloso un così rapido sviluppo: da cittadina portuale a grande e ricchissima capitale d’importazione ed esportazione; e il tutto in appena mezzo secolo. Un vero vanto per il Reame di Zonthar che – cosa più importante – ne riscuoteva tributi tra i più cospicui.
A buon diritto, dunque, era festa a Efreim.
Mille erano gli odori che ne permeavano l’aria, rendendola invitante alla curiosità forestiera.
Mille e più i colori provenienti dal caleidoscopio delle merci esposte con opulenza dai fornitissimi empori, dalle luci delle botteghe degli artigiani ancora attivi a tarda ora per soddisfare la costante domanda di beni d’ogni genere, e specialmente dalla miriade di candele accese dai locandieri e poste sui davanzali delle finestre affacciate sulle viuzze, al di sotto delle insegne in cui era grossolanamente intagliato il nome del locale, o ancora racchiuse nelle lanterne di bronzo appese agli stipiti delle porte grezze e saggiamente robuste.
Erano proprio quelle numerosissime candele a caratterizzare particolarmente l’atmosfera notturna, che – satura del fumo e delle polveri derivate dal passaggio assiduo dei visitatori – assumeva un soffuso e ipnotico tono dorato.
Era decisamente festa a Efreim.
E risuonavano in quei vicoli gli schiamazzi, i saluti, le risate, le contrattazioni, le liti che sovente scoppiavano tra i mercanti e i numerosi avventori provenienti dalle più disparate zone del Reame; ne derivava una chiassosa effervescenza, quella vivace baldoria che donava il carattere inconfondibile a quel centro di vitalità foriero di esperienze ed emozioni.
Era festa a Efreim.
Ma in quella dimensione vistosamente caotica – e, di fatto, del tutto confacente a una capitale mercantile – d’un tratto qualcosa, al contempo familiare e insolito, irruppe inaspettatamente.
Si faceva largo tra i vicoli un rumore che, sebbene consueto, sembrava assumere toni sempre meno rassicuranti man mano che si avvicinava.
Caratteristico era, tra quelle vie, udire la corsa selvaggiamente spronata di un cavallo; specie quando questo cercava di mettere al sicuro il ladro di turno che si fosse cimentato in uno dei frequentissimi tentativi di furti e rapine, perpetrati di solito ai danni di qualcuno dei mercanti cittadini.
Nulla di strano, dunque.
Almeno questo fu ciò che fantasticò la folla indirizzando il capo verso la fonte del rumore, pronta a vedere materializzarsi da un momento all’altro l’eccitante scena di fuga già elaborata dall’immaginazione.
Ma più l’eco della cavalcata si faceva vicina e più l’aspettativa mutava.
Erano zoccoli insolitamente forti e pesanti quelli che stavano scheggiando le pietre di pavimentazione – già sufficientemente consunte – di una delle arterie maggiori della città.
Assieme a quel martellamento cominciavano ad alzarsi poi urla e strepiti di gente che cercava di scansarsi, di trovare riparo o che, più sfortunatamente, era sbalzata per terra senza alcun riguardo.
Come il propagarsi di un’onda nata da un enorme masso gettato in acqua, il convulso spostamento della folla annunciava visivamente il crescere di quel trambusto sempre meno rassicurante.
Quella cavalcata sprezzante e inarrestabile dovette suonare per qualcuno come l’annuncio della rettitudine, della severità, del giusto castigo che finalmente si facevano largo in quel luogo dominato dal meschino profitto.
La sagoma grande e indistinta parve essere giunta per punire col suo inesorabile passaggio l’avidità, l’ingordigia, la disonestà che reggevano le oscure fondamenta di quella città di mercanti arricchitisi in brevi anni, grazie alla spregiudicata attività che una società corrotta come quella rendeva possibile.
La presenza che sconvolgeva Efreim in quella fatidica notte recava con sé un messaggio di punizione; ed esso era destinato ad uno dei suoi mercanti, in particolare.
Engoras imboccò, scivolando e arrancando sulla viscida strada lastricata, l’angusto vicoletto reso ancor più stretto dall’ombra.
I suoi occhi azzurri avevano perso del tutto l’espressione spavalda esibita in anni e anni di cinici affari; apparivano adesso sconvolti sulla maschera biancastra del volto, al di sotto dei lunghi capelli castani che, sudati nell’impulso disperato della corsa, gli si erano attaccati alla fronte e al naso aquilino disegnando arabeschi irregolari.
Per sua fortuna, la giovane età e soprattutto la sua vanità gli avevano permesso di conservare un fisico piuttosto asciutto, a differenza della maggior parte dei commercianti del posto, comunemente grassocci al pari delle loro preziose borse.
Engoras continuava a correre, senza fermarsi neppure per riprendere fiato, e imprecava tra i denti stretti allorché, dovendo sostenersi con le mani a causa delle frequenti cadute, spezzava le unghie curate, o graffiava le gemme dei suoi anelli d’oro, oppure spiegazzava la camicia e il panciotto di seta ricamata, o ancora strappava i calzoni di delicato velluto bianco insudiciati dal fango che ormai gli aveva ricoperto completamente le ginocchia, nella fuga resa scomposta da stivali alti e eleganti, ma poco adatti alle pietre grezze dei vicoletti meno frequentati.
Lanciando un’occhiata alle spalle, e percependo l’eco sempre più vicina di zoccoli scalpitanti, tuttavia, tali vane frivolezze vennero fagocitate dalla paura che si ingrossava nel suo petto, attanagliando inesorabilmente il respiro e le forze.
Si sorprese per il fatto che – nonostante il particolare frangente – quella sensazione stesse riportando alla mente vicende legate alla sua attività passata, un’attività che, per sua natura, lo aveva visto di continuo impegnato a scappare proprio come stava facendo quella notte.
Strizzò nervosamente gli occhi per distogliere l’attenzione da quei ricordi stranamente e inutilmente nostalgici.
Ma qualche istante dopo, per assurdo, proprio quella stessa sensazione e quei ricordi del passato servirono a risvegliare in lui un senso di prontezza e un istinto di sopravvivenza che erano stati a lungo deposti dalla sicurezza che la nuova e agiata posizione sociale gli aveva procurato.
Senza rallentare minimamente l’andatura spasmodica, e senza distogliere lo sguardo per decifrare il dedalo di viuzze che gli si paravano davanti, afferrò la piccola bisaccia che teneva sul fianco sinistro, ben nascosta al di sotto del panciotto, ma sempre a portata di mano.
Infilandovi la destra trovò un qualcosa che non si sarebbe mai immaginato di dover usare ancora.
Era stato l’istinto? Era stato il senso di prudenza riconducibile al suo vecchio “mestiere” che lo aveva spinto per tutti quegli anni a conservarlo nella bisaccia in cui portava gli oggetti di uso più frequente?
Engoras abbozzò un sorriso di sfida, come gli capitava di fare tutte le volte che si era imposto di cavarsela, assecondando l’atteggiamento volitivo che lo aveva portato fin dov’era arrivato; strinse tra le dita l’angolo di un sottile velo di stoffa che – sperava – gli avrebbe salvato la vita. Anche quella volta.
Ora il fiato stava definitivamente esaurendosi. Non avrebbe potuto proseguire oltre.
Con un caparbio sforzo, sveltendo ancor di più le falcate, terminò l’ultimo tratto in cui si era immesso.
Quindi si bloccò di scatto, scivolando per l’ennesima volta sul viscido selciato.
E rialzatosi con un’ennesima imprecazione – che stavolta venne prudentemente soffocata – si pose per brevissimo tempo al di sotto di una lanterna che gli favorì un rapido orientamento; poi infilò alla destra dell’incrocio che aveva raggiunto.
L’eco dei suoi passi si perse in una strettissima svolta ancora più buia di quelle percorse, perfetta per ciò che aveva in mente.
Trascorsero pochi istanti, e la stessa lanterna che aveva aiutato il mercante a decidere la via in cui cercare rifugio rischiarò con un cono di luce tremula e giallognola una grossa figura che emergeva dall’oscurità.
Un alto cavallo dal brillante manto nero incedeva con solenne lentezza, saldamente trattenuto da redini rette con fare sicuro; avanzava lasciando fluttuare una folta e lunga criniera grigio-cenere nell’umidità della stretta viuzza incastrata tra gli alti piani delle case.
Sfogando l’impeto che sino a poco prima lo aveva eccitato, il poderoso animale sbuffava dalle narici alzando e abbassando con energia il collo muscoloso, e agitando nervosamente il capo quasi a voler sfidare la fermezza del morso e della piastra di lucido metallo inciso che gli ricopriva gran parte della fronte, ma che non riusciva a celare né a eguagliare il lampo di quegli occhi nerissimi e vitali, dilatati dallo sforzo del galoppo appena concluso.
Conscia della necessità di calmarlo, una mano coperta da un guanto di velluto scarlatto si posò con delicatezza sul folto crine del destriero, che parve ubbidire a un tacito comando.
Immobile nella sua nobile postura, l’animale si limitava ora a emettere il suo cavernoso respiro, lasciandolo riecheggiare nel silenzio dell’attesa; un’attesa che durò tuttavia qualche attimo.
La decisione del suo cavaliere lo costrinse presto a muoversi di nuovo; questa volta al passo.
Le redini tiravano verso destra.
Al di sotto del tessuto, teso fra braccia e gambe divaricate, l’esausto mercante si costringeva a sopportare il calore generato non solo dalla scarsa traspirazione che la stoffa concedeva, ma specialmente dalla fatica che lo aveva sfiancato, prima nella corsa frenetica, poi nell’arrampicata su un cornicione che percorreva il muro sul fianco sinistro della stradetta in cui aveva riposto la speranza di nascondersi dal suo implacabile inseguitore.
Sospeso sulla stretta sporgenza, cercava di convincersi della decisione presa, giustificandola peraltro con la certezza che la sua attuale preparazione fisica non gli avrebbe concesso di prolungare oltre la sua corsa; era chiaramente fuori allenamento rispetto agli anni più giovanili.
La situazione era però assai simile a quelle che aveva vissuto spesso durante un periodo della sua vita non tanto remoto: non a caso gli era balenato nella mente quell’espediente che ora stava usando al fine di riportare a casa la pelle.
Sarebbe andata bene. Se l’era sempre cavata, d’altronde, in situazioni del genere. Specie grazie a quel suo raro “strumento del mestiere”.
Era questo che seguitava a ripetersi, quando d’un tratto il rumore di quei maledetti zoccoli tornò a farsi sentire.
La mente di Engoras fece ancor più spazio ai ricordi giovanili, che ora gli sembravano di un’utilità sempre più vitale.
“Ricorda ciò che ti hanno insegnato”, pensava, “Quando non ha più scampo, la volpe si finge morta davanti alla minaccia che non può affrontare, stando immobile. Imperterrita, non tradisce la sua simulazione, a meno che non sia sicura di essere inevitabilmente uccisa restando in quello stato”.
Bisognava perciò mantenere la calma e soprattutto bloccare le proprie membra.
Fino a quando quel terribile pericolo non fosse passato. E persino respirare con la bocca, al fine di evitare il fruscio che il respiro avrebbe procurato, passando troppo velocemente attraverso il naso, spinto dell’affanno e della trepidazione.
L’unico movimento che bisognava concedersi era quello degli occhi, tramite i quali – attraverso una sottile fessura praticata nella stoffa – Engoras indagava dall’alto la stradina immersa quasi completamente nel buio. Attendendo con tensione. Scrutando con impazienza ciò che non si fece attendere a lungo.
Il cavaliere avanzava, fondendosi con l’ombra mediante la serica, liquida oscurità del suo mantello, che lo copriva con un cappuccio sul capo, gli scendeva sulle spalle e sulla schiena completamente avvolte, e si riversava infine sui fianchi e sul dorso del destriero, unendo così le due sagome in un’unica presenza lugubre e mostruosa.
Aveva attraversato già metà della stradina, quando improvvisamente i guanti scarlatti guizzarono da una piega del mantello tendendo le redini.
Engoras – deglutendo a fatica – teneva le pupille immobili sul fantasma ammantato: rimaneva silenzioso, impassibile, raggelato da un’istintiva paura, contando con trepidazione gli interminabili attimi che la spettrale figura impiegava per valutare la prossima mossa da compiere.
Si imponeva un’estrema rigidità, maledicendosi per ogni minima contrazione dei muscoli indotta dall’indolenzimento crescente: se avesse potuto si sarebbe fatto assorbire volentieri dal muro alle sue spalle pur di scampare a quella situazione.
Quanto gli mancava quel baccano da festa tipico di Efreim, che ora disgraziatamente riecheggiava troppo lontano da quel desolato viottolo; lo aveva sempre disprezzato e invece adesso gli sarebbe tornato utile a camuffare il martellante battito del suo cuore sconvolto.
La lacerante attesa sembrava non voler cessare.
Spinto da un’ansia sempre più snervante, lo sventurato mercante volle spostare gli occhi appena per assicurare la posizione dei suoi stivali sul ripido cornicione di pietra che lo sorreggeva, ma proprio quando si accinse a farlo i movimenti della figura oscura sembrarono voler punire quell’azzardo.
Il mercante riportò immediatamente la concentrazione sulla fonte del pericolo, e sospirò con sollievo: il cavallo aveva semplicemente spostato il capo alla propria sinistra. In effetti, era la direzione in cui, poco più in alto, si trovava lui; ma era stato comunque il semplice movimento di un animale: nulla di cui allarmarsi.
L’attimo dopo, però, quella sua fallace distensione si tramutò bruscamente in una tensione peggiore di prima, allorché anche la testa del cavaliere si voltò a sinistra, sollevandosi, per giunta, verso l’alto.
Il cappuccio non lasciava intravedere alcun lineamento, conferendo a quello sguardo oscuro, che non si distoglieva dalla direzione della sua preda, una natura inumana.
Engoras si pietrificò nella sua posizione, aiutato in questo dalla paura che oramai gli aveva pietrificato le membra, penetrando in lui proprio attraverso le pupille rimaste fisse verso il basso.
Il guanto scarlatto irruppe nuovamente in quel dominio dell’ombra, affiorando dalle lunghe e ampissime maniche e infilandosi, con un movimento fluido, nel nero di una piega in prossimità del petto.
Ne riemerse subito dopo, accompagnandosi a uno scintillante riflesso argenteo: l’indice e il medio stringevano un piccolo, rilucente coltello da lancio.
Engoras non aveva decifrato ancora la natura di quell’oggetto e non ne ebbe il tempo, poiché esso saettò con un movimento incredibilmente preciso e fulmineo dalla mano rossa verso il muro al quale stava aggrappato.
Lo squillo metallico con cui si era infisso a poca distanza dalla sua gamba destra era stato nondimeno inconfondibile.
Ma la volpe non deve muoversi!
Nemmeno il tempo di inalare un altro respiro e un secondo sibilo argentino si avvicinò pericolosamente al suo torace.
Niente paura: non può vederti. Non muoverti!
La pausa che seguì parve sospendere il tempo.
La figura ammantata abbassò di nuovo il capo. Rimase come in meditazione.
Engoras conservò la sua simulazione, costringendo tutto il suo essere, confidando nel suo sangue freddo, nei suoi ricordi, nell’esperienza radicata in lui.
Gli attimi trascorsero con una lentezza insopportabile, ma sembrarono dargli finalmente ragione quando il cavallo si rimise in marcia, procedendo di nuovo in maniera pacata.
Ecco che passava sotto i suoi piedi.
Il trotto scandito dagli zoccoli poderosi dell’animale gli aveva completamente magnetizzato la coscienza: gli occhi non si staccavano da quell’incedere che non lasciava spazio a deduzioni di alcun genere.
Il destriero nero superò di qualche passo il nascondiglio.
Era fatta.
Alla fine la freddezza e l’astuzia del mercante avevano trionfato.
E il trepidante Engoras poté gioirne segretamente.
Ma per poco.
Come a voler giocare con la sua agonia, conscio di esserne l’artefice, lo sguardo di tenebra infranse la sua speranza, e di scatto lo trafisse con una spaventosa determinazione.
Un altro rapido movimento della mano scarlatta.
In un istante tre scintille saettarono verso l’alto.
Due gli si conficcarono nella gamba sinistra, una nella spalla destra.
Il dolore si diffuse attraverso le terminazioni nervose con una rapidità impressionante.
Lentamente e inevitabilmente il contatto delle spalle con il muro si allentò.
La volpe aveva definitivamente fallito.
La goffa sagoma del mercante scivolò dal cornicione, rovinando al suolo con un tonfo sordo; durante la caduta i movimenti erano impediti, come se gli arti fossero avvolti in qualcosa somigliante a un velo d’acqua, attraverso il quale trasparivano traballanti e sfocati i contorni delle misere architetture del vicoletto e la fioca luce che proveniva dal suo sbocco.
Engoras finì sul selciato, e atterrò proprio sulla spalla ferita.
Come inquinata dalla sudicia strada, la stoffa che poco prima mostrava una consistenza liquida e assolutamente trasparente si era tramutata d’incanto in un sottile drappo bruno, al di sotto del quale cominciavano a serpeggiare sottili rivoli di sangue.
Ora che il suo stratagemma era stato rivelato, e nulla più restava da nascondere e reprimere, l’uomo lasciò eruttare la tensione accumulata e il dolore lancinante in un urlo misto di rabbia, sofferenza e paura, che venne ovattato dalla stoffa in cui era ancora avvinto come in un sozzo bozzolo.
Ammutolì immediatamente, però, quando sentì due pesanti stivali che battevano contemporaneamente sul selciato: il cavaliere era smontato, balzando agilmente dalla sella.
Raccogliendo gli ultimi brandelli di coraggio, Engoras si convinse che restare nascosto sotto l’inutile stoffa non sarebbe certamente servito a sottrarlo a quell’odiato, ineludibile pericolo.
Aveva sperato che quel drappo incantato potesse servirgli da rifugio: ora, invece, rischiava di tramutarsi nella sua miserevole tomba.
Sollevando a fatica la fronte, che sino ad allora era stata attaccata al terreno con abbandonata rassegnazione, Engoras si sforzò di far ruotare il capo in direzione del cavaliere, di cui al momento – attraverso le pieghe sollevate del tessuto – poteva scorgere soltanto le punte dei lucidi stivali, coperti anch’essi in buona parte dalla sinistra cappa scura.
I pensieri del mercante corsero veloci, si affollarono nella sua mente, e infine fecero emergere il lato più attuale della sua personalità.
Il mercante infilò le dita al di sotto del panciotto, cercando quell’arma che – come gli avevano dimostrato gli ultimi anni – riusciva a essere, in molti casi, efficace più di tante lame.
Engoras la strinse nella mano, affidando ad essa le ultime speranze. Dunque la lanciò dal di sotto del drappo e stette ad osservarne gli esiti con occhi tremanti.
Un sacchetto di lucido raso verde scivolò sull’acciottolato, fermandosi ai piedi del cavaliere oscuro. Le sporgenti pietre della pavimentazione sciolsero la stretta imboccatura della piccola borsa che lasciò fuoriuscire parte del suo splendente contenuto.
Una moneta d’oro rotolò fino a toccare la punta dello stivale del cacciatore nero.
«Prendili! Sono sicuramente molti di più rispetto a quelli che ti hanno promesso. Ma posso dartene anche il doppio… il triplo! Parliamone… sono sicuro che raggiungeremo un accordo…»
Sistemate le redini attorno al collo robusto del fedele compagno, lo spettro ammantato avanzò di pochi passi soffermandosi presso il sacchetto di raso.
Esitò per qualche momento.
Poi, con fare sprezzante, lo scalciò mediante un rapido movimento del tacco, facendo volare il tintinnante mucchietto d’oro contro il muro laterale.
Engoras imprecò silenziosamente, stringendo i denti e gli occhi nel tempo che seguì.
A un certo punto sentì che la leggera protezione in cui aveva ostinatamente confidato sino all’ultimo gli veniva sollevata lentamente di dosso.
La sua immagine si rivelò in uno stato che mai avrebbe voluto mostrare: adagiato sul fianco meno malconcio si tratteneva la ferita alla spalla con la mano sinistra che non cessava di tremare, scossa dallo spasimo e ancor più dal panico.
Il respiro si era ridotto a un rantolo nervoso.
Torcendo la parte inferiore del corpo in una posa innaturale, aveva cercato di adagiare al meglio la gamba sinistra da cui sporgevano i due sottili pugnali: nell’urto della caduta questi avevano perfezionato il loro compito spingendosi più profondamente nelle carni, e ora lasciar gravare il peso dell’arto non era certo una buona idea.
In quella miserevole condizione, con i suoi bei vestiti ora laceri e impregnati di lerciume, Engoras avrebbe dovuto fronteggiare il suo destino.
E questo non tardò ad avvicinarsi.
Lo sguardo di tenebra tornò a indagare la sua preda più da vicino.
La debole vittima, pervasa dalle più tetre aspettative, lo incontrò con i suoi occhi d’un azzurro divenuto oramai vitreo.
Chi stava guardando? O – per meglio dire – che cosa era costretto a guardare? Perché tanta ostinazione in quell’inseguimento? Perché proprio a lui si era interessato quel terrificante cacciatore?
Di nemici ne aveva accumulato, quello era certo: è doveroso – per chi ha il proposito di arricchirsi in fretta – non avere scrupoli e quindi offendere e danneggiare un gran numero di persone a vantaggio dei propri affari. Ma mai avrebbe immaginato una conseguenza simile, una castigo così terribile per le sue azioni.
C’era qualcosa di anomalo in quel sicario. Qualcosa che esulava dalla semplice commissione di un assassinio; il secco rifiuto di tutto quel denaro lo aveva dimostrato indiscutibilmente.
Nella mente di Engoras si ammassavano innumerevoli strati di angoscia, che però vennero spazzati via bruscamente da qualcosa di peggiore allorché lo spettro, chinandosi su di lui, sembrò volerlo esaminare più da vicino: era per meglio riconoscere la sua vittima o, più probabilmente, per godersi lo spettacolo della sofferenza che aveva provocato con tanta tenacia?
«Sangue… fango… quanto è sottile la differenza in certi casi, non trovi? ».
Il sussurro gelido e imprevisto che si divertiva a schernirlo confermò la seconda ipotesi.
Raccogliendo i frammenti della coscienza che iniziava a sgretolarsi, Engoras proruppe nella domanda che più di tutte lo aveva torturato in quella dannata notte: «Chi… chi diavolo sei?!».
Alla risposta, tuttavia, si sostituì un freddo ordine; il sibilo fluì da un timbro di voce indistinto, ma la sostanza di quelle parole non lasciava spazio a indugi o a repliche.
«Ora mi dirai ciò che voglio sapere…»
Engoras non riuscì a ribattere una parola; si limitava ad ansimare nervosamente. Era l’unica protesta che poteva concedersi. In cuor suo sapeva che non avrebbe potuto far niente per opporsi: sebbene portasse con sé un pugnale, il male alla spalla destra gliene impediva l’utilizzo. E d’altronde non aveva nessuna sicurezza di riuscire vincitore in un duello con il misterioso e temibile avversario.
Il cavaliere dal canto suo sembrò non gradire quell’attesa, e capì di dover essere più convincente.
Risollevò con calma il busto tetramente drappeggiato, e lasciò che il temuto guanto rosso si inabissasse nuovamente nel suo manto scuro per poi fuoriuscirne con una minaccia peggiore di quelle già esibite.
Nera al pari di quella dannata notte, a un palmo dal volto di Engoras egli sospese una grande, spessa e assurda arma. Appariva come una spada, ma fatta di vetro, scolpita, appuntita, affilata senz’altro da una qualche sapienza demoniaca.
Estremamente vicino alla sua pupilla – tanto da permettergli di apprezzarne la micidiale bellezza – il lungo cristallo era simile a un immenso diamante nero, sfumato dai riflessi blu e grigi che si nutrivano della scarsa luce della stradetta. La sua lama aveva un profilo simmetrico, che si allargava e divergeva verso la punta, la quale diveniva molto ampia assieme alle due sporgenze laterali formando una sorta di piatto martello acuminato. Un’altra sezione più larga era presente presso l’elsa, che traspariva attraverso le fini stringhe di cuoio utili per una presa più sicura, e che era composta anch’essa dello stesso nerissimo cristallo. Lo spessore e la lunghezza di quella lama erano a dir poco sproporzionati, tanto da far pensare ad un peso indubbiamente eccessivo per la maggior parte dei normali guerrieri.
Ma al di là di questo, Engoras non poté evitare di notare poco dopo un ulteriore particolare che lo lasciò sconcertato.
Convinto che ciò che stava osservando fosse frutto dell’incubo che ormai lo aveva completamente inghiottendo, egli notò alcuni filamenti rossi, violacei e bluastri, che – ora fini ora più spessi – percorrevano la lama vitrea per quasi tutta la sua lunghezza, convergendo e annodandosi in prossimità della punta.
La sua lucidità era senza dubbio instabile in quel frangente, e a ciò egli dovette imputare la colpa per l’idea che gli balenò nella mente e che avrebbe volentieri scacciato per non accrescere ulteriormente il suo tormento.
Ma gli occhi indagarono ancora: troppo vicini al pericolo, troppo dilatati dalla paura, essi non potevano mentire.
Ora ne era certo.
Quei sottili filamenti, quelle nervature livide e vermiglie non potevano essere altro: vene; vene che attraversavano completamente quell’arma alimentandola, facendola pulsare.
Non era un oggetto, dunque, ma un essere a ipnotizzare la pupilla vacillante dello sventurato mercante.
E presto un sottofondo ancora più inaspettato e sinistro giunse a completare quello scenario irreale, facendolo piombare nell’atmosfera più angosciosa che Engoras potesse mai concepire.
La fonte del lugubre suono pareva essere ancora una volta la spada nera.
Un lamento, dapprima smorzato e rotto, che salì rapidamente a un lungo, intenso, insistente pianto; un gemito straziante, per metà di tristezza e per metà di protesta: il pianto afflitto e inconsolabile di un bambino.
Engoras iniziò a respirare con maggiore difficoltà.
“Questo… questo non può… non può essere, non può essere vero… non può accadere…”
Mentre farfugliava quei confusi sussurri, tutta la razionalità di cui un avido calcolatore come lui si era sempre vantato andava in frantumi, violentata da quell’incubo troppo dannatamente concreto.
Il pianto proseguiva, e adesso sembrava aver paralizzato persino il cavaliere.
In ultimo, un ennesimo dettaglio bizzarro fece la sua comparsa, provvedendo a scuotere stavolta entrambi: sulla punta di quella infernale arma si raccolse lentamente un liquido che presto cominciò a spargersi sul viso di Engoras in piccole gocce terse, come quelle nate da una sottile pioggia estiva o dalla rugiada dell’alba.
Erano gocce leggere e tiepide.
“Non può essere… Queste… queste sono…” continuava a balbettare Engoras, mentre riconosceva la natura di quel liquido che gli era parso quasi estraneo, tanti erano gli anni trascorsi da quando esso era stillato spontaneamente dalle sue palpebre.
“Lacrime…”, sussurrò con le labbra tremanti e sbiancate. Quella parola genere finalmente una reazione nel cavaliere, rimasto immobile come una sinistra statua sino a quel momento. Chiaramente innervosito, egli spostò con uno scatto la punta della spada dalla maschera d’incredulità del mercante.
Con gesti svelti e incuranti avvolse poi la carcassa malconcia di Engoras utilizzando il mantello bruno che ancora lo ricopriva.
E come un sacco di merce di poco valore lo scaraventò sui fianchi poderosi del destriero che era stato diligentemente in attesa.
Il tenebroso fantasma rimontò infine in sella e si rimise in marcia con galoppo spedito.




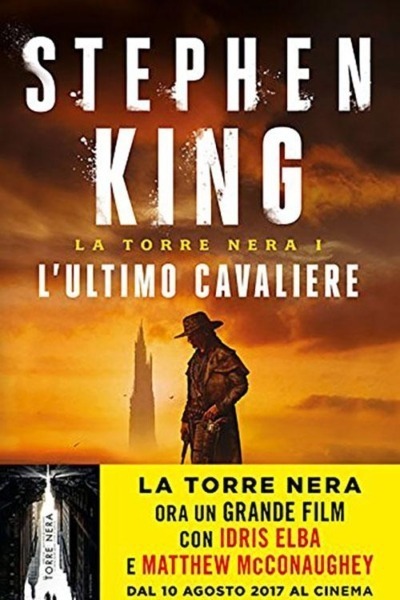
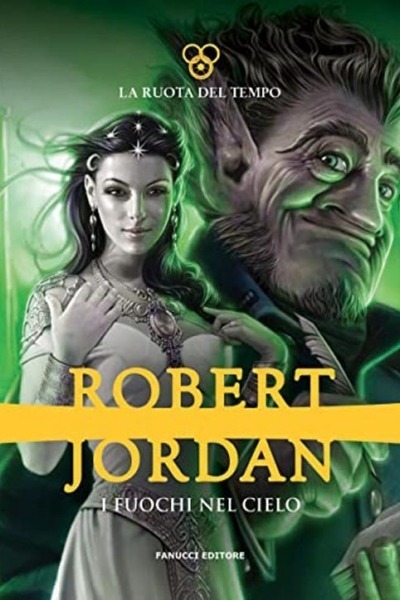

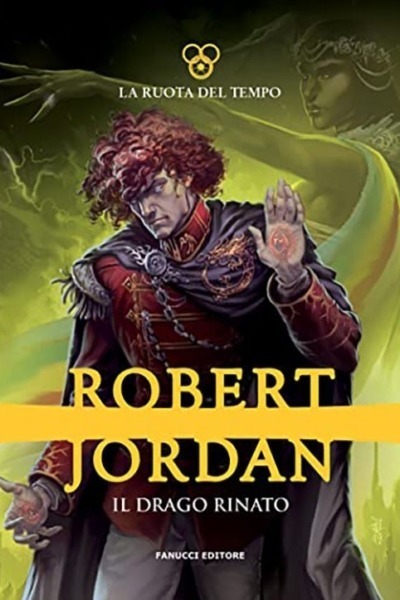
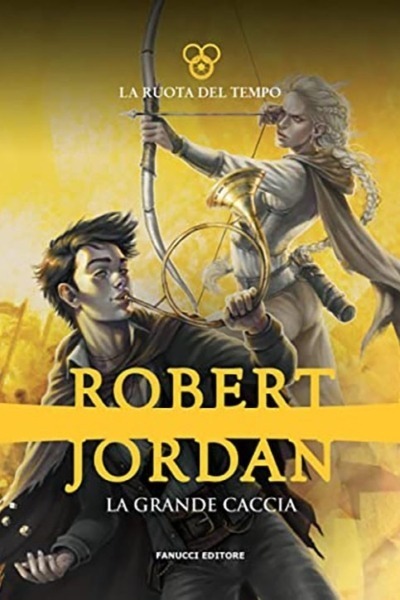
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.