Descrizione
1.
Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell’appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto – gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole – è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o è soltanto un dolore arruffato, senza redenzione.
2.
Ho amato molto mio padre, era un uomo sempre gentile. Aveva modi fini del tutto coerenti con un corpo esile al punto che gli abiti sembravano di una misura in più, cosa che ai miei occhi gli dava un’aria di inimitabile eleganza. Il suo viso era di lineamenti delicati e niente – gli occhi profondi dalle lunghe ciglia, il naso di un’ingegneria impeccabile, le labbra rigonfie – ne guastava l’armonia. Mi si rivolgeva in ogni occasione con un piglio allegro, qualunque fosse il suo umore o il mio, e non si chiudeva nello studio – studiava sempre – se non mi strappava almeno un sorriso. Gli davano gioia soprattutto i miei capelli, ma mi è difficile dire, adesso, quando cominciò a lodarmeli, forse già quando avevo due o tre anni. Di certo, durante la mia infanzia, facevamo conversazioni di questo tipo:
«Che bei capelli, che qualità, che luce, me li regali?».
«No, sono miei».
«Un po’ di generosità».
«Se vuoi te li posso prestare».
«Va benissimo, tanto non te li restituisco più».
«Hai già i tuoi».
«Quelli che ho li ho presi a te».
«Non è vero, dici le bugie».
«Controlla: erano troppo belli e te li ho rubati».
Io controllavo ma per gioco, lo sapevo che non me li avrebbe mai rubati. E ridevo, ridevo moltissimo, mi divertivo più con lui che con mia madre. Voleva sempre qualcosa di mio, un orecchio, il naso, il mento, diceva che erano così perfetti che non poteva vivere senza. Quel tono lo adoravo, mi provava di continuo quanto gli fossi indispensabile.
Naturalmente mio padre non era così con tutti. A volte, quando qualcosa lo coinvolgeva molto, tendeva a sommare in modo agitato discorsi finissimi ed emozioni incontrollate. Altre volte invece tagliava corto e ricorreva a frasi brevi, di estrema precisione, così dense che nessuno ribatteva più. Erano due padri molto diversi da quello che amavo, e avevo cominciato a scoprire la loro esistenza intorno ai sette o otto anni, quando lo sentivo discutere con amici e conoscenti che a volte venivano a casa nostra per riunioni molto accese su problemi di cui non capivo niente. In genere me ne stavo insieme a mia madre in cucina e facevo poco caso a come litigavano pochi metri più in là. Ma a volte, poiché mia madre aveva da fare e si chiudeva anche lei nella sua stanza, io restavo sola in corridoio a giocare o a leggere, soprattutto a leggere, direi, perché mio padre leggeva moltissimo, mia madre pure, e io amavo essere come loro. Non facevo caso alle discussioni, interrompevo il gioco o la lettura solo quando all’improvviso si faceva silenzio e insorgevano quelle voci estranee di mio padre. Da quel momento dettava legge e io aspettavo che la riunione finisse per capire se era tornato a essere il solito, quello con i toni gentili e affettuosi. La sera in cui disse quella frase aveva appena saputo che non andavo bene a scuola. Era una novità. Fin dalla prima elementare ero stata sempre brava e solo negli ultimi due mesi avevo cominciato a far male. Ma i miei genitori tenevano moltissimo alla mia buona riuscita scolastica e mia madre soprattutto, ai primi brutti voti, si era allarmata.
«Che succede?».
«Non lo so».
«Devi studiare».
«Io studio».
«E allora?».
«Certe cose me le ricordo e certe altre no».
«Studia finché non ti ricordi tutto».
Studiavo fino allo stremo, ma i risultati continuavano a essere deludenti. Quel pomeriggio, in particolare, mia madre era andata a parlare con gli insegnanti ed era tornata molto dispiaciuta. Non mi aveva rimproverata, i miei genitori non mi rimproveravano mai. Si era limitata a dire: la più scontenta è la professoressa di matematica, ma ha detto che se vuoi ce la puoi fare. Poi se n’era andata in cucina a preparare la cena e intanto era rientrato mio padre. Dalla mia stanza sentii solo che gli stava riassumendo le lagne dei professori, capii che per giustificarmi tirava in ballo i cambiamenti della prima adolescenza. Ma lui la interruppe e con una delle sue tonalità che con me non usava mai – persino una concessione al dialetto, del tutto proibito in casa nostra – si lasciò uscire di bocca ciò che sicuramente non avrebbe voluto che gli uscisse:
«L’adolescenza non c’entra: sta facendo la faccia di Vittoria».
Se lui avesse saputo che potevo sentirlo, sono sicura che non avrebbe mai parlato a quel modo così distante dalla nostra solita leggerezza divertita. Credevano entrambi che la porta della mia camera fosse chiusa, la chiudevo sempre, e non si resero conto che uno di loro l’aveva lasciata aperta. Fu così che a dodici anni appresi dalla voce di mio padre, soffocata dallo sforzo di tenerla bassa, che stavo diventando come sua sorella, una donna nella quale – gliel’avevo sentito dire fin da quando avevo memoria – combaciavano alla perfezione la bruttezza e la malvagità.
Qui mi si potrebbe obiettare: forse stai esagerando, tuo padre non disse alla lettera: Giovanna è brutta. È vero, non era nella sua natura pronunciare parole così brutali. Ma mi trovavo in un periodo di grande fragilità. Avevo le mestruazioni da quasi un anno, i seni erano fin troppo visibili e me ne vergognavo, temevo di puzzare, mi lavavo in continuazione, andavo a dormire svogliata e mi svegliavo svogliata. L’unico mio conforto, in quel periodo, l’unica mia certezza, era che lui adorava assolutamente tutto di me. Sicché, nel momento in cui mi accostò a zia Vittoria, fu peggio che se avesse detto: Giovanna una volta era bella, adesso è diventata brutta. Il nome Vittoria suonava in casa mia come quello di un essere mostruoso che macchia e infetta chiunque sfiori. Di lei sapevo poco o niente, l’avevo vista rarissime volte ma – e questo è il punto – ricordavo di quelle occasioni soltanto il disgusto e la paura. Non il disgusto e la paura che poteva avermi fatto lei in carne e ossa, non ne avevo alcuna memoria. A spaventarmi erano il disgusto e la paura che ne avevano i miei genitori. Mio padre, da sempre, parlava oscuramente della sorella, come se lei praticasse riti vergognosi che la insozzavano insozzando chiunque la frequentasse. Mia madre invece non la menzionava mai e anzi, quando interveniva negli sfoghi del marito, tendeva a zittirlo come se temesse che lei, dovunque si trovasse, riuscisse a sentirli e subito corresse su per San Giacomo dei Capri a grandi falcate sebbene fosse una via lunga ed erta, e si trascinasse dietro di proposito tutte le malattie degli ospedali con cui confinavamo, volasse fino a casa nostra al sesto piano, spaccasse il mobilio lanciando neri lampi ubriachi dagli occhi, la schiaffeggiasse se solo provava a protestare.
Certo, intuivo che dietro quella tensione ci doveva essere una storia di torti fatti e ricevuti, ma sapevo poco, all’epoca, di vicende familiari e soprattutto non consideravo quella zia terribile una persona di famiglia. Lei era uno spauracchio dell’infanzia, era una sagoma secca e spiritata, era una figura arruffata in agguato negli angoli delle case quando cala il buio. Possibile dunque che così, senza alcun preambolo, dovessi scoprire che stavo facendo la sua faccia? Io? Io che fino a quel momento mi ero creduta bella e ritenevo, grazie a mio padre, che tale sarei rimasta per sempre? Io che per sua continua ammissione pensavo di avere capelli splendidi, io che volevo essere amatissima come lui mi amava, come mi aveva abituata a credermi, io che già soffrivo perché sentivo entrambi i miei genitori all’improvviso scontenti di me, e quella scontentezza mi agitava opacizzando ogni cosa?
Attesi le parole di mia madre, ma la sua reazione non mi confortò. Pur odiando tutti i parenti del marito e pur detestando la cognata come si detesta una lucertola che ti corre su per la gamba nuda, non reagì gridandogli: sei pazzo, tra mia figlia e tua sorella non c’è niente in comune. Si limitò invece a un fiacco, brevissimo: che dici, ma no. E io, lì nella mia stanza, corsi a chiudere la porta per non sentire altro. Poi piansi in silenzio e smisi solo quando mio padre tornò ad annunciare – questa volta con la voce buona – che era pronta la cena.
Li raggiunsi in cucina a occhi asciutti, dovetti sopportare, sguardo nel piatto, una serie di consigli utili per migliorare il mio rendimento scolastico. Dopo me ne tornai a fingere di studiare, mentre loro si accomodavano davanti al televisore. Provavo un dolore che non voleva cessare e nemmeno attenuarsi. Perché mio padre aveva pronunciato quella frase, perché mia madre non l’aveva contraddetto con forza? Era stato un loro scontento dovuto ai brutti voti o un allarme che prescindeva dalla scuola, che durava chissà da quando? E lui, lui soprattutto, aveva pronunciato quelle brutte parole per un dispiacere momentaneo che gli avevo dato, o col suo sguardo acuto, di persona che sa e vede ogni cosa, aveva individuato da tempo i tratti di un mio guasto futuro, di un male che stava avanzando e che lo sconfortava e contro cui lui stesso non sapeva come comportarsi? Mi disperai tutta la notte. Al mattino mi convinsi che, se volevo salvarmi, dovevo andare a vedere com’era realmente la faccia di zia Vittoria.



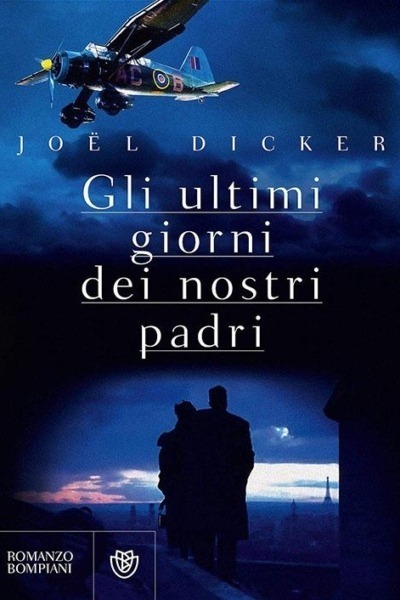
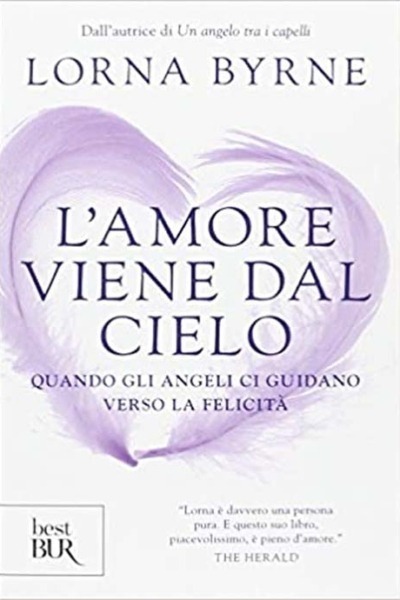

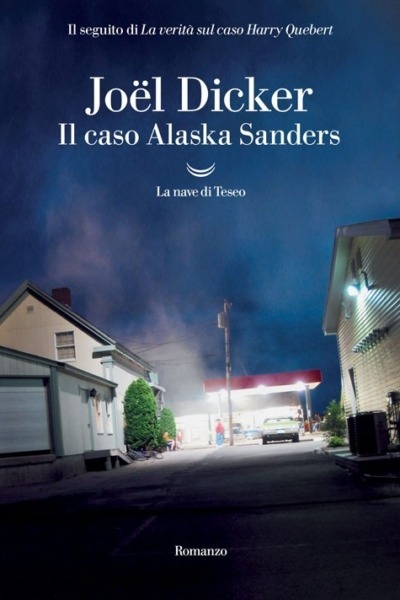

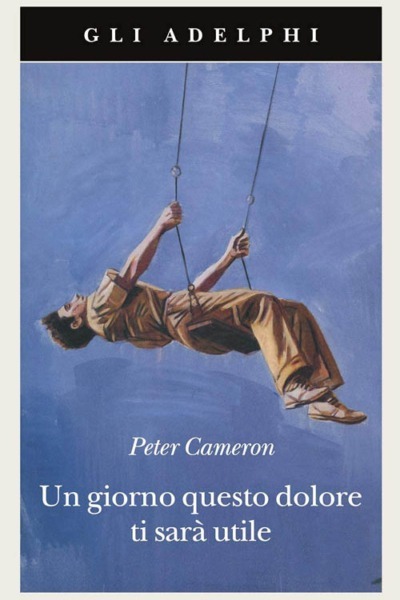
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.