Descrizione
I
Il Genova è attraccato
Lanciai un’occhiata di là dalle finestre del comando, verso la rada di Massaua.
L’unica traccia del piroscafo Genova erano le colonne di fumo nero che si stagliavano in lontananza, come due scarabocchi di carbone sul cielo azzurro. L’orologio appeso alla parete segnava le otto e mezzo.
«È in ritardo almeno di un paio d’ore», dissi rivolto all’uomo che sedeva un po’ più in là, dietro una scrivania che la corporatura robusta rendeva troppo piccola.
«Hanno avuto dei problemi all’attracco di Porto Said», rispose il maresciallo Barbagallo, «anche se il mare era calmo non sono poi riusciti a recuperare. Tempo mezz’ora e inizieranno a sbarcare i primi passeggeri.»
L’arrivo di una nave nel porto di Massaua era sempre un avvenimento. Bastava che un qualsiasi mercantile gettasse l’ancora alla Banchina, come era familiarmente chiamato lungomare Umberto I, perché decine di persone si accalcassero sul molo, sgomitando per conquistare la prima fila vicino alla passerella. I più veloci ad arrivare erano i ragazzini eritrei, alla ricerca di una qualsiasi valigia da portare fino al più vicino albergo in cambio di una manciata di centesimi. Poi era il turno dei venditori d’acqua e dei commercianti arabi, e nel giro di qualche minuto si avvicinavano alla banchina anche gli italiani, a partire dagli ispettori della dogana, che si facevano largo a pedate fra gli scugnizzi e i facchini del porto.
Quando poi arrivava da Genova il postale celere della Compagnia Italiana Transatlantica oppure il piroscafo mensile del Lloyd Triestino, l’attesa diventava frenetica. La nave era ancora impegnata nelle manovre d’ingresso nel porto e si apprestava appena a oltrepassare il promontorio di Abd el Cadér, in direzione delle banchine Salvago Raggi e Regina Elena, che già il lungomare brulicava di folla. Vedevi accorrere i soldati in attesa della posta e i fattorini degli uffici coloniali in attesa del funzionario di turno, mentre i factotum degli alberghi cittadini – dal Grande Albergo al Savoia, fino ai più modesti
Ghedém e Manetti – scrutavano come rapaci i passeggeri che scendevano dalla nave, in cerca di clienti.
Lungo la Banchina non mancava neppure la solita dozzina di sfaccendati, che passeggiavano svogliatamente su e giù per il molo. Per lo più era gente che campava di piccoli traffici, ai margini della legge. Alcuni avevano trasferito in Africa Orientale il millenario mestiere del ruffiano e se ne andavano tenendo a braccetto donne dal trucco pesante e dallo sguardo invitante. Così, tanto per fare un po’ di réclame alla mercanzia.
Quel 10 marzo 1935 la Città Vecchia appariva più animata del solito. Negli ultimi tempi l’arrivo di navi dalla madrepatria – soprattutto convogli militari – si era intensificato, ma l’imminente attracco del Genova veniva considerato il vero avvenimento della settimana. Tutto merito della famosa compagnia di varietà di Pippo Lanzafame, che aveva scelto Massaua come prima tappa della sua tournée nelle colonie. Il capocomico, gli attori e le ballerine erano attesi con impazienza dalla buona società italiana in Eritrea, che in verità non aveva molte occasioni di assistere a spettacoli mondani. Dopo un paio d’esibizioni a Massaua, Lanzafame e i suoi avrebbero preso le valigie per Cheren e Agordat, per poi proseguire fino ad Asmara, dove il varietà sarebbe rimasto in cartellone per un’intera settimana, sul palcoscenico dell’omonimo teatro, di fianco alla Casa del Fascio.
A ritornarci col pensiero sembra ieri l’altro, invece è passata quasi una vita. Avevo poco più di quarant’anni ed ero maggiore in servizio presso il comando di Massaua della compagnia Carabinieri d’Eritrea. Ricordo con chiarezza le sensazioni che in quel momento stavo vivendo: non l’avrei ammesso neppure sotto tortura o dietro esplicita domanda di sua maestà il re, ma quella mattina, a spingermi tra la folla assiepata sul lungomare, non erano solo ragioni legate al mio ufficio. E neppure la curiosità.
Certo, nella sonnolenta Massaua non capitava spesso di poter accantonare le occupazioni di routine per incontrare una compagnia di artisti, acclamata in patria come uno dei sodalizi più popolari dello spettacolo leggero. Ma c’era dell’altro. I miei gradi mi avrebbero permesso di avvicinarmi senza alcuna difficoltà a Pippo Lanzafame e ai suoi compagni. E anche a Virginia Mariani, una delle due vedette dello spettacolo Avanti c’è posto, il varietà che l’anno prima aveva sbancato i teatri di mezz’Italia.
L’avevo conosciuta nel 1925 a Firenze, dove ero tenente dell’Arma in servizio presso la compagnia Centro. Poco più che ventenne, prima ballerina di una compagnia di livello regionale, per alcuni mesi Virginia aveva accettato la mia corte sobria e fin troppo discreta. Poi mi aveva piantato per un industrialotto conciario, che ogni sera le invadeva il camerino con dozzine di mazzi di rose. Era stata solo una passioncella giovanile, mi andavo ripetendo, nulla di più. Un amore intenso sfiorito in fretta, che fino a un paio di giorni prima non aveva più dato segno di vita, covando sotto la cenere dei ricordi. Eppure, dopo aver letto il suo nome sul giornale, era come se un piccolo tarlo avesse cominciato a rodermi il cervello. Lento ma inesorabile. Un paio di volte, redigendo i soliti rapporti nell’afa dell’ufficio, mitigata a stento dalle pale del ventilatore sul soffitto, mi ero sorpreso a pensare a Virginia, la penna sospesa nella mano destra e lo sguardo perso oltre la finestra.
«Che bischero», era stato il mio commento, che avrebbe voluto essere ironico. L’avevo detto a bassa voce, per non farmi sentire dal maresciallo, con accento volutamente toscano, così come l’avrebbe pronunciato lei. Un ulteriore sintomo della mia bischeraggine.
«Che bischero», tornai a mormorare mentre fendevo la folla per raggiungere il punto di attracco del piroscafo. Barbagallo mi seguiva due passi più indietro, accigliato come sempre, ma in realtà ben felice di abbandonare le scartoffie del comando per calarsi nel mondo dorato dello spettacolo. Forse il sottufficiale già pregustava il resoconto che avrebbe fatto quella sera alla moglie, un donnone brontolone e lamentoso che però lo adorava, tanto da lasciare senza batter ciglio la natìa Nizza Monferrato per seguirlo in Africa Orientale.
«Sulle ballerine, però, preferisco sorvolare», disse strizzando l’occhio. «Mi raccomando, signor maggiore: se uno di questi giorni incontrate mia moglie non ne fate cenno. Sapete come sono le donne…»
Dalla passerella del Genova i primi passeggeri stavano già scendendo. Risposi appena al saluto militare di un paio di doganieri, mi avvicinai al molo e riconobbi da lontano la figura di Lanzafame, che avevo visto una volta a Roma, un paio d’anni prima di imbarcarmi per l’Eritrea. Impossibile sbagliarsi. Un tipo alto e allampanato, con i radi capelli impomatati, baffi e pizzetto che s’iniziavano a ingrigire, l’aria ascetica ravvivata da due occhietti neri che non stavano mai fermi. Indossava un completo di lino bianco e chiacchierava con un ometto sui cinquant’anni dal volto rubicondo, quasi calvo.



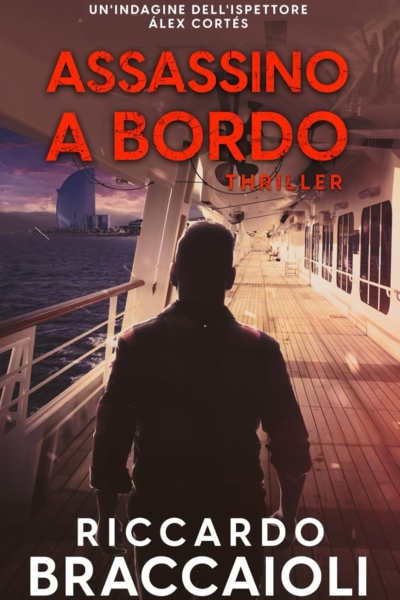
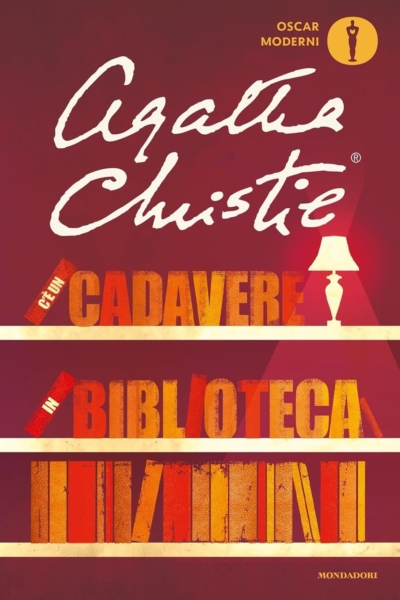



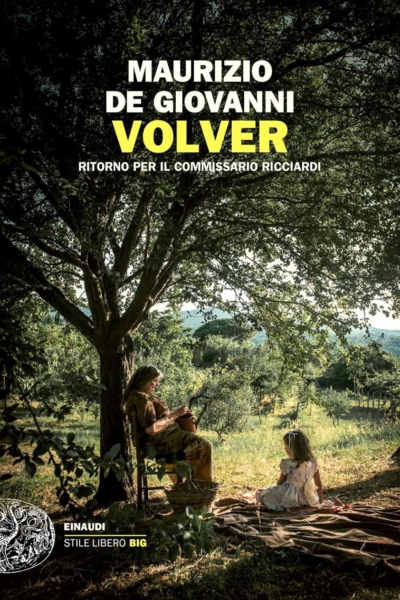
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.