Descrizione
1.
Mio padre è morto un anno fa. Io non credo alla teoria secondo cui si diventa veramente adulti solo alla morte dei genitori; veramente adulti non lo si diventa mai.
Davanti alla sua bara ho avuto pensieri incresciosi. Si era goduto la vita, quel vecchio porco; se l’era spassata alla grande. “Ti sei riprodotto…” gli dissi fra me e me con una certa foga, “hai ficcato il tuo grosso uccello nella fica di mia madre.” Diciamo pure che ero piuttosto teso: non capita tutti i giorni di avere un morto in famiglia. Il cadavere m’ero rifiutato di vederlo. Ho quarant’anni, e di cadaveri ne ho già visti abbastanza; adesso preferisco evitare. Che poi è il motivo per cui non ho mai voluto animali domestici.
E non mi sono neanche sposato. Di occasioni per farlo ne ho avute diverse; ma ho sempre lasciato perdere. Comunque le donne mi piacciono, e pure tanto. In effetti il celibato un po’ mi pesa. È seccante soprattutto per le vacanze. La gente diffida degli scapoli in vacanza, soprattutto se di una certa età: li considerano persone molto egoiste e anche un po’ dissolute; difficile dargli torto.
Dopo il funerale sono tornato nella casa dove mio padre aveva trascorso gli ultimi anni di vita. Il cadavere l’avevano trovato una settimana prima. Un po’ di polvere era già andata accumulandosi sui mobili e negli angoli delle stanze; nel vano di una finestra ondeggiava una ragnatela. Tempo, entropia e compagnia bella stavano dunque cominciando la loro opera di pacifico impossessamento della casa. Il congelatore era vuoto. Sulle scansie della cucina c’erano perlopiù flaconi di proteine aromatizzate, tavolette energetiche, pasti monodose Weight Watchers. Gironzolai per il pianterreno sgranocchiando un biscotto arricchito con sali di magnesio. Poi scesi nel seminterrato a fare un po’ di cyclette. A settant’anni suonati mio padre godeva di una condizione fisica decisamente migliore della mia. Faceva un’ora al giorno di ginnastica intensiva, più un paio di vasche di piscina due volte la settimana. Nei fine-settimana giocava a tennis e andava in bici con alcuni coetanei; ne avevo conosciuti un paio al funerale. “Ci faceva neri!…” aveva esclamato un ginecologo. “Aveva dieci anni più di noi, ma riusciva a darci la birra anche in salita!” Padre, padre mio, mi dissi, quant’era grande la tua vanità. Nell’angolo sinistro del mio campo visivo intravedevo una panca per il sollevamento pesi, e a terra un paio di manubri. Visualizzai per un attimo un deficiente in pantaloncini corti – pieno di rughe, ma per il resto molto simile a me – che gonfiava i pettorali con un fervore privo di speranza. Padre mio, mi dissi, hai edificato la tua casa sulla sabbia. Continuavo a pedalare, però sentivo che già cominciava a mancarmi il fiato, e mi dolevano le cosce; eppure ero appena al livello 1. Ripensando al funerale mi rendevo conto di aver fatto un’ottima impressione, in generale. La mia barba è sempre rasata di fresco, le mie spalle sono strette; i capelli li porto molto corti, abitudine presa una decina d’anni fa, quando hanno cominciato a diradarsi. In genere indosso completi grigi, cravatte discrete, e non ho l’aria molto allegra. Coi miei capelli corti, i miei occhiali leggeri e la mia faccia imbronciata, chinando un poco la testa per ascoltare un bel mix di inni funebri cristiani, in quella situazione mi sentivo proprio a mio agio – molto più a mio agio che a un matrimonio, per esempio. I funerali erano decisamente il mio forte. Smisi di pedalare, tossii piano. La notte calava rapidamente sui prati tutt’attorno. Per terra, accanto alla struttura di cemento che ospitava la caldaia, si scorgeva una chiazza scura, che qualcuno aveva invano cercato di lavar via dal pavimento. Era lì che era stato trovato mio padre, col cranio sfondato e indosso un paio di pantaloncini corti e una maglietta I LOVE NEW YORK. La morte risaliva a tre giorni prima, secondo il medico legale. In linea di principio si sarebbe potuto ipotizzare un incidente: poteva esser scivolato su una chiazza di olio della caldaia, o qualcosa del genere. Ma il pavimento del locale era perfettamente asciutto; e il cranio era fratturato in diversi punti, con addirittura un po’ di cervello schizzato sul pavimento; quindi, molto più verosimilmente, doveva trattarsi di omicidio. Il capitano Chaumont, della polizia di Cherbourg, mi aveva annunciato una sua visita in serata.
Tornato in soggiorno accesi il televisore, un Sony con schermo 16:9 da 82 cm, dolby surround e lettore dvd incorporato. Su TF1 c’era un episodio di Xena la guerriera, uno dei miei telefilm preferiti; due donne muscolosissime, entrambe in minigonna di pelle e reggipetto d’acciaio, si sfidavano brandendo minacciosamente le sciabole. “Il tuo regno è durato troppo, Tagratha!” gridava la bionda. “Io sono Xena, la guerriera delle Pianure Occidentali!” Qualcuno bussò alla porta; azzerai il volume.
Fuori era scesa la notte. Il vento agitava piano i rami madidi di pioggia. Una ragazza sui venticinque anni, di tipo nordafricano, era ferma sulla soglia. “Mi chiamo Aïcha,” disse. “Facevo le pulizie per il signor Renault due volte la settimana. Sono venuta a riprendere le mie cose.”
“Ah bene…” feci io, “ah bene…” Accompagnai quelle parole con un gesto, una specie di gesto che voleva essere accogliente. La ragazza entrò, lanciò una rapida occhiata allo schermo del televisore: adesso le due guerriere lottavano corpo a corpo sul ciglio di un cratere fumante; suppongo che scene del genere abbiano una certa presa sul pubblico lesbico. “Spero di non disturbarla,” disse Aïcha, “ne avrò per cinque minuti al massimo.”
“Lei non mi disturba affatto,” dissi. “In effetti non c’è niente che mi disturbi.” La ragazza annuì come se condividesse il concetto, i suoi occhi indugiarono per qualche istante sul mio viso; forse per valutare la somiglianza fisica con mio padre, magari inferendo un qualche grado di rassomiglianza morale. Dopo avermi studiato per qualche secondo si voltò e si avviò su per la scala che portava al primo piano. “Faccia con comodo,” dissi io con voce soffocata, “faccia pure con comodo…” Lei non rispose, né rallentò la salita; probabilmente non mi aveva neanche sentito. Stremato dal confronto, mi lasciai cadere sul divano. Avrei dovuto suggerirle di togliersi il cappotto; è quello che in genere si fa con gli ospiti, suggerire di togliersi il cappotto. Fu allora che mi resi conto che lì dentro faceva un freddo cane – un freddo umido e penetrante, un freddo da spelonca. Non sapevo come si accendesse la caldaia, non mi andava di provarci; mio padre era morto e io avrei dovuto andarmene di corsa. Passai su FR3 giusto in tempo per seguire l’ultima tornata di Questions pour un champion. Nel momento in cui una certa Nadège, originaria del Val-Fourré, annunciava a Julien Lepers di voler rimettere in gioco per la terza volta il proprio titolo, Aïcha comparve sulle scale, con una piccola borsa da viaggio a tracolla. Spensi il televisore, mi affrettai ad andarle incontro. “Ho sempre provato una grande ammirazione per Julien Lepers,” le dissi. “Anche quando non ha una conoscenza specifica delle città o dei paesi d’origine dei concorrenti, riesce comunque a dire qualcosa quantomeno sulla zona, sulla regione; dimostra una cognizione approssimativa e tuttavia partecipe del clima, delle bellezze naturali. E, soprattutto, conosce la vita: per lui i concorrenti sono esseri umani, di cui intuisce tanto le difficoltà quanto le piccole gioie. Non c’è nulla della realtà umana dei concorrenti che gli sia estraneo o indifferente. Qualunque sia l’indole del concorrente, Julien Lepers riesce sempre a farlo parlare del lavoro che fa, della famiglia che ha, delle passioni che coltiva – insomma, di tutto ciò che, ai suoi occhi, può dar luogo a una vita. Molto spesso i concorrenti fanno parte di una banda di paese, o di una filodrammatica; si dedicano all’organizzazione di qualche festa locale, o si interessano a qualche causa umanitaria. Spesso hanno con sé i figli, che li seguono con trepidazione dagli spalti dello studio televisivo. In genere quella trasmissione dà l’impressione che la gente sia felice, e noi stessi alla fine ci sentiamo più felici e migliori. Non trova?”
La ragazza mi guardò senza sorridere; aveva i capelli raccolti a crocchia, il viso poco truccato, gli abiti decisamente sobri; una ragazza seria. Dopo qualche secondo di esitazione, con voce bassa e leggermente arrochita dalla timidezza, disse: “Volevo molto bene a suo padre.” Non avevo di che risponderle; mi sembrava molto strano, ma in fondo possibile. Il vecchio doveva essere una fucina di aneddoti: era stato in Colombia, in Kenya o chissà in quali altri posti; gli era capitato di guardare col binocolo due rinoceronti. Ogni volta che ci vedevamo si divertiva a ironizzare sul mio status di funzionario pubblico, sulla sicurezza del posto fisso. “Hai trovato la cuccagna, eh?” ripeteva, senza curarsi di nascondere il suo disprezzo; fra consanguinei le cose sono sempre un po’ difficili. “Studio da infermiera,” proseguì Aïcha, “e sono andata via da casa, quindi devo mantenermi facendo la cameriera.” Mi scervellai alla ricerca di una risposta adeguata; dovevo chiederle informazioni sul costo medio degli affitti lì a Cherbourg? Alla fine optai per un “Eh sì…” cercando di farne trasparire una certa qual comprensione della vita. Come risposta parve bastarle, e se ne andò. Mi incollai alla finestra per guardare la sua Volkswagen Polo che faceva manovra sul sentiero fangoso. Su FR3 c’era un telefilm rurale ambientato probabilmente nel XIX secolo, con Tchéky Karyo nel ruolo di bracciante agricolo. Tra una lezione di pianoforte e l’altra, la figlia del padrone – interpretato da Jean-Pierre Marielle – accordava certe libertà al seducente campagnolo. I loro incontri avvenivano in una stalla; sprofondai nel sonno proprio mentre Tchéky Karyo, con notevole gagliardia, le strappava di dosso le mutande d’organza. L’ultima cosa di cui ebbi coscienza fu una dissolvenza incrociata su un piccolo branco di maiali.
Fui svegliato dal dolore, e dal freddo; dovevo essermi addormentato in una posizione stramba, avevo la cervicale pressoché paralizzata. Mentre mi alzavo in piedi ebbi un violento accesso di tosse, e nell’aria gelida del soggiorno si formarono effimere nuvolette d’alito. Sullo schermo, stranamente, c’erano le immagini di Très pêche, un programma di TF1: evidentemente dovevo essermi svegliato, o quantomeno aver raggiunto un livello di vigilanza sufficiente ad azionare il telecomando; non me ne ricordavo affatto. Quella puntata era dedicata ai pesci-siluro, grossi pesci sprovvisti di squame, diventati sempre più frequenti nei fiumi francesi in seguito all’innalzamento delle temperature medie; si dimostravano particolarmente attratti dalle centrali nucleari. Il servizio sui pesci-siluro tendeva a far luce su determinati miti: sì, i pesci-siluro adulti raggiungevano lunghezze dai tre ai quattro metri; anzi, nella Drôme erano stati segnalati esemplari di oltre cinque metri, cosa tutt’altro che inverosimile. Era invece categoricamente da escludere che potessero manifestare inclinazioni carnivore, o che potessero aggredire i bagnanti. Il sospetto popolare che circondava i pesci-siluro sembrava per certi versi contagiare chi si dedicava alla loro pesca; la grande famiglia dei pescatori non vedeva di buon occhio la piccola confraternita dei pescatori di pesci-siluro. E costoro ne soffrivano e desideravano approfittare della trasmissione per ribaltare quell’immagine negativa. Certo, non potevano ricorrere a motivazioni gastronomiche: le carni del siluro erano decisamente immangiabili. Però si trattava di una bella pesca, al tempo stesso intelligente e sportiva, che vantava qualche analogia con quella del luccio, e meritava di fare nuovi proseliti. Mossi qualche passo nel soggiorno, senza peraltro riuscire a scaldarmi; non sopportavo l’idea di andarmi a coricare nel letto di mio padre. Alla fine, dopo esser salito a prendere un cuscino e un paio di coperte, mi sistemai alla bell’e meglio sul divano. Spensi dopo i titoli di coda de Il siluro controverso. La notte era fosca; il silenzio pure.
2.
Tutto giunge a una fine, anche la notte. Venni strappato da un letargo saurico dalla voce chiara e sonora del capitano Chaumont; si scusava, la sera prima non aveva avuto tempo di passare. Gli offrii un caffè. Mentre l’acqua si scaldava, il capitano piazzò sul tavolo della cucina un computer portatile e una minuscola stampante, e li collegò. Così avrebbe potuto farmi rileggere e firmare la deposizione prima di andarsene; ebbi un sussurro di approvazione. La polizia, troppo impegnata con le mansioni amministrative, lamentava di non avere abbastanza tempo da dedicare alla propria vera missione: l’indagine – come avevo avuto modo di apprendere da svariati servizi televisivi sull’argomento. Il capitano Chaumont approvò con trasporto. Ecco un interrogatorio che partiva da ottime basi, in un’atmosfera di reciproca fiducia. Windows si attivò con un rumorino gaio.
La morte di mio padre risaliva alla sera/notte del 14 novembre. Quel giorno lavoravo; lavoravo altresì il 15. Era chiaro che avrei potuto prendere la macchina, andare a uccidere mio padre, e rientrare in nottata. Cosa facevo la sera/notte del 14? Niente, per quanto ne sapevo; niente di particolare. Comunque qualcosa di cui non avevo alcuna memoria; eppure era passata sì e no una settimana. Non avevo né una compagna stabile né veri e propri amici intimi; in simili condizioni come si fa a ricordare qualcosa? Le giornate passano, tutto qua. Lanciai uno sguardo desolato al capitano Chaumont; mi sarebbe piaciuto aiutarlo, o quantomeno orientarlo in una specifica direzione di indagine. “Vado a consultare l’agenda…” dissi. Da quella consultazione non mi aspettavo niente; invece, stranamente, alla data del 14 corrispondeva un numero di cellulare, con sopra un nome: “Coralie”. Coralie chi? In quell’agenda c’era proprio di tutto.
“Mi spiace, ma ho il cervello in vacca…” dissi al capitano, con un sorriso avvilito. “Non so, forse ero a una mostra.”
“Una mostra?” Attendeva pazientemente, con le dita a mezz’aria sopra la tastiera.
“Sì, lavoro al Ministero della Cultura. Preparo le pratiche per il finanziamento di mostre e spettacoli.”
“Spettacoli?”
“Sì, spettacoli… di danza contemporanea…” Mi sentivo disperato, annientato dalla vergogna.
“Quindi lei opera nelle attività culturali.”
“Sì, esatto… nelle attività culturali.” Mi fissava con una simpatia soffusa di severità. Era a conoscenza dell’esistenza di un universo culturale, una conoscenza vaga ma reale. Il suo lavoro doveva metterlo a contatto con gente di ogni tipo; non c’era ambiente sociale che potesse essergli totalmente estraneo. La formazione umanistica della polizia.
Il resto dell’interrogatorio si svolse più o meno normalmente; avendo visto parecchi telefilm polizieschi ero piuttosto preparato a quel tipo di dialogo. Mi risultava che mio padre avesse dei nemici? No, però neanche amici, a dire il vero. Comunque mio padre non era abbastanza importante per avere nemici. Chi poteva trarre vantaggio dalla sua morte? Be’, io. A quando risaliva la mia ultima visita? Probabilmente ad agosto. In agosto non c’è mai molto da fare in ufficio, e i miei colleghi sono costretti ad andare al mare per via dei figli. Io invece resto a Parigi, faccio solitari al computer e, verso il 15, vado a trovare mio padre a Cherbourg per due o tre giorni. Dunque ero in buoni rapporti con mio padre? Sì e no. Più no che sì, e comunque andavo a fargli visita un paio di volte l’anno, in fondo non era mica poco.
Il capitano Chaumont scosse la testa. Capii che la mia deposizione volgeva al termine; peccato, avrei voluto avere qualcos’altro da dirgli. Provavo per quell’uomo una simpatia irragionevole, quasi morbosa. Stava già caricando la stampante.
“Mio padre era molto sportivo!” buttai lì, quasi gridando. Il capitano Chaumont alzò su di me uno sguardo interrogativo. “Non so…” dissi allargando le braccia in un gesto sconsolato, “volevo solo dire che era molto sportivo.” Con un secco movimento della mano, il capitano Chaumont avviò la stampa.
Dopo aver firmato la deposizione lo accompagnai alla porta. Gli dissi che mi rendevo conto di essere un testimone inadeguato. “Tutti i testimoni sono inadeguati…” replicò lui. Meditai per qualche secondo su quell’aforisma. Davanti a noi si stendeva la sconfinata noia dei campi. Il capitano Chaumont montò sulla sua Peugeot 305; mi avrebbe tenuto al corrente dei progressi dell’indagine. In caso di decesso di un ascendente diretto, i dipendenti pubblici usufruiscono di un permesso di tre giorni. Quindi avrei potuto prendermela comoda, magari fare un giretto lì attorno in cerca di formaggi genuini; invece imboccai subito l’autostrada per Parigi.
Trascorsi la mia ultima giornata di permesso in varie agenzie di viaggio. Adoravo i cataloghi delle agenzie di viaggio, la loro astrazione, il loro modo di ridurre i luoghi del mondo a una circoscritta sequenza di possibili soddisfazioni e di tariffe; in special modo apprezzavo il sistema di classificazione tramite stelle per indicare i diversi gradi di felicità cui si poteva aspirare. Io non ero felice, però apprezzavo la felicità, e continuavo ad aspirarvi. Secondo il modello di Marshall, l’acquirente è un individuo razionale teso a massimizzare la propria soddisfazione in relazione al prezzo; il modello di Veblen, invece, analizza l’influenza del gruppo sul processo di acquisto (a seconda che l’individuo intenda identificarcisi o sottrarvisi). Il modello di Copeland dimostra che il processo d’acquisto varia in virtù della categoria di prodotto/servizio (acquisto impulsivo, acquisto ponderato, acquisto specializzato); ma il modello Baudrillard-Becker sostiene che consumare implichi altresì produrre segni. Tutto sommato, mi sentivo più vicino al modello di Marshall.
Tornato al lavoro, annunciai a Marie-Jeanne che avevo bisogno di vacanze. Marie-Jeanne è la mia collega; è con lei che prepariamo le pratiche delle varie mostre, cioè che ci adoperiamo per la cultura contemporanea. È una donna di trentacinque anni, coi capelli biondi e lisci, e gli occhi di un blu chiarissimo; della sua vita intima non so assolutamente niente. Sul piano gerarchico, Marie-Jeanne è in posizione leggermente superiore alla mia; ma è un particolare che lei preferisce ignorare, nel senso che tende a sottolineare come il nostro dipartimento faccia leva sul lavoro di squadra. Ogni volta che riceviamo la visita di una persona veramente importante – tipo un delegato della Direzione Arti Plastiche, o un membro del gabinetto del ministro – Marie-Jeanne insiste su questo concetto di squadra. “Ed ecco l’uomo più importante del dipartimento!…” esclama entrando nel mio ufficio. “Colui che tiene in equilibrio cifre e bilanci contabili… Senza di lui mi sentirei completamente persa.” Poi, in genere, si mette a ridere; i visitatori importanti si mettono a ridere anche loro, o quantomeno sorridono felici. Sorrido anch’io, per quanto mi sia possibile. Cerco di vedermi nei panni di giocoliere, con cifre e bilanci contabili in equilibrio sul naso; ma in realtà il mio lavoro consiste nel fare calcoli semplicissimi. In senso stretto, Marie-Jeanne non fa assolutamente niente, eppure il compito più difficile è proprio il suo: deve tenersi al corrente delle tendenze, delle mode, dei movimenti; essendosi assunta una responsabilità culturale, corre costantemente il rischio di vedersi accusata di immobilismo, se non addirittura di oscurantismo; è un rischio dal quale deve difendersi, difendendo così anche l’istituzione. Perciò si tiene in contatto continuo con artisti, galleristi, direttori di riviste per me del tutto oscure; quei contatti, cioè in pratica quelle telefonate, la rendono felice, poiché la sua passione per l’arte contemporanea è genuina. Per parte mia, diciamo che l’arte contemporanea non mi fa orrore: non sono un fautore dell’accademia, né del ritorno alla tradizione in pittura; mantengo l’atteggiamento distaccato che si confà a chi debba far quadrare i conti. Le questioni estetiche e politiche non mi riguardano; non ho l’ambizione di inventare o adottare nuovi orientamenti, nuovi rapporti col mondo; ho rinunciato a farlo quando le mie spalle hanno cominciato a curvarsi e la mia fisionomia a evolvere verso la tristezza. Ho assistito a mostre, a inaugurazioni, a esibizioni memorabili. La mia conclusione è ormai incontrovertibile: l’arte non può cambiare la vita. Di sicuro non la mia.
Avevo informato Marie-Jeanne del lutto che mi aveva colpito; la sua accoglienza fu estremamente partecipe; mi mise addirittura una mano sulla spalla. Giudicava naturale e sacrosanta la mia domanda di ferie. “Michel, tu hai bisogno di fare il punto della situazione,” mi disse, “hai bisogno di rientrare in te stesso.” Cercai di visualizzare la manovra che mi proponeva, decisi che aveva senz’altro ragione. “Cecilia chiuderà il piano previsionale al posto tuo,” proseguì Marie-Jeanne. “Glielo dirò io appena la vedo.” Di che diavolo stava parlando, e chi era Cecilia?
Guardandomi attorno notai una bozza di manifesto, e allora ricordai. Cecilia era una ragazzona dai capelli rossi che ingurgitava una quantità impressionante di cioccolatini Cadbury e che lavorava con noi da un paio di mesi: una CDD, ovvero una TUC;* insomma una con un curriculum alquanto trascurabile e conseguentemente destinata a una permanenza limitata. Poco prima della morte di mio padre, in effetti, stavo appunto lavorando al piano previsionale della mostra Mani in alto, manigoldi! che si sarebbe inaugurata in gennaio a Bourg-la-Reine: brutalità delle forze dell’ordine nella regione delle Yvelines, documentate fotograficamente col teleobiettivo; ma non si trattava di un lavoro documentaristico, piuttosto di un processo di teatralizzazione dello spazio, accompagnato da ammiccamenti a varie serie televisive aventi per protagonista il famigerato Los Angeles Police Department. L’artista aveva privilegiato un approccio scanzonato anziché quello, scontato, della denuncia sociale. In poche parole, era un progetto interessante, tra l’altro non troppo caro né complesso; perfino una zuccona come Cecilia era in grado di finalizzare il piano previsionale.
Di solito, quando uscivo dall’ufficio, facevo un salto in un peep-show. Mi costava cinquanta franchi, o settanta quando l’eiaculazione tardava. Vedere fiche in movimento mi sgombrava il cervello. Gli indirizzi contraddittori della video-arte contemporanea, l’equilibrio tra conservazione del patrimonio e sostegno all’espressività contemporanea… tutta quella roba spariva in un baleno davanti alla facile magia della fica in movimento. Evacuavo con garbo i miei testicoli. Alla stessa ora, Cecilia si ingozzava di dolci al cioccolato in una pasticceria nei pressi del ministero; le nostre motivazioni erano quasi le stesse.
Qualche volta, ma di rado, prendevo un salottino privato a cinquecento franchi; questo avveniva quando il mio uccello faceva i capricci, e me lo vedevo come un’appendice pretenziosa, inutile e olezzante di formaggio; allora avevo bisogno che una ragazza lo prendesse in mano e, ancorché per finta, si entusiasmasse per il suo vigore, per la ricchezza del suo seme. Comunque non rincasavo mai dopo le sette e mezzo. A quel punto cominciavo con Questions pour un champion, di cui avevo programmato la registrazione col mio vhs; poi continuavo con i telegiornali nazionali. La crisi della mucca pazza non mi interessava granché, visto che mi nutrivo quasi esclusivamente di purè Mosuline al formaggio. E così via, tutta la sera. Non mi sentivo infelice, avevo centoventotto canali. Verso le due del mattino concludevo la serata con qualche commedia musicale turca.
Passarono così alcuni giorni, in un’atmosfera relativamente serena, fino a quando ricevetti una nuova telefonata del capitano Chaumont. L’indagine aveva fatto passi avanti decisivi, lui e i suoi uomini avevano trovato il presunto assassino, poi rivelatosi ben più che presunto, visto che in pratica aveva confessato l’omicidio. Di lì a due giorni avrebbero effettuato una ricostruzione del delitto, volevo assistere? “Oh sì,” dissi, “eccome.”
Marie-Jeanne si complimentò per questa decisione coraggiosa; mi parlò di elaborazione del lutto, di enigma della filiazione; utilizzava termini socialmente corretti, perlopiù ricavati da un lessico di modesta entità, ma non importava: sentivo che quella donna provava per me dell’affetto, il che era sorprendente, ed era bello. Le donne almeno provano affetto, mi dissi mentre salivo sul treno per Cherbourg; perfino nel lavoro tendono a stabilire rapporti affettivi, fanno fatica a muoversi in un universo privo di rapporti affettivi, è un’atmosfera in cui stentano a esprimersi. Hanno questa debolezza, le donne, e le pagine “psico” di Marie Claire glielo rammentano costantemente: farebbero meglio a operare una netta separazione tra l’ambito professionale e quello affettivo; tuttavia non ci riescono, e le pagine “testimonianza” di Marie Claire lo documentano con altrettanta costanza. All’altezza di Rouen ripensai agli sviluppi dell’indagine. La grande scoperta del capitano Chaumont si riduceva al fatto che Aïcha aveva intrattenuto “rapporti intimi” con mio padre. Con che frequenza, e fino a che punto? Questo non lo sapeva, e d’altronde era un elemento rivelatosi inutile ai fini dello svolgimento dell’indagine. Uno dei fratelli di Aïcha aveva prontamente confessato di essere andato a “chiedere spiegazioni” al vecchio, di non esser riuscito a impedire che la discussione degenerasse, e di averlo lasciato morto sul pavimento, accanto alla caldaia.
La ricostruzione del delitto era teoricamente condotta dal giudice istruttore, un ometto segaligno e austero in pantaloni di flanella e polo scura, col viso deformato da un persistente ghigno di fastidio; ma sin dall’inizio il capitano Chaumont si rivelò il vero maestro di cerimonia. Vispo e allegro, accoglieva cordialmente i vari partecipanti, offriva a ciascuno una parola di benvenuto, gli indicava il suo posto; sembrava proprio contento. Era il suo primo caso di omicidio, e l’aveva risolto in meno di una settimana; era lui l’unico vero eroe di quella storia sordida e banale. Aïcha, rannicchiata su una sedia, visibilmente prostrata, con i capelli fermati da una fascia nera, quando entrai sollevò appena lo sguardo; evitava ostentatamente di guardare il fratello. Questi, stretto fra due poliziotti, fissava con espressione stolida il pavimento. Aveva proprio l’aria del criminale da strapazzo; nei suoi confronti non provavo la minima pietà. Poi alzò gli occhi, e incrociò il mio sguardo; sicuramente mi identificò. Dovevano averlo avvisato, dunque conosceva il mio ruolo: secondo la sua mentalità da bruto, io vantavo nei suoi confronti un sacro diritto di vendetta, ero lì per esigere il suo sangue come risarcimento del sangue di mio padre. Consapevole del rapporto instauratosi fra noi, lo fissai senza abbassare lo sguardo; mi lasciai lentamente pervadere dall’odio, sentii il mio respiro farsi più fluido, una sensazione piacevole e intensa. Se avessi disposto di un’arma lo avrei accoppato senza esitazione. Ammazzare quel piccolo farabutto mi sembrava un atto non solo legittimo, ma decisamente positivo, salutare. Un poliziotto tracciò col gessetto dei segni sul pavimento, e la ricostruzione ebbe inizio. Secondo l’imputato le cose erano molto semplici: nel corso della discussione si era innervosito e aveva dato una violenta spinta a mio padre; questi era caduto all’indietro e si era fracassato il cranio sul pavimento; preso dal panico, l’omicida si era dato alla fuga.
Ovviamente mentiva, e il capitano Chaumont non ebbe alcuna difficoltà a dimostrarlo. L’esame del cranio della vittima rivelava un inconfutabile accanimento da parte dell’aggressore: si riscontravano contusioni multiple, probabilmente dovute a una serie di calci, e inoltre il viso di mio padre era stato ripetutamente sbattuto contro uno spigolo, al punto di provocare la fuoriuscita di un occhio dall’orbita. “Non so…” farfugliò l’imputato, “ero accecato dalla rabbia.” Osservando le sue braccia nerborute e il suo volto gretto e malvagio non era difficile credergli: aveva agito senza premeditazione, probabilmente eccitato dallo schianto del cranio sul pavimento e dalla vista del sangue. La sua linea difensiva era chiara e credibile, sicuramente gli avrebbe consentito di cavarsela egregiamente in tribunale: qualche annetto con la condizionale, nulla di più. Il capitano Chaumont, soddisfatto per l’andamento della ricostruzione, si accingeva a concludere. Mi alzai dalla sedia, avvicinandomi a una finestra. Scendeva la sera: nei campi i montoni si apprestavano a terminare la giornata. Pure loro erano stupidi, probabilmente anche più del fratello di Aïcha; ma nei loro geni non era programmata nessuna azione violenta. Giunti all’ultima sera della loro vita avrebbero belato di terrore, il loro ritmo cardiaco si sarebbe fatto più rapido, le loro zampe si sarebbero agitate disperatamente; poi sarebbe arrivato il colpo di pistola, la loro vita si sarebbe esaurita, il loro corpo si sarebbe trasformato in cibo. Ci lasciammo con una stretta di mano; il capitano Chaumont mi ringraziò di aver partecipato.
Rividi Aïcha l’indomani; su consiglio dell’agente immobiliare avevo deciso di fare pulire a fondo la casa prima delle visite dei potenziali acquirenti. Le diedi le chiavi, lei si offrì di accompagnarmi alla stazione di Cherbourg. L’inverno cominciava ad assediare il boschetto, masse di nebbia si addensavano sopra le siepi. Non era facile starle accanto. Aveva conosciuto gli organi sessuali di mio padre, e questo tendeva a creare un’intimità un po’ incongrua. Ancora non riuscivo a crederci: mi sembrava una ragazza seria, e mio padre non aveva nulla del seduttore. Evidentemente doveva possedere qualche tratto, qualche caratteristica seducente che non ero stato capace di cogliere; in realtà stentavo già solo a ricordare i suoi lineamenti. Gli uomini vivono gli uni accanto agli altri come buoi; è già molto se riescono, di tanto in tanto, a condividere una bottiglia di vino.
La Volkswagen di Aïcha si fermò nel piazzale della stazione; mi resi conto che prima di separarci conveniva pronunciare qualche parola. “Be’…” dissi. Poi, dopo qualche secondo, fu lei a parlare. “Ho deciso di andarmene da qui,” disse, con voce sorda. “Ho un amico che può trovarmi un posto come cameriera a Parigi; così potrò continuare i miei studi. Tanto, ormai i miei mi considerano una puttana.” Emisi un sussurro partecipe. “A Parigi c’è molta più gente…” riuscii finalmente a dire, stremato. L’estrema vacuità della mia replica non parve scoraggiarla. “La mia famiglia non ha più niente da darmi,” proseguì rancorosamente Aïcha. “Non solo sono poveri, sono pure stronzi. Due anni fa mio padre è andato in pellegrinaggio alla Mecca; da allora non c’è più verso di farlo ragionare. I miei fratelli, poi, non ne parliamo: bevono pastis dalla mattina alla sera, beandosi della propria coglionaggine e credendosi i depositari della vera fede, e per giunta si permettono di trattarmi come una puttana per il semplice fatto che preferisco lavorare anziché sposare qualche coglione del loro stampo.”
“Già, nell’insieme i musulmani non sono granché…” dissi io, imbarazzatissimo. Presi la borsa da viaggio e aprii lo sportello. “Penso che riuscirà a cavarsela benissimo, Aïcha…” mormorai, poco convinto. In quell’istante ebbi una specie di visione dei flussi migratori che attraversavano l’Europa; i musulmani vi figuravano come coaguli difficili da assorbire. Aïcha mi guardava, dubbiosa. Nell’abitacolo si riversavano ondate di gelo. Mentalmente riuscivo a provare una certa attrazione per la vagina delle musulmane. Sorrisi, però in maniera un po’ forzata. Sorrise anche lei, con più naturalezza. Le strinsi la mano, gliela tenni stretta a lungo, avvertivo il calore delle sue dita, continuai a stringere fino a sentire il sangue che pulsava piano nel polso. A qualche metro dalla macchina mi voltai per farle un piccolo cenno con la mano. Se non altro c’era stato un incontro; se non altro, alla fine, era successo qualcosa.
Salendo sul vagone della Corail mi dissi che avrei dovuto darle dei soldi. Ma poi che no, avevo fatto bene a non dargliene, meglio evitare malintesi. Fu lì, in quel momento, che per la prima volta ebbi la consapevolezza che sarei diventato un uomo ricco; cioè, relativamente ricco. Lo storno dei conti di mio padre era già stato effettuato. Per il resto avevo affidato la vendita della macchina a un’autofficina e quella della casa a un’agenzia immobiliare; tutto sistemato nel modo più semplice. Il valore di quei beni era sancito dalle leggi di mercato. Certo, c’era comunque un margine di trattativa: 10% di oscillazione rispetto al valore di mercato, non di più. Anche le tasse non erano un mistero: bastava consultare gli accuratissimi opuscoli pubblicati dalla Direzione delle Imposte.
Mio padre doveva aver più volte pensato di diseredarmi; poi, evidentemente, aveva rinunciato; forse si era detto che era troppo complicato, che c’erano troppi passaggi da fare, per giunta per un risultato nient’affatto sicuro (giacché è tutt’altro che facile diseredare i propri figli: le possibilità concesse dalla legge sono molto limitate – e così va a finire che quei maledetti mocciosi, dopo avervi intossicato la vita, finiscono per mangiarsi tutto quello che avete messo da parte con tanta fatica). Soprattutto doveva essersi detto che, in fondo, la cosa non aveva la minima importanza – già, che cazzo gliene poteva fregare di cosa succedeva dopo la sua morte? Secondo me era stato proprio quello il suo ragionamento. Comunque il vecchio bastardo aveva tirato le cuoia, e io avrei rivenduto la casa dove aveva trascorso i suoi ultimi anni di vita; così come avrei ceduto il Toyota Land Cruiser con cui si portava a casa le sue belle confezioni di Evian comprate all’ipermercato Géant Casino di Cherbourg. E io, io che abitavo vicino all’Orto Botanico, cosa me ne sarei fatto di un Toyota Land Cruiser? Al massimo potevo usarlo per andare a comprare ravioli alla ricotta al mercatino di Rue Mouffetard. Quando si tratta di eredità in linea diretta, le tasse di successione non sono molto gravose – e questo vale anche in caso di rapporti affettivi non particolarmente intensi. Al netto, dunque, prevedevo di intascare qualcosa come tre milioni di franchi. Il che costituiva all’incirca l’equivalente di quindici volte il mio stipendio annuale. E costituiva altresì l’equivalente di quanto, in Europa occidentale, un operaio non qualificato potesse sperare di guadagnare in un’intera vita di lavoro; niente male. C’era di che cavarsela; quantomeno c’era di che cominciare a provarci.
Sicuramente nel giro di qualche settimana avrei ricevuto una lettera dalla banca. Mentre il treno si avvicinava a Bayeux cominciai a immaginare come si sarebbe svolta la conversazione. Il preposto dell’agenzia, notato l’ingente saldo attivo del mio conto corrente, avrebbe manifestato il proposito di scambiare quattro chiacchiere con me – chi può dire di non aver bisogno, in questo o quel momento della propria vita, di un interlocutore finanziario? Un po’ diffidente, io gli avrei esposto il mio desiderio di orientarmi più che altro su opzioni sicure; lui avrebbe accolto questa reazione – così frequente – con un sorrisetto bonario. La maggior parte degli investitori alle prime armi, lo sapeva bene, privilegiano la sicurezza rispetto al rendimento; un atteggiamento che gli operatori del settore ben conoscevano. Per carità, non dovevo fraintenderlo: in materia di gestione patrimoniale anche le persone più mature si comportano da perfetti neofiti. Per parte sua desiderava attirare la mia attenzione su uno scenario leggermente diverso – lasciandomi, beninteso, tutto il tempo di riflettere. Perché non impiegare, per esempio, due terzi del mio patrimonio liquido in un investimento sicuro ma a basso reddito – e il restante terzo in un investimento un po’ avventuroso, ma dal potenziale reddituale decisamente più interessante? Dopo qualche giorno di riflessione, lo sapevo perfettamente, mi sarei arreso alle sue argomentazioni. Lui si sarebbe sentito rincuorato dal mio assenso, avrebbe preparato la documentazione con un fremito di eccitazione – e la nostra stretta di mano, al momento di separarci, sarebbe stata apertamente calorosa.
Vivevo in un paese caratterizzato da un socialismo sedato, dove il possesso di beni materiali era tutelato da una legislazione rigorosa, e il sistema bancario era assoggettato a rigide garanzie statali. Se non mi fossi avventurato fuori dai confini della legalità non avrei rischiato né malversazioni né fallimenti dolosi. Insomma, non dovevo più preoccuparmi granché. D’altronde, non è che mi fossi mai preoccupato più di tanto: terminati gli studi, giudiziosamente anche se non brillantemente, mi ero subito orientato verso il settore pubblico. Eravamo in pieni anni ottanta, all’inizio della modernizzazione del socialismo, ovvero all’epoca in cui l’illustre Jack Lang spargeva fasto e gloria sulle istituzioni culturali di stato; il mio stipendio era stato soddisfacente sin dall’inizio. E poi ero invecchiato, assistendo senza turbamenti ai successivi rimescolamenti politici. Ero garbato, corretto, apprezzato da superiori e colleghi; data l’indole tutt’altro che espansiva, non ero riuscito a farmi dei veri amici. La sera calava rapidamente sulla regione di Lisieux. Perché, nel mio lavoro, non avevo mai manifestato una passione paragonabile a quella di Marie-Jeanne? Perché, più in generale, nella mia vita non ero mai riuscito a manifestare alcun tipo di passione?
Passò ancora qualche settimana, senza fornirmi risposte; poi, al mattino del 23 dicembre, presi un taxi per Roissy.




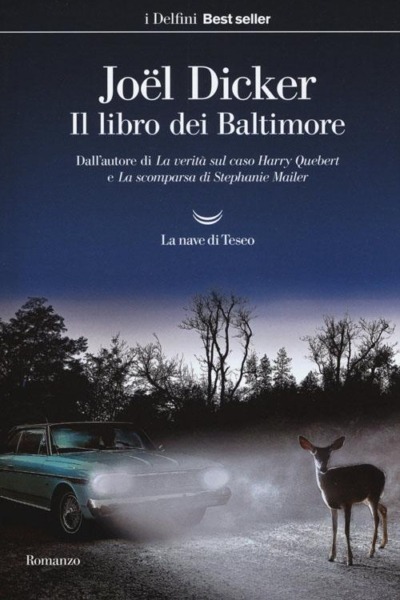



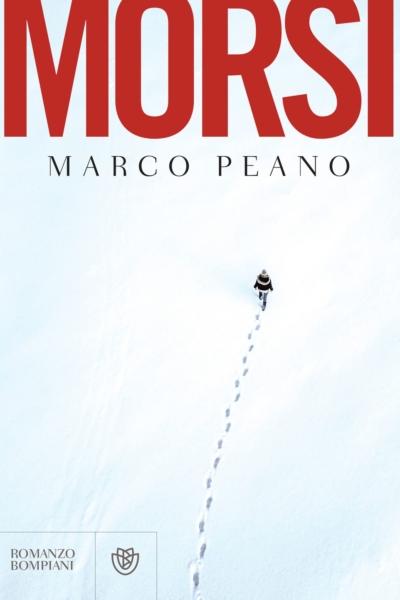
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.