Descrizione
1. Benedetta maledizione
UNA buona occasione nella vita si presenta sempre. Il problema è saperla riconoscere e a volte non è facile. La mia, per esempio, aveva tutta l’aria di essere una maledizione. «Attento! Nel 1993 corri un gran rischio di morire. In quell’anno non volare. Non volare mai», m’aveva detto un indovino.
Era successo a Hong Kong. Avevo incontrato quel vecchio cinese per caso. Sul momento quelle parole m’avevano ovviamente colpito, ma non me ne ero fatto un gran cruccio. Era la primavera del 1976, e il 1993 pareva ancora lontanissimo. Quella scadenza però non l’avevo dimenticata. M’era rimasta in mente, un po’ come la data di un appuntamento cui non si è ancora deciso se andare o no.
1977… 1987… 1990… 1991. Sedici anni, specie se visti dalla prospettiva del primo giorno, sembrano tanti, ma, come tutti gli anni, tranne quelli dell’adolescenza, passarono velocissimi e presto mi ritrovai alla fine del 1992. Che fare? Prendere sul serio quel vecchio cinese e riorganizzare la mia vita, tenendo conto del suo avvertimento? O far finta di niente e tirare avanti dicendomi: «Al diavolo gli indovini e le loro fandonie»?
A quel punto avevo vissuto in Asia, ininterrottamente, per più di un ventennio – prima a Singapore, poi a Hong Kong, Pechino, Tokyo, infine a Bangkok – e pensai che il miglior modo di affrontare quella «profezia» fosse il modo asiatico: non mettercisi contro, ma piegarcisi.
«Allora ci credi?» mi stuzzicavano i colleghi-giornalisti, specie quelli occidentali, gente avvezza a voler sempre un netto sì o no a tutte le domande; anche a quelle mal poste come questa. Uno non ha bisogno di credere alle previsioni del tempo per uscire di casa con l’ombrello in una giornata nuvolosa. La pioggia è una possibilità, l’ombrello una precauzione. Perché provocare la sorte se proprio quella ti fa un cenno, ti dà un suggerimento? Al tavolo della roulette quando il nero è uscito tre o quattro volte di seguito ci sono giocatori che, contando sulle probabilità statistiche, puntano allora tutto quel che hanno sul rosso. Io no. Ripunto sul nero. Non è in questo senso che la pallina mi ha fatto l’occhiolino?
E poi a me l’idea di non volare per un anno intero piaceva di per sé. Soprattutto come sfida. Pretendere che un vecchio cinese di Hong Kong potesse avere la chiave del mio futuro mi divertiva moltissimo. Mi pareva di fare un primo passo in un terreno ignoto. Ero curioso di vedere dove altri passi in quella direzione mi avrebbero portato. Se non altro mi avrebbero indotto a fare, per un po’, una vita diversa da quella di sempre.
Per anni ho viaggiato in aereo e, andando per mestiere nei posti più balordi del mondo dove sono in corso guerre, scoppiano rivoluzioni o accadono terribili disastri, mi è capitato ovviamente più di una volta di stare con il fiato sospeso, di atterrare con un motore in fiamme o con un meccanico che all’ultimissimo momento riesce, a colpi di martello in una botola aperta fra i sedili, a far scendere il carrello che si rifiutava di uscire dalla pancia.
Avessi nel 1993 ignorato la profezia e avessi volato come niente fosse, lo avrei certo fatto con una dose in più di quella solita inquietudine che prima o poi prende tutti coloro – piloti compresi – che han passato gran parte del loro tempo per aria; ma sostanzialmente avrei continuato nella mia routine: aerei, taxi, alberghi, taxi, aerei.
Quel divino avvertimento (già: «indovino», «divino», così simili?!) mi dava l’occasione, direi mi imponeva, di introdurre una variante nei miei giorni.
La profezia era la scusa. La verità è che uno a cinquantacinque anni ha una gran voglia di aggiungere un pizzico di poesia alla propria vita, di guardare al mondo con occhi nuovi, di rileggere i classici, di riscoprire che il sole sorge, che in cielo c’è la luna e che il tempo non è solo quello scandito dagli orologi. Questa era la mia occasione e non potevo lasciarmela scappare.
Il problema era come fare: rinunciare per un anno al mio lavoro? prendere una lunga vacanza o continuare a lavorare, pur con questa limitazione? Il giornalismo è ormai dominato, come molte altre professioni, dall’elettronica. Computer, modem, velocità hanno un ruolo preponderante; la brevità e la tempestività delle immagini televisive trasmesse via satellite hanno stabilito nuovi standard e il giornalismo stampato, invece che puntare sulla riflessione e sul personale, non fa che correre dietro e cercare di imitare l’imbattibile immediatezza, e con ciò anche la superficialità, della TV.
Nei giorni del massacro sul Tien An Men, la CNN trasmetteva in diretta dalla piazza nel centro di Pechino e molti colleghi preferivano stare nella loro camera d’albergo davanti al televisore invece che andare a vedere di persona quel che succedeva a poche centinaia di metri. Era il modo più veloce di tenersi aggiornati, di seguire gli avvenimenti. Per giunta i loro direttori e capiredattori a migliaia di chilometri di distanza vedevano sui loro televisori le stesse immagini e quella diventava la verità; la sola. Inutile andare a cercarne un’altra.
Come avrebbero reagito i miei direttori all’idea di avere in Asia un corrispondente che, per un suo schiribizzo, decide di non volare per un intero anno? Cosa avrebbero pensato di uno che, nel 1993, diventa improvvisamente un giornalista da inizio del secolo, uno di quelli che partivano allo scoppio di una guerra e spesso arrivavano quando era già finita?
L’occasione di verificarlo venne nell’ottobre del 1992. Uno dei due capiredattori di Der Spiegel passò da Bangkok e una sera, dopo cena, senza tanti preamboli, gli raccontai la storia dell’indovino di Hong Kong e gli parlai della mia intenzione di passare il 1993 senza prendere aerei.
«Ora che m’ha detto questo, come vuole che io le chieda di volare a Manila quando ci sarà il prossimo colpo di Stato o in Bangladesh per il prossimo tifone? Faccia come crede», fu la sua risposta. Come al solito magnifici, quei miei lontani gestori! Capirono che da quel mio sfizio poteva nascere una storia diversa, che avremmo potuto offrire al lettore qualcosa che gli altri non avevano.
La reazione di Der Spiegel mi tolse ovviamente un peso, ma non per questo presi allora la decisione. La «profezia» scattava con l’inizio dell’anno nuovo e mi riservai di decidere all’ultimissimo momento, allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre dovunque mi fossi trovato. Fu nella foresta del Laos. Il «cenone» era stato una omelette di uova di formiche rosse; per brindare non c’era champagne, ma sollevando un bicchiere d’acqua fresca presi formalmente con me stesso l’impegno di non cedere, per nessuna ragione, a nessun costo, alla tentazione di volare. Avrei viaggiato il mondo con ogni mezzo possibile purché non fosse un aereo, un elicottero, un aliante o un deltaplano.
Fu una splendida decisione e l’anno 1993 è finito per essere uno dei più straordinari che io abbia passato: avrei dovuto morirci e son rinato. Quella che pareva una maledizione s’è dimostrata una vera benedizione.
Muovendomi fra l’Asia e l’Europa in treno, in nave, in macchina, a volte anche a piedi, il ritmo delle mie giornate è completamente cambiato, le distanze hanno ripreso il loro valore e ho ritrovato nel viaggiare il vecchio gusto di scoperta e di avventura.
D’un tratto, senza più la possibilità di correre a un aeroporto, pagare con una carta di credito, schizzar via ed essere, in un baleno, letteralmente dovunque, sono stato costretto a riguardare al mondo come a un intreccio complicato di paesi divisi da bracci di mare che vanno attraversati, da fiumi che vanno superati, da frontiere per ognuna delle quali occorre un visto; e un visto speciale che dica «via terra», come se questa via, specie in Asia, fosse nel frattempo diventata così insolita da rendere automaticamente sospetto chiunque si ostini a usarla.
Spostarsi non è stato più questione di ore, ma di giorni, di settimane. Per non fare errori, prima di mettermi in viaggio, ho dovuto guardare bene le carte, rimettermi a studiare la geografia. Le montagne sono tornate a essere possibili ostacoli sul mio cammino e non più delle belle, irrilevanti rifiniture in un paesaggio visto da un oblò.
Il viaggiare in treno o in nave, su grandi distanze, m’ha ridato il senso della vastità del mondo e soprattutto m’ha fatto riscoprire un’umanità, quella dei più, quella di cui uno, a forza di volare, dimentica quasi l’esistenza: l’umanità che si sposta carica di pacchi e di bambini, quella cui gli aerei e tutto il resto passano in ogni senso sopra la testa.
Impormi di non volare è diventato un gioco pieno di sorprese. A far finta, per un po’, d’esser ciechi si scopre che, per compensare la mancanza della vista, tutti gli altri sensi si affinano. Il rifiuto degli aerei ha un effetto simile: il treno, con i suoi agi di tempo e i suoi disagi di spazio, rimette addosso la disusata curiosità per i particolari, affina l’attenzione per quel che si ha attorno, per quel che scorre fuori del finestrino. Sugli aerei presto si impara a non guardare, a non ascoltare: la gente che si incontra è sempre la stessa; le conversazioni che si hanno sono scontate. In trent’anni di voli mi pare di non ricordarmi di nessuno. Sui treni, almeno quelli dell’Asia, no! L’umanità con cui si spartiscono i giorni, i pasti e la noia non la si incontrerebbe altrimenti e certi personaggi restano indimenticabili.
Appena si decide di farne a meno, ci si accorge di come gli aerei ci impongono la loro limitata percezione dell’esistenza; di come, essendo una comoda scorciatoia di distanze, finiscono per scorciare tutto: anche la comprensione del mondo. Si lascia Roma al tramonto, si cena, si dorme un po’ e all’alba si è già in India. Ma un paese è anche tutta una sua diversità e uno deve pur avere il tempo di prepararsi all’incontro, deve pur fare fatica per godere della conquista. Tutto è diventato così facile oggi che non si prova più piacere per nulla. Il capire qualcosa è una gioia, ma solo se legato a uno sforzo. Così con i paesi. Leggere una guida, saltando da un aeroporto all’altro, non equivale alla lenta, faticosa acquisizione – per osmosi – degli umori della terra cui, con il treno, si rimane attaccati.
Raggiunti in aereo, senza un minimo sforzo nell’avvicinarli, tutti i posti diventano simili: semplici mete separate fra di loro solo da qualche ora di volo. Le frontiere, in realtà segnate dalla natura e dalla storia e radicate nella coscienza dei popoli che ci vivono dentro, perdono valore, diventano inesistenti per chi arriva e parte dalle bolle ad aria condizionata degli aeroporti, dove il «confine» è un poliziotto davanti allo schermo di un computer, dove l’impatto con il nuovo è quello con il nastro che distribuisce i bagagli, dove la commozione di un addio viene distratta dalla bramosia del passaggio obbligato attraverso il free duty shop, ormai uguale dovunque.
Le navi si avvicinano ai paesi entrando con lento pudore nelle bocche dei loro fiumi; i porti lontani tornano a essere delle agognate destinazioni, ognuna con la sua faccia, ognuna con il suo odore. Quel che un tempo si chiamavano i terreni d’aviazione erano anche loro un po’ così. Oggi non più. Gli aeroporti, falsi come i messaggi pubblicitari, isole di relativa perfezione anche nello sfacelo dei paesi in cui si trovano, si assomigliano ormai tutti; tutti parlano nello stesso linguaggio internazionale che dà a ciascuno l’impressione di essere arrivato a casa. Invece si è solo arrivati in una qualche periferia da cui bisogna ripartire, in autobus o in taxi, per un centro che è sempre lontanissimo.
Le stazioni invece no, sono vere, sono specchi delle città nel cui cuore sono piantate. Le stazioni stanno vicino alle cattedrali, alle moschee, alle pagode o ai mausolei. Una volta arrivati lì, si è arrivati davvero.


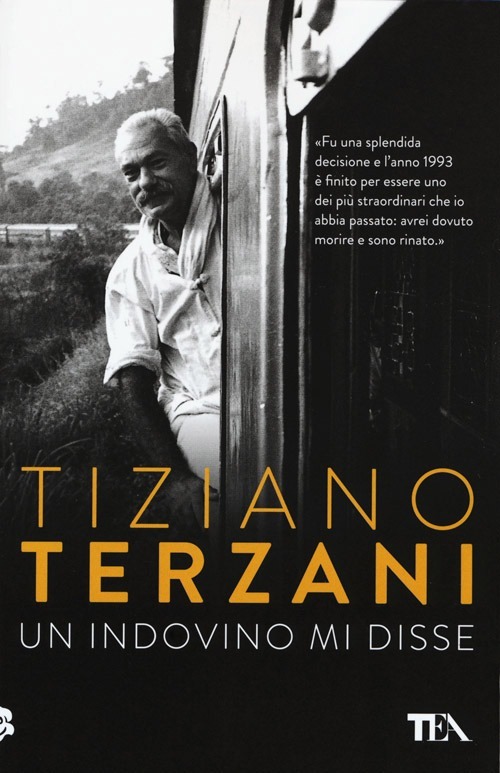



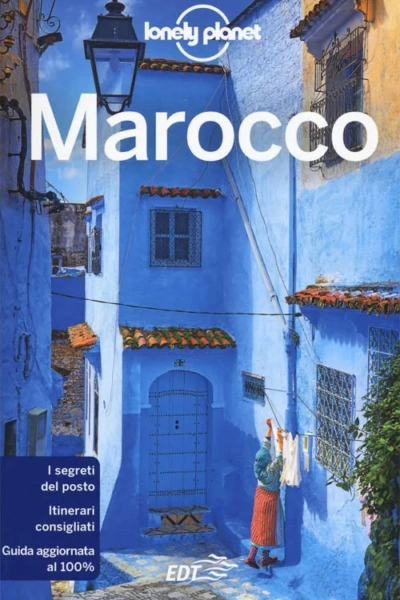


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.