Descrizione
I
Il camionista
Da più un un’ora l’autocarro risaliva i tornanti della pista per Ailet. Il Ceirano 47 rombava con ritmo regolare, arrancando con fragore nel momento di dover superare le asperità della strada. Le manone dell’autista tenevano saldo il volante per evitare che pietre e buche sviassero la traiettoria del mezzo pesante.
«Meglio stare attenti», pensò il conducente.
Non si era ancora arrivati in cima e sulla destra della camionabile un precipizio di un centinaio di metri non prometteva niente di buono. Approfittando di un breve rettilineo pianeggiante, l’uomo tirò fuori dalla tasca un fazzolettone bianco a righine azzurre e si asciugò il sudore sulla fronte e sul collo. Si deterse pure i baffoni risorgimentali, ormai intrisi di una sottile polvere grigia. Il caldo afoso di Massaua era ormai alle spalle, ma ci sarebbe voluto ancora un po’ per raggiungere l’aria fresca e ristoratrice dell’altopiano eritreo.
«Bele-sì a fa sempre ’na caud, boia fauss!» mormorò a mezza voce.
Quando pensava o parlava fra sé e sé, lo faceva sempre in piemontese. Abitudini d’infanzia. A Nizza Monferrato, dov’era nato e cresciuto fino all’età di vent’anni, l’italiano era merce rara. Solo i signori lo parlavano. E qualche napuli giunto fra quelle colline per lavorare in ferrovia o negli uffici statali. Che poi magari era gente che arrivava da Ancona o Viterbo, ma per quelli del posto sempre di napuli si trattava, anche se lo dicevano in senso buono.
Pochi chilometri prima, attraversando a Dògali il torrente Desset, non aveva potuto trattenere un sorriso pieno d’orgoglio leggendo la frase incisa sulla trave in cemento, all’imbocco del ponte: «Ch’a custa lon ch’a custa». A quanto ne sapeva, il motto, dedicato al generale Menabrea e ai suoi bersaglieri, era l’unica scritta in piemontese della Colonia. Forse dell’intera Africa. Ed era sempre una bella soddisfazione quando ci passava davanti in compagnia del suo collega di Sorrento – lui sì che era un vero napuli – e partivano le solite prese in giro.
Quel giorno, però, nell’abitacolo del Ceirano 47, era solo. E mancava ancora un bel po’ di strada per Ailet e Gumhod, meta finale del viaggio. Dopo aver scalato e innestato la ridotta per affrontare un tornante più ripido degli altri, l’autista diede un’occhiata dietro di sé, cercando di controllare il carico sistemato nel cassone dell’autocarro. Era protetto da un telone cerato, perché man mano che si sale sull’altopiano il rischio di un acquazzone improvviso è sempre più concreto. Non come a Massaua, dove piove pochissimo. E anche quando Giove Pluvio apre le cateratte e l’acqua viene giù a secchiate, dopo un quarto d’ora c’è già di nuovo il sole. E fa più caldo di prima.
Al solo pensiero della canicola, là sulla costa, gli venne di nuovo sete. Prese la borraccia mezza vuota e buttò giù una sorsata d’acqua tiepida. Era freschissima quando l’aveva presa a una piccola sorgente del passo di Hancar, ma nel giro di mezz’ora si era già trasformata in piscio di gatto.
«Pazienza», pensò l’autista. «Appena arrivo ad Ailet mi faccio una bella birra gelata.» Intorno a lui il paesaggio era cambiato in fretta. Le collinette brulle, ricoperte da pietre e rovi spinosi, stavano lasciando posto ai primi boschi di sicomori e tamarindi, ed era facile notare intere famiglie di babbuini e cercopitechi che giocavano appesi ai rami degli alberi, lanciando urla sguaiate al passaggio del camion. La pista era deserta e la macchia sempre più fitta. Il camion avanzava piano, sia per la pendenza sia per il fondo sconnesso.
«Davvero un bel posto per un agguato», pensò ancora il conducente.
Da alcuni mesi le autorità della Colonia avevano registrato una preoccupante impennata di rapine ai danni degli autocarri che facevano la spola fra Massaua e Asmara. Non tanto sulla strada principale, battuta con frequenza dalle pattuglie dei Carabinieri e dai convogli militari, che andavano ad ammassarsi verso il confine con l’Abissinia, quanto piuttosto sulle piccole piste secondarie, dove i camionisti dovevano passare per forza per rifornire i villaggi più isolati e le guarnigioni distaccate sull’altopiano.
Si trattava di banditi, naturalmente. Nelle zone più impervie dell’Eritrea c’erano sempre state sacche in cui l’autorità italiana stentava ad affermarsi ed era lì che proliferavano i briganti. Per non parlare delle zone desertiche della Dancalia, dove ancora nella tarda estate del 1935, alla vigilia della guerra, poteva capitare che persino una pattuglia militare venisse assaltata dai terribili predoni Afàr. Ma quella era un’area praticamente disabitata e priva d’insediamenti coloniali, tanto pericolosa e inospitale che persino gli eritrei la scansavano come il demonio.
La presenza di bande criminali sull’altopiano, invece, destava una certa apprensione. E non solo perché in più d’un caso c’era scappato il morto. Nei palazzi governativi di Asmara si temeva che dietro all’aumento delle imboscate si celasse la longa manus del regime del Negus Hailé Selassié, l’imperatore dell’Etiopia. Il nemico giurato dell’espansione italiana in Africa Orientale. L’erede di quel Menelik che quarant’anni prima aveva infranto i sogni di gloria coloniale e inflitto al nostro esercito la più cocente delle sconfitte: Adua.
Il sospetto che a istigare i briganti fossero gli agenti abissini aveva trovato conferma un paio di mesi prima, quando un plotone di esploratori alpini della Divisione Pusteria, in marcia verso Axum, si era imbattuto per caso, su una pista secondaria, in una banda di predoni. Il conflitto a fuoco era stato breve ma intenso, e una mezza dozzina di banditi era rimasta per terra. Con grande sorpresa, gli alpini avevano scoperto che alcuni di loro erano armati con moderni fucili di produzione europea, svedese e belga. Gli stessi in dotazione alle forze armate imperiali abissine. Molto più di una coincidenza.
A questo pensava il conducente del Ceirano 47 mentre sobbalzava sul sedile poco molleggiato dell’autocarro, attento a evitare le buche più profonde. Cattivi pensieri, non c’è dubbio. Ma a ogni scossone sentiva la Beretta urtare contro il cassetto del cruscotto e quel tonfo sordo gli dava un po’ di sicurezza.
Il sole era ancora alto, ma già l’aria dell’altopiano s’infilava dai finestrini aperti e rinfrescava l’abitacolo del camion.
«Magari mi preoccupo inutilmente», ragionò l’autista. «In fin dei conti, è da una settimana che vado avanti e indrè su questa maledetta pista e non è mai successo nulla.»
Affrontò disinvolto l’ennesima curva, ma quando vide l’albero di traverso sulla carreggiata capì subito quel che sarebbe successo. Tirò il freno a mano, spense il motore e, osservando con la coda dell’occhio i primi briganti che venivano giù dal costone della montagna, tolse la sicura alla Beretta.
«Adess a ’s divertuma…»




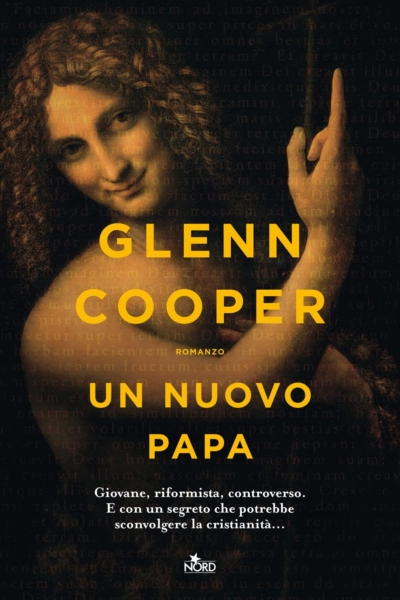
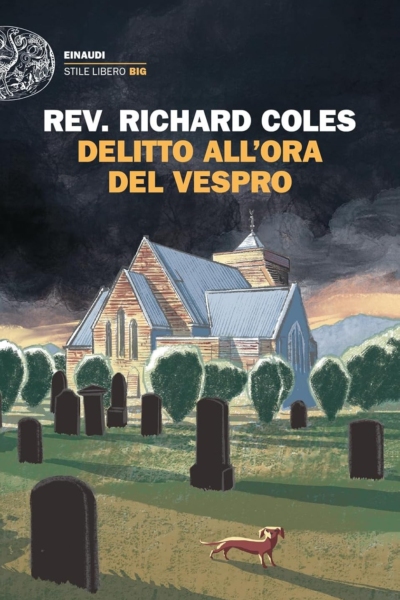

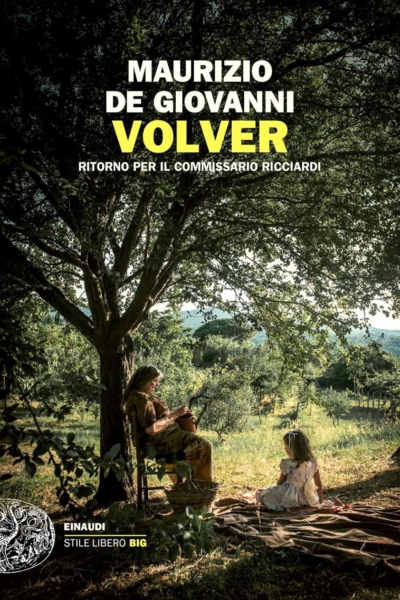

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.