Descrizione
PRIMA PARTE
LA SCOMMESSA
1.
Di tutte le stanze, i corridoi e i luoghi simbolo che costituiscono il complesso della Casa Bianca e dei suoi giardini, il punto che amavo di più era il Portico della West Wing.
Per otto anni, quel passaggio – un tragitto di un minuto all’aria aperta dalla residenza all’ufficio e viceversa – ha incorniciato le mie giornate. Era lì che al mattino sentivo il primo schiaffo del vento invernale o il palpito della calura estiva; era lì che raccoglievo le idee prima di ogni incontro in agenda, elaborando gli argomenti da presentare ai membri più scettici del Congresso o agli elettori impazienti, e preparandomi mentalmente a una decisione da prendere o agli sviluppi di una crisi annosa.
Nei primi anni di vita della Casa Bianca, gli uffici e la residenza della famiglia presidenziale si trovavano sotto lo stesso tetto, e il Portico della West Wing era poco più di un sentiero che conduceva alle scuderie dei cavalli. Fu Teddy Roosevelt, una volta assunto l’incarico, a stabilire che un unico edificio non potesse ospitare uno staff moderno, sei bambini esuberanti e il suo equilibrio mentale. Ordinò quindi la costruzione di quelli che sarebbero diventati la West Wing e lo Studio ovale; nei decenni a seguire, con altri presidenti, sarebbe via via emersa l’attuale configurazione del portico, una parentesi che delimita il Giardino delle rose a nord e a ovest: il muro spesso sul lato settentrionale, silenzioso e spoglio se non per le alte finestre a mezzaluna, e sul lato occidentale le maestose colonne bianche che si susseguono come un picchetto d’onore a protezione del passaggio.
In genere sono uno che cammina piano – con passo hawaiano, come ripete Michelle, talvolta non senza un pizzico d’impazienza. Lungo quel portico, però, consapevole com’ero della storia che vi era stata scritta e di quanti mi avevano preceduto, adottavo un’andatura differente. La falcata era più ampia, l’incedere più spiccio, mentre a ogni mio passo sulla pietra facevano eco, a distanza di qualche metro, quelli della scorta dei Servizi segreti. Non appena raggiungevo lo scivolo sull’estremità occidentale del portico, un lascito di Franklin Delano Roosevelt – lo immagino sorridere mentre, il mento in fuori, il bocchino stretto tra i denti, cerca di risalire la china armeggiando sulla sedia a rotelle –, rivolgevo un cenno alla guardia in uniforme subito al di là della porta a vetri. A volte la guardia doveva contenere una frotta di visitatori colti di sorpresa. Se ne avevo il tempo, scambiavo qualche stretta di mano e chiedevo loro da dove venissero. Di solito, però, a quel punto giravo a sinistra, seguendo il muro esterno della Sala del gabinetto, e poi m’infilavo nell’ingresso secondario accanto allo Studio ovale. Quindi salutavo il mio staff, afferravo il programma degli impegni e una tazza di tè bollente e cominciavo a dedicarmi alle questioni del giorno.
Diverse volte a settimana, uscendo sul portico mi imbattevo negli addetti alla manutenzione del parco – tutti dipendenti del National Park Service –, intenti a curare il Giardino delle rose. Erano uomini anziani, perlopiù, con l’uniforme verde e cachi cui talvolta abbinavano un cappello floscio per proteggersi dal sole o un voluminoso giaccone per resistere al gelo. Se non ero in ritardo, capitava che mi fermassi a complimentarmi per le nuove piante o a chiedere dei danni prodotti dal temporale della notte prima, per poi ascoltarli mentre mi parlavano del loro lavoro con pacato orgoglio. Erano uomini di poche parole; anche tra di loro erano soliti spiegarsi con un gesto o un cenno del capo, muovendosi con grazia sincronizzata pur essendo concentrati ciascuno sul proprio compito individuale. Uno dei più anziani, Ed Thomas, era un nero alto e asciutto, con le guance incavate; lavorava alla Casa Bianca ormai da quarant’anni. Il giorno in cui l’ho conosciuto, prima di stringermi la mano ha recuperato una pezza dalla tasca posteriore per ripulirsi dal terriccio. La sua mano, fitta di venature e nodosa come le radici di un albero, ha inghiottito la mia. Gli ho chiesto quanto tempo intendesse rimanere ancora alla Casa Bianca prima di mettersi in pensione.
«Non lo so, signor presidente», ha risposto. «Lavorare mi piace. Ho le articolazioni un po’ arrugginite, ma immagino di restare fino a quando rimarrà lei. Per assicurarmi che i giardini siano sempre belli.»
E altroché se erano belli, i giardini! Le magnolie ombrose che svettavano a ogni angolo; le siepi folte, di un verde intenso; i meli selvatici potati alla perfezione. E i fiori, coltivati in serra a qualche chilometro da lì, perpetuavano un’esplosione costante di colore: una varietà di sfumature di rosso e giallo e rosa e viola. In primavera, sbocciavano le aiuole di tulipani con le corolle inclinate verso il sole; d’estate era il turno di eliotropi color lavanda, gerani e gigli; in autunno, crisantemi, margherite e fiori di campo. E non mancava mai qualche rosa, in genere rossa, più di rado anche gialla o bianca, ma sempre in piena fioritura.
Ogni volta che percorrevo il portico o che guardavo dalla finestra dello Studio ovale, vedevo il frutto del lavoro di quegli uomini, di quelle donne. Mi ricordavano il piccolo dipinto di Norman Rockwell che tenevo alla parete, accanto al ritratto di George Washington e sopra il busto di Martin Luther King: cinque minuscole sagome con la pelle di diverso colore, operai in calzoni di tela appesi a funi per lucidare la lampada della Statua della libertà sullo sfondo dell’azzurro terso del cielo. Così come gli uomini del dipinto, pensavo, anche gli inservienti del giardino erano guardiani: i silenziosi sacerdoti dell’ordine delle cose, un ordine giusto e solenne. E mi dicevo che avrei dovuto compiere il mio lavoro con la stessa cura e lo stesso impegno che quella gente metteva nel proprio.
Col tempo, le mie passeggiate lungo il portico si sono caricate di ricordi. C’erano i grossi eventi pubblici, certo – gli annunci fatti davanti a una falange di videocamere, le conferenze stampa con leader stranieri –, ma anche gli istanti riservati a pochi: Malia e Sasha che facevano a gara per venirmi a salutare il pomeriggio durante una visita inattesa, o i nostri cani, Bo e Sunny, che saltellavano sulla neve, sprofondando a tal punto da riaffiorare poi con una sorta di barbetta bianca. Quattro lanci col pallone da football in una radiosa giornata autunnale, un collaboratore a cui prestare conforto in un momento di difficoltà personale.
Spesso, queste immagini mi balenavano in testa, interrompendo qualsiasi riflessione. Mi ricordavano il passare dei giorni, colmandomi talvolta di un sentimento nostalgico, il desiderio di riportare indietro le lancette e ricominciare. Cosa che non era possibile durante la passeggiata mattutina. La freccia del tempo, allora, puntava solo in avanti: verso il lavoro da fare. Non c’era altro orizzonte.
La sera, invece, era diverso. Di ritorno alla residenza, con la valigetta piena di documenti, mi costringevo a rallentare e certe volte mi fermavo a respirare l’aria intrisa del profumo di terra e di erba e di polline, e ad ascoltare il vento o il ticchettio della pioggia. Certe volte indugiavo ad ammirare la luce riflessa sul colonnato e l’imponenza regale della Casa Bianca, con la bandiera illuminata sul tetto, o volgevo lo sguardo verso il Monumento a Washington che, in lontananza, fendeva il cielo nero nel quale, di tanto in tanto, scorgevo la luna e le stelle o le luci intermittenti di un aereo in volo. In momenti come quelli mi sembrava di rivedere, non senza meraviglia, l’inconsueto percorso e l’idea stessa che mi avevano portato fin lì.
Non provengo da una famiglia di politici. I miei nonni materni, di sangue perlopiù scozzese e irlandese, erano originari del Midwest. Li si poteva considerare progressisti – soprattutto per gli standard dell’epoca della Grande depressione in un contesto come quello delle cittadine del Kansas in cui erano nati –, anche per la solerzia nel tenersi aggiornati. «Informarsi è compito di ogni buon cittadino», mi diceva la nonna, che tutti chiamavamo Toot, usando la forma abbreviata per Tutu (che in lingua hawaiana significa appunto «nonna»), sbirciandomi da sopra le pagine del suo «Honolulu Advertiser». Tuttavia, lei e il nonno non avevano salde inclinazioni ideologiche o partitiche, al di là di quello che consideravano semplice buonsenso. Pensavano a lavorare – la nonna era vicepresidente della Sezione fondi e depositi di una banca locale, il nonno vendeva assicurazioni sulla vita – e a pagare le bollette e ai piccoli diversivi offerti dalla vita quotidiana.
E comunque vivevano sull’isola di Oahu, dove nulla sembrava così urgente. Dopo anni trascorsi ai quattro angoli del Paese, in luoghi come l’Oklahoma, il Texas e lo Stato di Washington, si erano stabiliti alle Hawaii nel 1960, un anno dopo che l’arcipelago era diventato il cinquantesimo Stato dell’Unione. Adesso, a separarli da disordini, proteste e altri eventi di questo tipo c’era la vastità dell’oceano. L’unica conversazione a tema politico che ricordo di aver sentito tra loro quand’ero ragazzino riguardava un bar sulla spiaggia: il sindaco di Honolulu aveva fatto demolire la bettola preferita del nonno per rinnovare il lungomare nella zona periferica di Waikiki.
E il nonno non glielo perdonò mai.
Mia madre, Ann Dunham, era diversa e molto decisa nelle sue opinioni. Figlia unica, alle scuole superiori si ribellò alle convenzioni: leggeva i poeti beat e gli esistenzialisti francesi, una volta andò in giro per giorni in auto con una persona amica, senza dirlo a nessuno, arrivando fino a San Francisco. Da piccolo la sentivo parlare di marce per i diritti civili e della guerra in Vietnam come di una scelta disastrosa; di movimenti femministi (sì alla parità dei salari; per il resto, non è che fosse contraria a depilarsi le gambe) e di lotta alla povertà. Quando ci trasferimmo in Indonesia per vivere con il mio patrigno, non perdeva occasione di spiegarmi i mali della corruzione governativa («In poche parole, Barry, significa rubare») anche in un ambiente in cui tutti sembravano approfittarne. In seguito, nell’estate in cui compii dodici anni, durante un mese di vacanza trascorso girando insieme gli Stati Uniti, insistette perché ogni sera guardassimo in TV le udienze del Watergate, che commentava puntualmente in diretta («Che cosa ti aspettavi da un maccartista?»).
Non si concentrava solo sulle notizie da prima pagina. Una volta, quando venne a sapere che insieme ad altri compagni di scuola prendevo di mira un ragazzino, mi fece sedere di fronte a sé, stringendo le labbra per il disappunto.
«Sai, Barry» (era il diminutivo con cui mi chiamavano lei e i nonni, in quegli anni; spesso veniva accorciato in «Bar», pronunciato come «Bear», orso), disse, «al mondo c’è gente che pensa solo a sé. A queste persone non importa di cosa accade agli altri, fintanto che loro ottengono quello che vogliono. Buttano giù il prossimo perché questo le fa sentire importanti.
«Poi ci sono quelli che fanno il contrario, perché riescono a immaginare come debbano sentirsi gli altri e, di conseguenza, stanno attenti a non fare niente che possa ferirli.
«Allora», disse infine, guardandomi fisso negli occhi. «Che tipo di persona vuoi essere?»
Mi sentii uno schifo. Com’era nei suoi intenti, quella domanda rimase con me per molto tempo.
Per mia madre, il mondo era una continua opportunità di insegnamenti morali. Tuttavia, non era tipo da lasciarsi coinvolgere in campagne politiche. Come i miei nonni, diffidava di programmi, dottrine e principi assoluti e preferiva esprimere i propri valori in una cornice più contenuta. «Il mondo è complicato, Bar. Ed è questo a renderlo interessante.» Costernata dalla guerra nel Sud-est asiatico, finì per trascorrere lì gran parte della sua vita, assorbendone la lingua e la cultura, e organizzando programmi di microcredito per le persone in stato di povertà molto prima che la pratica diventasse di moda nel quadro dello sviluppo internazionale. Inorridita dal razzismo, contrasse non uno ma due matrimoni interrazziali, riversando quello che sembrava un amore inesauribile sui suoi due figli dalla pelle scura. Insofferente alle costrizioni imposte alle donne dalla società, divorziò da entrambi i mariti nel momento in cui si rivelarono dispotici o deludenti, per ritagliarsi la carriera che aveva scelto, crescere i figli secondo i propri dettami morali e fare più o meno come diavolo voleva.
Nel mondo di mia madre, il privato era davvero politico, anche se di quello slogan non avrebbe saputo che farne.
Nulla di tutto questo vuol dire che non nutrisse ambizioni riguardo a suo figlio, anzi. Nonostante le difficoltà finanziarie, lei e i nonni mi mandarono alla Punahou, la scuola secondaria privata più prestigiosa delle Hawaii. L’idea che io non andassi all’università non fu mai presa in considerazione. Ma nessuno dei miei famigliari avrebbe mai pensato che un giorno potessi ricoprire una carica pubblica. Se aveste chiesto a mia madre, probabilmente avrebbe detto che mi immaginava alla guida di un’istituzione filantropica come la Ford Foundation. Ai miei nonni sarebbe piaciuto vedermi con addosso la toga da giudice o come un avvocato alla Perry Mason.
«Così potrebbe mettere a frutto quella sua lingua affilata», diceva il nonno.
Mio padre non ebbe una grande influenza, visto che nemmeno lo conoscevo. Sapevo vagamente che per un certo lasso di tempo aveva lavorato per il governo keniano e in un’occasione, quando avevo dieci anni, venne dal Kenya per trascorrere un mese da noi, a Honolulu. Quella fu la prima e l’ultima volta che lo vidi; da allora in avanti, seppi di lui solo dalle sue sporadiche lettere, scritte su un foglio sottile di carta azzurra per la posta aerea, di quelli prestampati per essere piegati e spediti senza busta. «Tua madre mi dice che stai pensando di studiare architettura», recitava una di queste. «È una professione pratica, e può essere esercitata in qualsiasi parte del mondo.»
Non c’erano molti appigli per proseguire.
Fuori dalla cerchia famigliare, be’, quello che si sarebbe visto per quasi tutti gli anni della mia adolescenza non era un leader in erba quanto, piuttosto, uno studente svogliato, un appassionato giocatore di pallacanestro dal talento limitato e un instancabile, convinto festaiolo. Niente consigli studenteschi, né boy scout o tirocini presso l’ufficio del parlamentare locale. Alle scuole superiori, i discorsi con gli amici non andavano molto oltre lo sport, le ragazze, la musica e lo sballo.
Tre di loro – Bobby Titcomb, Greg Orme e Mike Ramos – sono tuttora tra i miei amici più intimi. Ancora oggi, siamo capaci di ridere per ore rievocando le storie della nostra gioventù bruciata. Negli anni a venire, avrebbero preso parte tutti e tre alle mie campagne con una lealtà della quale sarò loro grato per sempre: mi hanno difeso da ogni accusa come neanche i giornalisti del canale televisivo MSNBC.
Ma in certi altri momenti, nel corso della mia presidenza – magari dopo avermi visto parlare davanti a una folla oceanica, o ricevere i saluti briosi da parte di giovani Marines durante la visita a una base –, il loro volto avrebbe tradito una certa perplessità, mentre cercavano di conciliare l’uomo brizzolato in giacca e cravatta con il bamboccione informe di un tempo.
Ma è proprio lui?, sembravano dirsi in quei casi. Come diavolo è potuto succedere?
Se l’avessero chiesto direttamente a me, non sono sicuro che avrei avuto una risposta soddisfacente da dare.
So che talvolta, ai tempi delle superiori, iniziavo a fare domande: sull’assenza di mio padre e sulle scelte di mia madre; su come mai mi fossi ritrovato a vivere in un posto dove solo in pochi avevano il mio aspetto. Un sacco di domande avevano a che vedere con la razza: perché i neri giocavano nel basket professionistico ma non allenavano? Che cosa intendeva quella compagna di scuola quando diceva di non considerarmi un nero? Perché nei film i neri erano tutti degli squilibrati sempre pronti a brandire il coltello a serramanico, a eccezione dell’unico rispettabile – il comprimario, guarda caso – che però finiva immancabilmente per farsi ammazzare?
Ma la questione della razza non era la mia unica preoccupazione. Era anche una questione di classe. Essendo cresciuto in Indonesia, avevo ben presente l’abisso tra le condizioni di vita delle élite benestanti e quelle delle masse impoverite, e nutrivo la nascente consapevolezza delle tensioni tribali che scuotevano il Paese di mio padre, di tutto l’odio che divideva quanti, in superficie, potevano sembrare uguali. Io stesso ero giorno per giorno testimone dell’esistenza apparentemente angusta dei miei nonni, delle amarezze che affrontavano a forza di TV e di alcolici, o acquistando di tanto in tanto un elettrodomestico o un’auto nuova. Mia madre scontava la propria libertà intellettuale con il cronico ripresentarsi di problemi finanziari e, a più riprese, con un po’ di caos sul piano personale, e io mi ero adattato alle gerarchie non così velate tra i miei compagni di classe, gerarchie che in larga parte dipendevano da quanti soldi avevano i rispettivi genitori. E poi c’era il fatto sconcertante per cui, a dispetto dei proclami di mia madre, i prepotenti, i truffatori e quelli che si autoincensavano sembravano cavarsela piuttosto bene, mentre quelle che lei considerava persone oneste e rispettabili di solito rimediavano un sacco di fregature.
Tutto questo mi sballottava in direzioni contrastanti. Era come se, proprio per l’estrema singolarità del mio retaggio, per i diversi mondi tra cui stavo a cavallo, avessi radici ovunque e in nessun luogo, quasi fossi una combinazione di parti che mal si adattavano tra loro, come un ornitorinco o una sorta di animale fantastico: confinato in un fragile habitat, non sapevo quale fosse il mio posto. E sentivo, senza comprendere appieno come e perché, che se non fossi riuscito a rimettere insieme la mia vita e a collocarmi su un asse ben saldo, mi sarei ritrovato a vivere essenzialmente in solitudine.
Ma era qualcosa di cui non parlavo con nessuno, men che meno con gli amici o i famigliari. Non volevo ferire i loro sentimenti o distinguermi più di quanto non facessi già. Così trovai rifugio nei libri. Mia madre, d’altronde, mi aveva instillato l’abitudine alla lettura sin da bambino: era la sua mossa vincente ogniqualvolta mi vedesse annoiato o quando, in Indonesia, non poteva permettersi di mandarmi in una scuola internazionale o, ancora, nelle occasioni in cui dovevo accompagnarla in ufficio perché non aveva una babysitter.
Leggiti un bel libro, mi diceva, e poi raccontami che cosa hai imparato.
Per un paio di anni rimasi con i nonni alle Hawaii mentre mia madre, in Indonesia, continuava a lavorare e a occuparsi di Maya, la mia sorellina. Senza il suo assillo costante non imparavo poi così tanto, come attestavano puntualmente i miei voti. Poi, intorno al secondo anno delle superiori, le cose cambiarono. Ricordo ancora la volta in cui, al mercatino dell’usato presso la Central Union Church dove ero andato con i nonni, sul lato opposto della strada rispetto al nostro appartamento, mi ritrovai di fronte a una cesta piena di vecchi volumi rilegati. Per qualche ragione, cominciai a tirar fuori quelli con i titoli che mi piacevano o che mi suonavano vagamente familiari, libri di Ralph Ellison e Langston Hughes, Robert Penn Warren e Fëdor Dostoevskij, D.H. Lawrence e Ralph Waldo Emerson. Quando mi vide arrivare con la mia scatola di libri, il nonno, che nel frattempo stava adocchiando un set di mazze da golf usate, mi guardò con aria perplessa.
«Hai intenzione di aprire una biblioteca?»
Fu subito zittito dalla nonna, che invece trovava ammirevole il mio improvviso interesse per la letteratura. Da donna concreta qual era, tuttavia, mi suggerì di concentrarmi sui compiti di scuola, prima di lasciarmi assorbire da Delitto e castigo.
Alla fine li lessi tutti, quei libri, a volte anche di sera tardi, di ritorno da un allenamento di basket o da una birra con gli amici, oppure la domenica pomeriggio dopo aver fatto bodysurf, seduto da solo nella vecchia, traballante Ford Granada del nonno, con un asciugamano intorno alla vita per non bagnargli il sedile. Finita la prima infornata di libri, cominciai a girare altri mercatini per procurarmene di nuovi. Riuscivo a comprendere solo confusamente molte delle cose che leggevo; presi l’abitudine di cerchiare i termini sconosciuti per cercarli sul dizionario, benché fossi meno scrupoloso nel decifrarne le pronunce: a vent’anni suonati, conoscevo il significato di parole che non ero in grado di pronunciare. Non avevo alcun metodo. Nessun percorso specifico, nessuna direzione particolare. Ero un po’ come un giovane inventore che, nel garage di casa, mette insieme vecchi tubi catodici, bulloni e cavi penzolanti: non avevo un’idea precisa di cosa fare di quel materiale, ma ero sicuro che sarebbe tornato utile una volta che avessi capito la natura della mia vocazione.


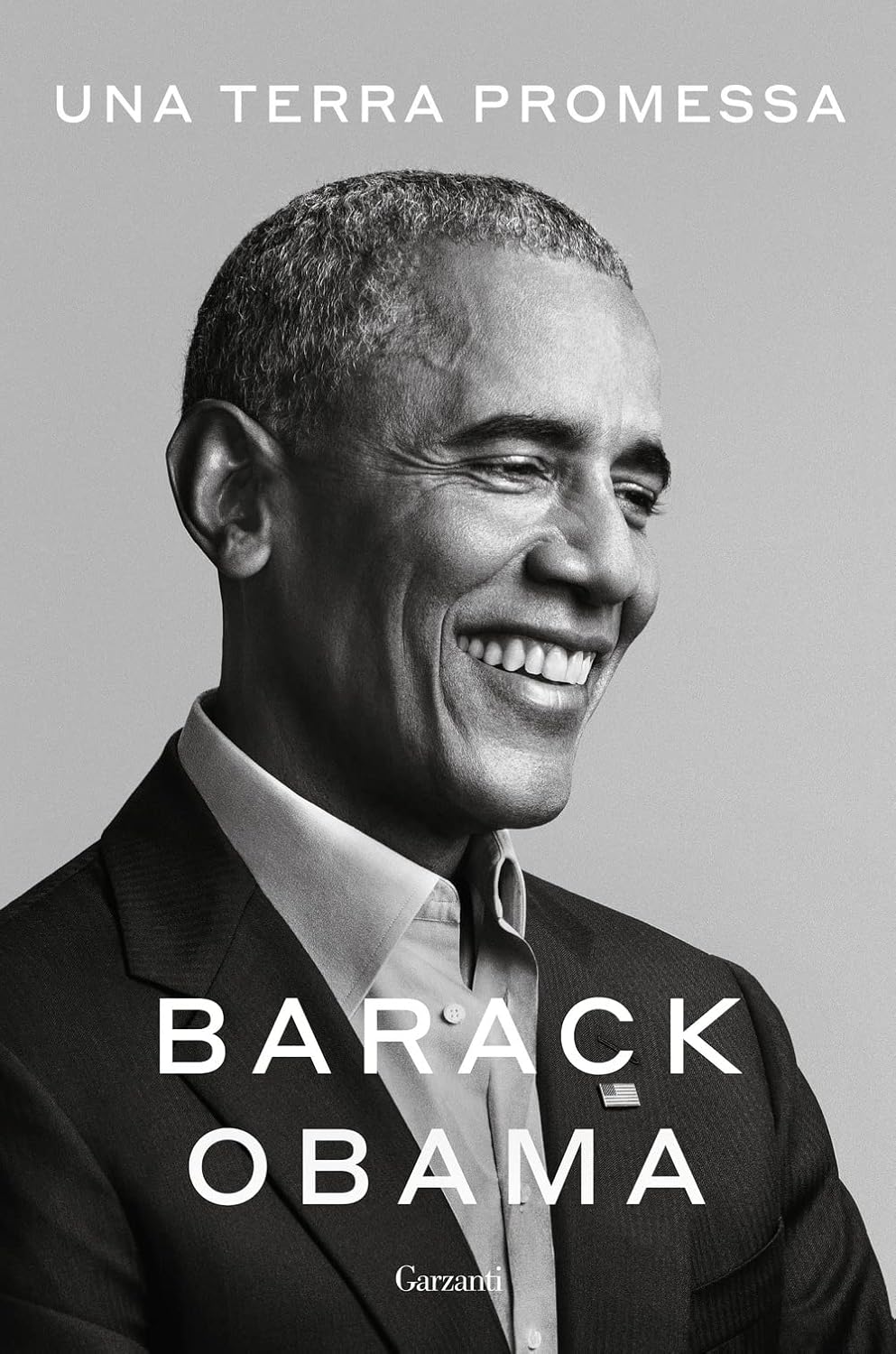

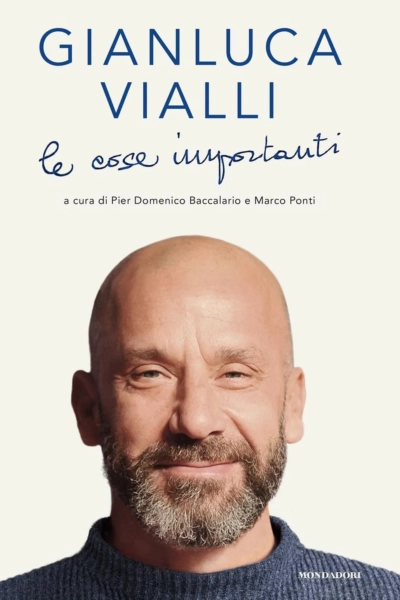



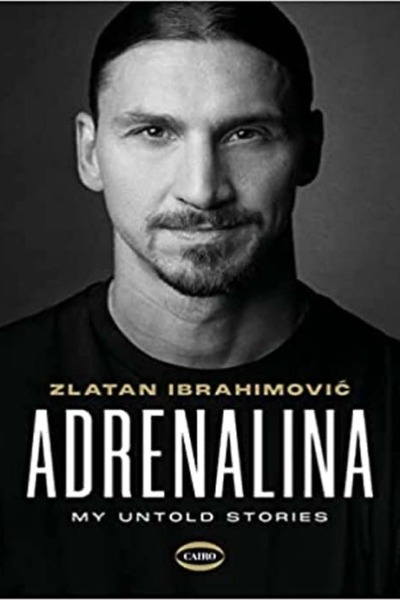
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.